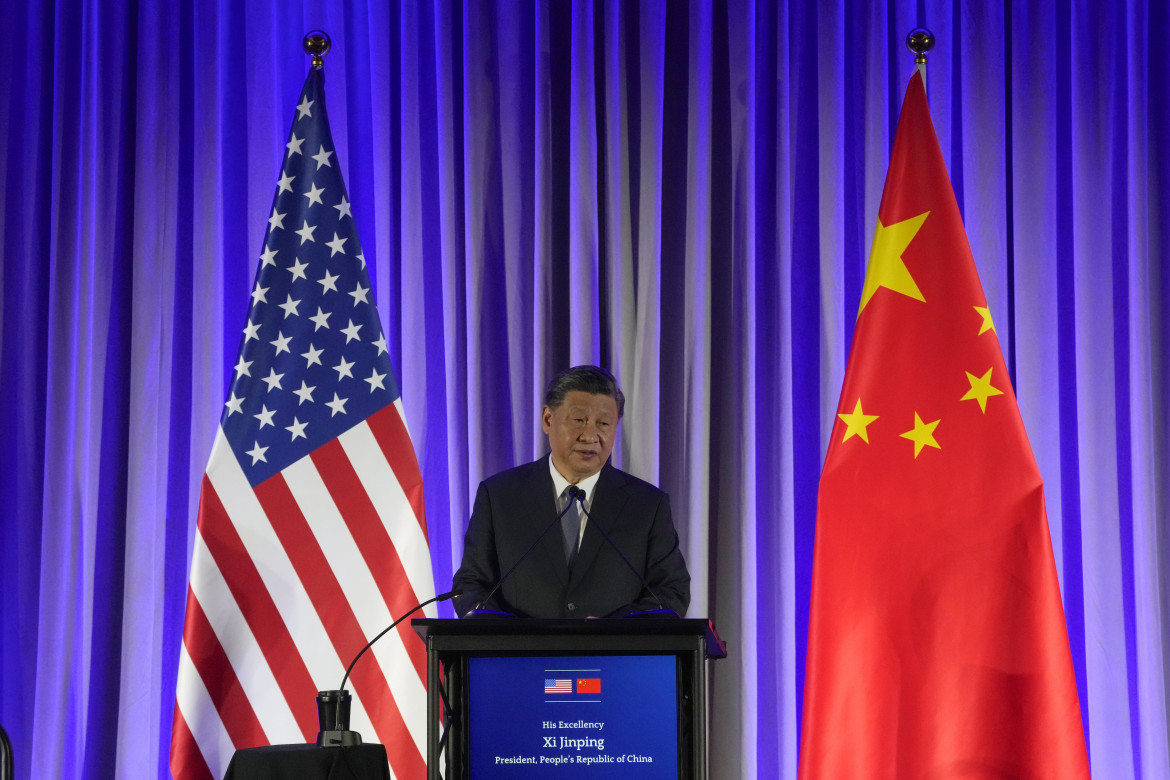Operai cinesi prigionieri in fabbrica per salvare la produzione
Cina Il sistema del "circuito chiuso": lavoratori costretti in bolle anti-Covid, turni massacranti e notti in tende e sui cartoni, senza contatti con l'esterno. Non solo la Tesla, hanno aderito 4mila aziende
 Un'operaia in una fabbrica nel distretto di Funan – Ap
Un'operaia in una fabbrica nel distretto di Funan – ApCina Il sistema del "circuito chiuso": lavoratori costretti in bolle anti-Covid, turni massacranti e notti in tende e sui cartoni, senza contatti con l'esterno. Non solo la Tesla, hanno aderito 4mila aziende
In Cina la fabbrica-dormitorio è un modello già consolidato in siti produttivi come la famigerata Foxconn – nota per il suo sistema di disciplinamento severo, oltre che per l’ondata di suicidi a cui la stampa internazionale ha dedicato numerosi approfondimenti – e non solo.
Ma di recente gli operai hanno sofferto anche l’applicazione del cosiddetto sistema «a circuito chiuso», nel rispetto della ormai nota strategia nazionale «Zero Covid»: il modo più efficace, secondo le autorità della città di Shanghai, per riprendere la produzione e limitare i danni sul fronte economico.
I dati ufficiali forniscono un quadro sorprendente: a metà maggio quasi 4.500 siti produttivi della megalopoli sono riusciti a riaprire i battenti, oltre il 70% delle 1.800 grandi fabbriche e addirittura il 90% se si prendono in considerazione le aziende dei settori “chiave”. Di fatto, lo stabilimento di punta della Tesla nel distretto di Lingang, Gigafactory 3, ha riavviato la produzione dopo circa tre settimane di stallo.
A metà aprile i lavoratori sono stati convogliati nello stabilimento-bolla grazie a degli autobus speciali, dove li attendevano un sacco a pelo, tre pasti al giorno e un’indennità monetaria giornaliera sulla base della carica ricoperta. Per recuperare le 40 mila auto «perse» durante la chiusura, ha riportato Bloomberg, gli operai hanno dovuto rispettare turni di 12 ore, privati di qualsiasi contatto con persone esterne alla bolla, familiari compresi. Sforzi su larga scala che non tutte le fabbriche sono riuscite a sostenere.
Alcune aziende nelle città meridionali di Shenzhen e Dongguan, ha riferito a marzo la piattaforma di Hong Kong Now, si sono perfino rifiutate di pagare il salario minimo nelle settimane di sospensione della produzione. Una somma, tra l’altro, già di molto inferiore al salario medio: a Shanghai, che vanta tra le quote più alte del paese, il salario minimo si attesta sui 3mila yuan al mese, circa 415 euro, a fronte di una retribuzione mensile che supera con facilità i 10mila yuan.
In mancanza di alloggi, molte fabbriche hanno costretto i lavoratori a passare settimane su cartoni ammassati a terra a mo’ di letto, o in tende piantate nelle aree esterne della struttura. Una sorte peggiore è toccata a chi ingrossa le file degli operai «a chiamata», che hanno trascorso le notti sotto i cavalcavia dei distretti cittadini, a far compagnia agli addetti alle consegne. La gigantesca stazione di Hongqiao a Shanghai è stata presa d’assalto tanto da sembrare «un campo profughi», ha commentato un articolo nel sito di approfondimento in lingua cinese The Initium.
A Quanta Computer Inc., società taiwanese che produce i MacBook di Apple, a inizio maggio un nutrito gruppo di operai ha tentato di sfondare le barricate del perimetro dello stabilimento, esasperati da quasi un mese di sistema-bolla. Altri lavoratori, qualche giorno fa, hanno preso d’assalto le strutture che ospitano i manager taiwanesi della società, pare in seguito a una disputa sul prolungamento dell’isolamento.
Se mancano numeri certi che chiariscano la portata delle agitazioni operai, i dati sulle attività del settore manifatturiero nel centro finanziario del paese, invece, non scarseggiano. Le ingenti difficoltà che i siti produttivi affrontano a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento stridono con il quadro roseo che i media nazionali evidenziano, soprattutto a qualche ora dall’allentamento del lockdown. Da sondaggi e indagini è emerso, ad esempio, che nessuna delle fabbriche di proprietà giapponese ha ripristinato i livelli di produzione originari.
Ad aprile Gigafactory 3, capace in tempi luminosi di garantire oltre 2mila Tesla al giorno, ha prodotto poco più di 1.500 automobili. E fonti del media cinese Sina Finance hanno riferito che lo stabilimento potrebbero continuare sulla via del «circuito chiuso» fino alla metà di giugno.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento