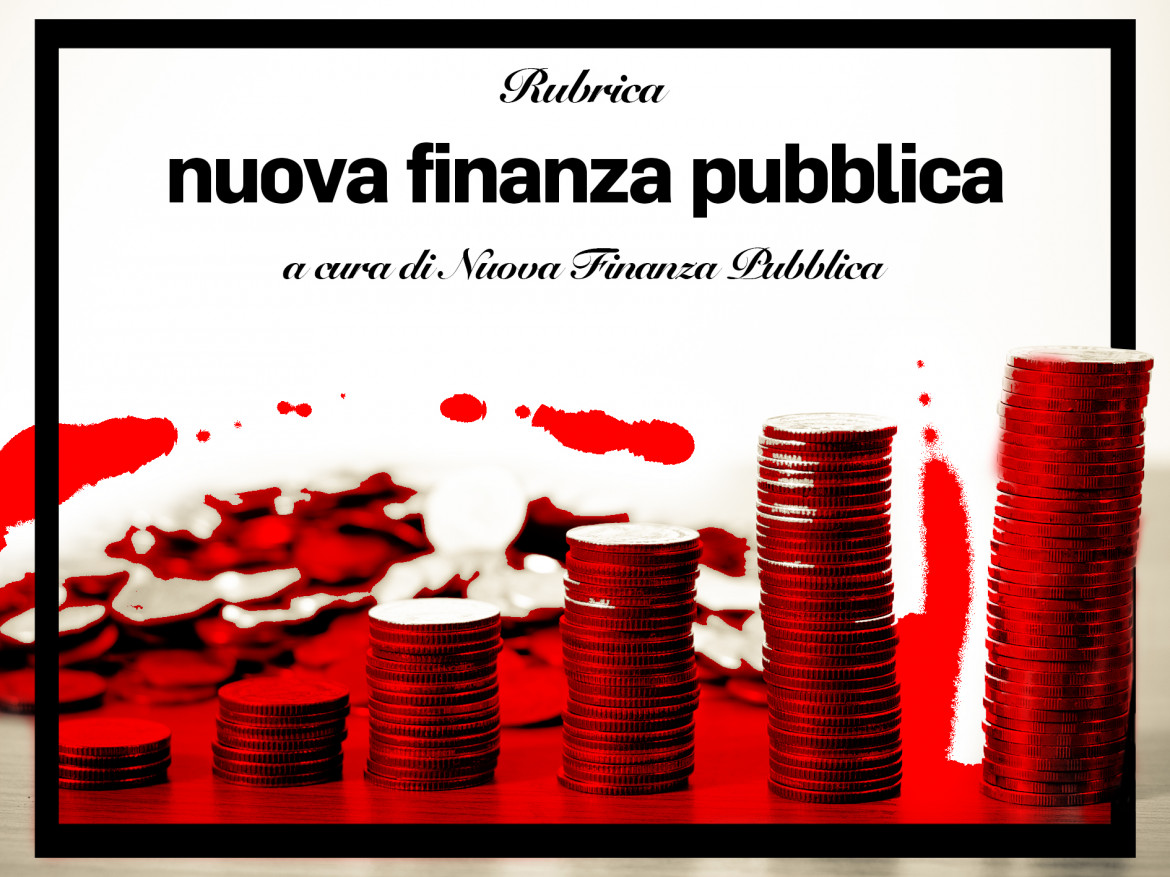
L’economia sovrana tra propaganda e realtà
Come afferma efficacemente un recente editoriale di Jacobin-Italia, il quadro che emerge dalle elezioni europee è in larga parte figlio della crisi del 2007-2009. Le promesse di crescita e benessere della globalizzazione neoliberista sono state disattese e chiunque si sia cimentato con il governo è risultato inefficace su crescita, benessere e crisi climatica. Un contesto che ha alimentato sfiducia nella politica, ben evidenziato dal record di astensionismo.
Lo spostamento a destra nasce in questo contesto di fragilità e incertezza. La retorica di successo securitaria e anti-migranti è in parte compatibile con un quadro economico che invece non sembra nella sostanza modificabile. Ma quanto reggerà il discorso neonazionalista alla prova dei fatti? Che tipo di «economia sovrana» è ipotizzabile per l’Europa? Proviamo a riflettere considerando fattori strutturali.
Gli scenari possono essere potenzialmente due: il primo più probabile, perlomeno nel suo affacciarsi a breve, consiste nell’adattamento della destra al quadro politico economico internazionale con il rafforzamento dell’alleanza Stati Uniti-Europa in chiave anti-cinese (quella che appare la strategia subita e agita dalla Meloni in Italia, realizzata con i conservatori alleati ai popolari), oppure un «liberi tutti» con il riemergere di prospettive più marcatamente nazionali (l’orientamento Salvini-Le Pen per semplificare).
La redazione consiglia:
Ita è di Lufthansa: il sì di Bruxelles figlio delle rinunceEntrambe prospettive fragili e piene di contraddizioni dove a pagare un prezzo elevato potrebbe essere innanzitutto la Germania, paese caratterizzato da un’impresa rivolta all’export su prodotti di qualità medio-elevate e già segnato dalla crisi della globalizzazione e dal ritorno della geopolitica. Gli Stati Uniti riducono le importazioni dalla Cina già da 5 anni e la svolta protezionista sembra strutturale, ma in Europa il quadro sembra molto più incerto.
Le importazioni dalla Cina sono in calo da minor tempo, a causa di una debolezza nelle catene di fornitura che rende più complesso riportare a casa produzioni anche strategiche. Gli Usa non possono fare a meno completamente di un’economia internazionale (troppo a fondo sono andati i meccanismi della globalizzazione per annullarli) e, dunque, stanno provando a torcere il progetto europeo in direzione di rinsaldare un’alleanza atlantica anche sul piano economico.
L’Italia potrebbe fornire prodotti industriali a prezzi contenuti puntando sul lungo inverno salariale, sostituendo, almeno in parte, la Cina nelle importazioni di Washington. La Germania è ancora il paese più esposto verso la Cina per esportazioni e importazioni. Il capitalismo tedesco sarebbe disposto a percorrere questa strada? Significativo come Berlino si sia appena smarcata dalla proposta della Commissione di dazi aggiuntivi per le auto elettriche cinesi. Il rischio per la Germania è quello di una crisi strategica con riflessi importanti su redditi e salari (ma anche sui paesi subfornitori, Italia compresa).
Quanto malcontento si genererebbe nella popolazione tedesca? Una dinamica che potrebbe portare a un ulteriore rafforzamento dell’estrema destra e spingere nella direzione di un nazionalismo anti-europeista, magari alimentato dal crescente revanscismo francese sul piano continentale. Barba Navaretti parla di scivolamento verso un «protezionismo autogenerativo». Ma anche questa strada sembra assai fragile. Un’Europa spaccata in macro-aree sarebbe ancor più debole sul piano geopolitico ed economico. Tanto più considerando l’uso di risorse pubbliche che Cina e Usa impiegano nella contesa globale.
Per il momento a gongolare appare la destra nostrana, unica ad aver superato indenne due anni di governo, che non sembra porsi questo tipo di interrogativi. Ma in questa prospettiva neonazionalista è sufficiente prendersela con la Bce per il ritorno dello spread? Oppure, per fare solo un esempio, il problema del debito inizierà nuovamente a mordere in un’Europa senza visione a rischio implosione?
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




