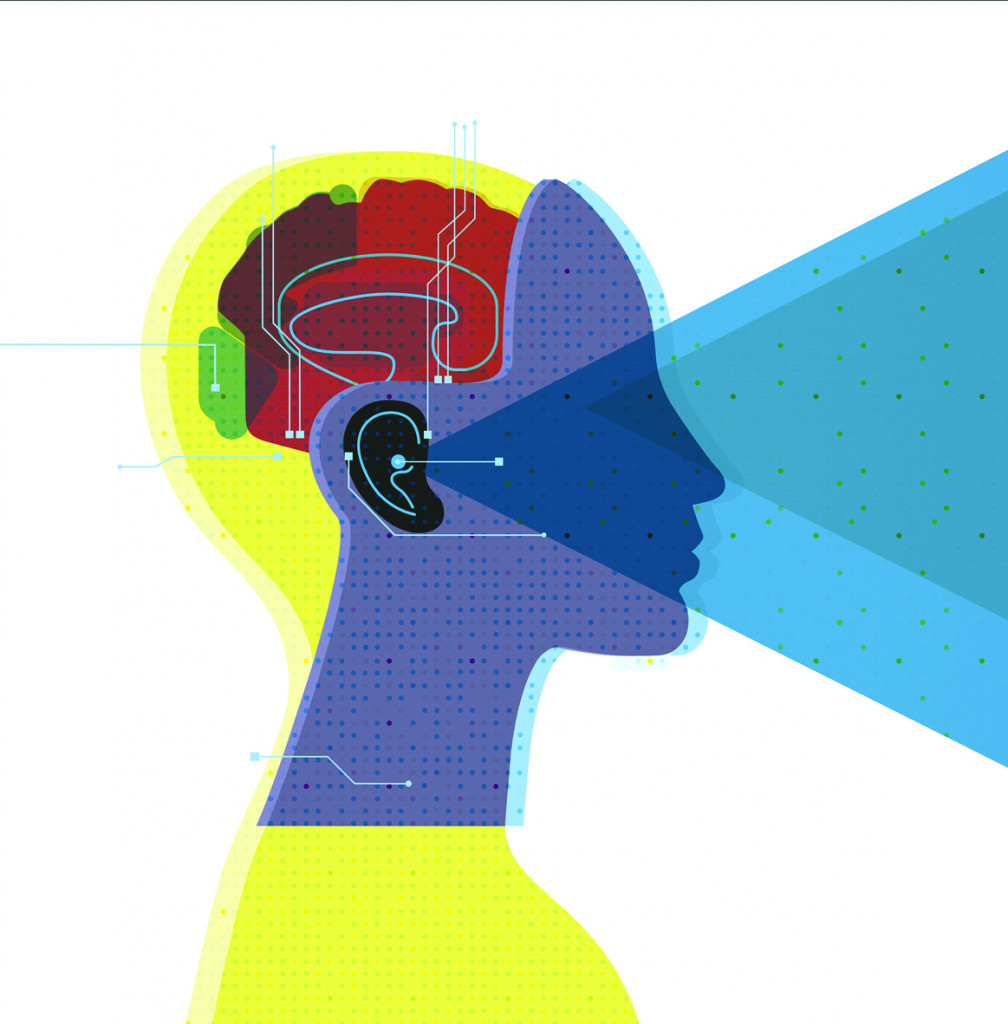Zeruya Shalev, le ferite della memoria generano consapevolezza
Festivaletteratura di Mantova La scrittrice israeliana presenta nell’ambito della kermesse mantovana il nuovo romanzo «Stupore», edito da Feltrinelli. Gli appuntamenti: oggi alle 18 alla Tenda dei libri, domani alle 14,45 a Palazzo San Sebastiano. Atara e Rachel, rispettivamente figlia e ex compagna di Manu si incontrano per la prima volta per parlare dell’uomo scomparso, sarà l’inizio di un viaggio nel passato, tra i ricordi dei combattenti contro gli inglesi prima del 1948, ma anche una reciproca scoperta che saprà far rivivere sentimenti ed affetti
 La scrittrice israeliana Zeruya Shalev – foto Ansa
La scrittrice israeliana Zeruya Shalev – foto AnsaFestivaletteratura di Mantova La scrittrice israeliana presenta nell’ambito della kermesse mantovana il nuovo romanzo «Stupore», edito da Feltrinelli. Gli appuntamenti: oggi alle 18 alla Tenda dei libri, domani alle 14,45 a Palazzo San Sebastiano. Atara e Rachel, rispettivamente figlia e ex compagna di Manu si incontrano per la prima volta per parlare dell’uomo scomparso, sarà l’inizio di un viaggio nel passato, tra i ricordi dei combattenti contro gli inglesi prima del 1948, ma anche una reciproca scoperta che saprà far rivivere sentimenti ed affetti
È un nome ad aver stabilito per sempre un legame tra loro, intrecciando destini lontani ma inquietudini e quesiti che hanno più di un punto in comune. L’una lo porta, quel nome, senza conoscerne l’origine, malgrado si sia interrogata più e più volte sul perché suo padre glielo avesse affibbiato. L’altra sa bene quale ferita racchiuda, quale sconfitta celi in poche lettere, quasi fosse proiettato all’infinito sull’orizzonte perché niente di quanto accaduto possa mai essere dimenticato.
Atara non ha cinquant’anni Rachel quasi cento. Sono loro le protagoniste di Stupore, il nuovo romanzo di Zeruya Shalev, appena pubblicato da Feltrinelli (pp. 320, euro 19, traduzione di Elena Loewenthal) che la scrittrice israeliana presenta al Festivaletteratura di Mantova (oggi alle 18 alla Tenda dei libri, domani alle 14,45 a Palazzo San Sebastiano).
LA PRIMA STA CERCANDO tracce di quel padre, Menachem, «Manu» per gli intimi, cui era stata legata profondamente, ma sempre in modo conflittuale, e che tenta di conoscere davvero solo ora che non c’è più. La seconda era stata sposata per un breve periodo con l’uomo prima che questi incontrasse la madre di Atara.
Ma soprattutto, Rachel era stata una combattente che aveva condiviso con il suo compagno dell’epoca i giorni drammatici della resistenza ebraica contro gli inglesi prima della nascita dello Stato d’Israele nel 1948. Compagni, amanti, complici, Rachel e Manu facevano parte di un’organizzazione clandestina armata, la Lehi, acronimo di Combattenti per la Libertà d’Israele che raccoglieva esponenti dell’estrema destra come dell’estrema sinistra e alcuni dei cui membri avrebbero poi integrato la cosiddetta Banda Stern responsabile anche di azioni terroristiche e sanguinarie.
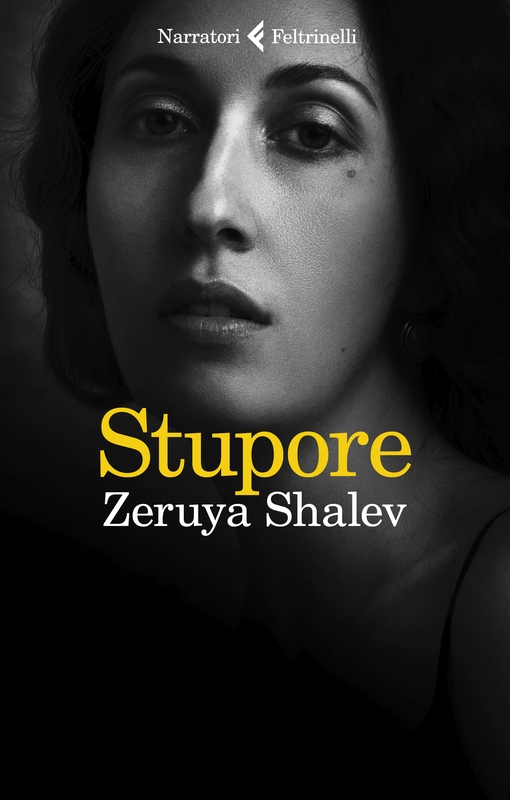
Non potevano sapere, i due, che quella lettera conteneva un messaggio urgente della madre della giovane che malata ne reclamava la presenza accanto a sé: il giorno seguente la corriera su cui viaggiava la ragazza sarebbe stata bersagliata dai colpi dei cecchini arabi che avrebbero fatto diverse vittime, lei compresa. Ben prima di rendersi conto che «il Paese per il quale avevano combattuto era diventato diverso», per Rachel, e soprattutto per Manu, quella vicenda aveva rappresentato una tragica svolta. Un punto di rottura dal quale si erano generate scelte che avrebbero finito per separare anche i loro destini, le loro vite, tracciare un solco in quel loro amore che era stato totale, senza mediazioni possibili.
QUEL NOME, cui sembra legato un destino tragico ma anche quella che a Rachel appare quasi come una drammatica epopea, non solo dei suoi vent’anni, l’idea di cacciare gli inglesi e costruire un nazione di ebrei e arabi, racconta di ferite e di una memoria da riconquistare di fronte alle incertezze del presente, ma evoca anche una consapevolezza nuova, un conoscersi reciprocamente di due donne che si incontrano nel nome dell’amore che seppur in modo molto diverso le ha legate alla stessa persona, Manu.
Nell’incontro, Atara porta i dubbi che la accompagnano quanto al suo legame con un uomo per il quale ha lasciato il marito, ma anche la passione che da architetta le fa prediligere le vecchie abitazioni che sembra sentir respirare, dove scorge i segni del tempo e le traiettorie di chi vi è vissuto, in un Paese come Israele, lamenta, dove si vorrebbe che tutto fosse nuovissimo, moderno, creato dal nulla. Ma per lei è diverso, ha scelto con cura la casa in stile arabo e coloniale alle pendici del Carmelo, la montagna inglobata dallo sviluppo urbano di Haifa, in cui abita e ha preferito questa città «più mista» alla Gerusalemme degli ultrà religiosi. E si chiede, chissà cosa direbbe Manu, il combattente sionista della prima ora, del fatto che la sua migliore amica è Rania, una collega palestinese?
COME ACCADE SPESSO nei romanzi di Zeruya Shalev, una delle protagoniste della letteratura israeliana, nata nel 1959 nel kibbutz Kinneret – tra le sue opere, Una relazione intima (2003), Quel che resta della vita (2013), Dolore (2016) -, anche in Stupore tra le ferite più dolorose sembra di poter scorgere le tracce del germogliare di un nuovo afflato verso l’esistenza. Non c’è perdita, abbandono, trauma pare suggerire Shalev che la consapevolezza di sé, o perlomeno la sua ricerca, non possa tentare di volgere verso l’amore. Sullo fondo, quell’impasto di vicende intime e memoria collettiva che caratterizza tanta parte della narrativa di Israele. E che nel caso di Shalev si traduce anche in implicite citazioni personali: Iris, la protagonista di Dolore è sopravvissuta ad un attentato proprio come accaduto alla scrittrice e i genitori di Shalev facevano parte della Lehi proprio come Manu e Rachel di quest’ultimo romanzo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento