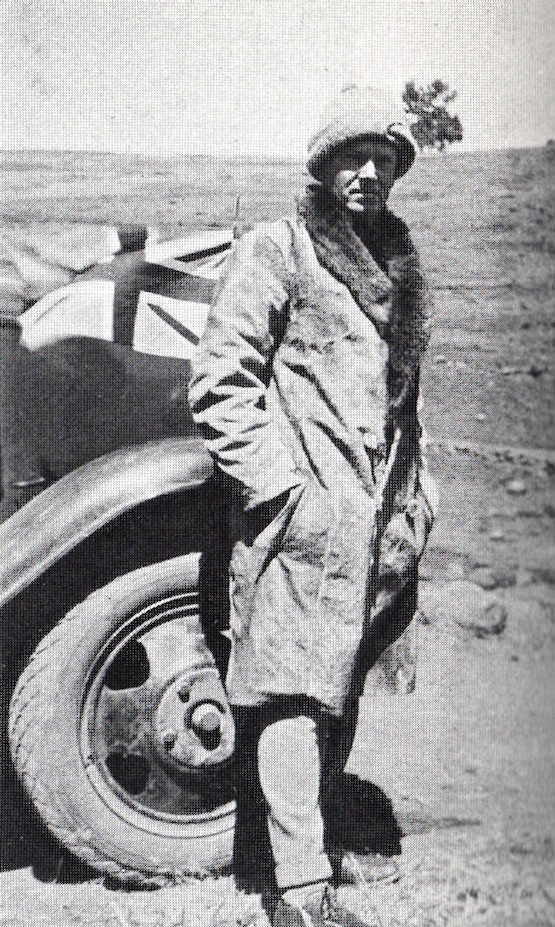Sulle ostili acque di colonia del lago Kivu
Africa Gisenyi e Goma, sorelle da fiaba dei fratelli Grimm, divise dal confine tracciato dagli europei tra Ruanda e Congo, dai fantasmi del genocidio, il coltan e un conflitto non dichiarato
 Il campo profughi di Mugunga, a ovest di Goma, dopo il bombardamento dello scorso 3 maggio, attribuito all’M23 – foto Ap
Il campo profughi di Mugunga, a ovest di Goma, dopo il bombardamento dello scorso 3 maggio, attribuito all’M23 – foto ApAfrica Gisenyi e Goma, sorelle da fiaba dei fratelli Grimm, divise dal confine tracciato dagli europei tra Ruanda e Congo, dai fantasmi del genocidio, il coltan e un conflitto non dichiarato
Quando le nuvole coprono il sole e annunciano pioggia, il lago Kivu assume un colore opalescente e sembra avvolto da una calma quasi irreale. La tranquillità è solo apparente. Il lago, di origine vulcanica, racchiude nel suo ventre enormi quantità di anidride carbonica che potrebbero improvvisamente causare un’eruzione capace di liberare gas tossici e innescare uno tsunami. Le acque sono ostili alla fauna e solo poche specie di pesci ostinati sopravvivono. Ma la minaccia più che dalla natura in questo angolo d’Africa viene dall’uomo.
Il lago Kivu è il confine naturale che separa la Repubblica Democratica del Congo dal Ruanda, due paesi impegnati in un conflitto non dichiarato combattuto per procura e scandito da dichiarazioni sempre più bellicose. A guardare una carta geografica si rimane sbigottiti: è come se il Molise fosse ai ferri corti con la Germania. Le proporzioni dei territori sono quelle. Ma nell’Africa equatoriale i nostri metri di giudizio non valgono. Sulla riva Nord del lago una frontiera divide due città: a ovest la congolese Goma a est la ruandese Gisenyi. Sono due sorelle da fiaba dei fratelli Grimm. Goma ha 700mila abitanti e migliaia di profughi e nel 2002 ha rischiato di essere cancellata dall’eruzione del vulcano Nyiragongo; Gisenyi di abitanti ne ha circa 80mila, è una città placida e quasi elegante, dalla vocazione turistica un po’ appassita e sede del principale birrificio del Ruanda.
LE RIVALITÀ POLITICHE non fermano le circa 20mila persone al giorno coinvolte in traffici transfrontalieri. Hotel, bar e attività produttive di Gisenyi impiegano cittadini congolesi che attraversano il posto di frontiera quotidianamente. I due centri vivono in simbiosi: Goma ha un aeroporto internazionale, Gisenyi strutture alberghiere anche di lusso. Come per le acque del lago la tranquillità inganna.
Sul versante congolese è in corso un conflitto che più di uno scontro di eserciti è una guerra tra bande. Le Forze armate della Repubblica Democratica del Congo fronteggiano le milizie del Movimento 23 Marzo (M23), che secondo le Nazioni Unite e il Dipartimento di Stato Americano sono un braccio armato del governo ruandese. Le due fazioni si contendono a colpi di artiglieria e di mortaio e con feroci incursioni nei campi profughi e nei villaggi il controllo di Goma e dell’aeroporto che, forse per un tacito accordo, continua a funzionare per scopi civili. La città è pacifica, ma le verdissime colline nei dintorni sono insanguinate e le parti si rinfacciano accuse di crimini contro la popolazione. È accaduto anche lo scorso 3 maggio quando è stato bombardato un campo profughi a Mugunga, a ovest di Goma, e sono morte 35 persone. Nessuno se ne è preso la responsabilità.
Il governo congolese parla di «genocidio» e il presidente Félix Tshisekedi ha annunciato la possibilità di una guerra diretta contro il Ruanda. Ma è un presidente debole e lo scorso 19 maggio è scampato a un fallimentare tentativo di golpe ordito da uno sconclusionato drappello di 20 militanti di un gruppo ribattezzatosi New Zaire Movement che ha assaltato, in diretta streaming, la residenza presidenziale.
Sull’altro versante il presidente ruandese, l’ex militare Paul Kagame nega ogni coinvolgimento, ma ha anche detto esplicitamente in un incontro pubblico: «Quando si tratta di difendere questo paese che ha sofferto così tanto, senza che nessuno venisse in nostro aiuto, non ho bisogno del permesso di nessuno per fare quello che devo fare. Dormite sonni tranquilli, nessuno oserà varcare i nostri confini». Tra le righe il riferimento è chiaro.
SONO PASSATI 30 ANNI, ma per il Ruanda il ricordo del genocidio è incancellabile. La popolazione di etnia tutsi venne quasi completamente annientata, Kagame, ai tempi leader dei tutsi del Fronte Patriottico Ruandese, conquistò la capitale Kigali e mise fine alla mattanza. Centinaia di migliaia di hutu, tra cui molti carnefici, scapparono in Congo (allora Zaire) proprio verso Goma, creando una situazione di instabilità che scatenò un conflitto di proporzioni tali da essere definito «prima guerra mondiale africana». Oggi le dinamiche rispecchiano ancora le divisioni del 1994.
L’M23 è in gran parte composto da tutsi che parlano la lingua ruandese kinyarwanda, rivendica il mantenimento degli accordi di pace che vennero siglati il 23 marzo del 2009, ha un arsenale moderno ed efficiente e si accredita come l’ultimo baluardo contro una possibile rivincita dei génocidaires, gli assassini del ’94 e i loro eredi hutu pronti a una vendetta covata per tre decenni.
IL GOVERNO DEL CONGO vede invece l’M23 come dei ribelli separatisti che combattono per procura su ordine di Kagame e il cui unico scopo è depredare il territorio di minerali e in particolare della columbite-tantalite, il cosiddetto coltan, indispensabile per l’industria elettronica. Una materia prima di cui il Ruanda è il maggior esportatore mondiale. Sullo sfondo si muovono più di 100 gruppi armati minori sparpagliati lungo tutto il lato est del Congo. Non mancano, come in un romanzo di Wilbur Smith, avventurieri e mercenari: la società di sicurezza Agemira guidata da ex militari francesi, Congo Protection comandata da un ex legionario di origine rumena e, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, anche Erik Prince l’ex padrone della Blackwater, società di sicurezza americana che si macchiò di crimini di guerra in Iraq.

Ormai in fase di disarmo e pronta al ritiro è la missione militare Onu “Monusco”. Attiva da oltre vent’anni ha provato a mantenere la pace lasciando sul campo circa 300 caschi blu, ma concluderà il suo mandato con un sostanziale fallimento anche se nel mese di maggio ha lanciato l’operazione sul terreno «Artiglio di tigre» per smantellare alcune postazioni di un’altra milizia della regione che si definisce Cooperativa per lo sviluppo del Congo.
LA TRAGICA IRONIA è che questa terra martoriata paga ancora gli errori dei colonialisti. A Kigali, la vecchia casa coloniale del governatore tedesco del paese Richard Kandt è diventata un museo di storia nazionale. È esposta una copia di una foto datata 1910, scattata proprio in riva al lago Kivu. Alcuni militari e funzionari europei in eleganti abiti bianchi posano davanti a un cippo che segna un confine che fino ad allora non esisteva. Una commissione composta da belgi, britannici e tedeschi a Bruxelles aveva deciso che da quel momento da una parte avrebbero governato i belgi e dall’altra i tedeschi. Una popolazione unita da lingua e tradizioni veniva separata. Qualche anno dopo, con il primo conflitto mondiale, quel confine stabilito a migliaia di chilometri con un tratto di penna divenne un fronte. I tedeschi reclutarono le guardie speciali tutsi del Re Musinga del Ruanda, le vestirono con le divise del kaiser e le fecero combattere in una tragica parodia tropicale dei campi di battaglia della Somme. I tedeschi persero, i belgi si appropriarono del Ruanda.
Quel confine rimase, e i belgi decisero di governare il paese trasformando la distinzione sociale ed etnica tra tutsi e hutu in una codificata, anche pseudo-scientificamente, gerarchia politica e razziale, seminando divisione e odio e creando le premesse di massacri che culmineranno con il genocidio del ‘94.
OGGI IL RUANDA è un paese in pieno sviluppo che vuole essere la Singapore d’Africa, ospita un milione e mezzo di turisti all’anno e raccoglie capitali e investimenti per infrastrutture. Il Congo è un gigante dai piedi d’argilla, tanto colossale e ricco di risorse, quanto instabile. A luglio Kagame, che nel paese non ha veri oppositori, verrà rieletto presidente per un quarto mandato. Tshisekedi è stato confermato presidente lo scorso dicembre dopo un voto contestato dai rivali. Gli equilibri sono molto diversi rispetto a quello che vediamo sulla carta geografica. E la comunità internazionale, come è accaduto in passato, distratta da altre guerre e altre tragedie è pronta a chiudere gli occhi e lasciare questa regione al suo destino, comprando materie prime dal miglior offerente.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento