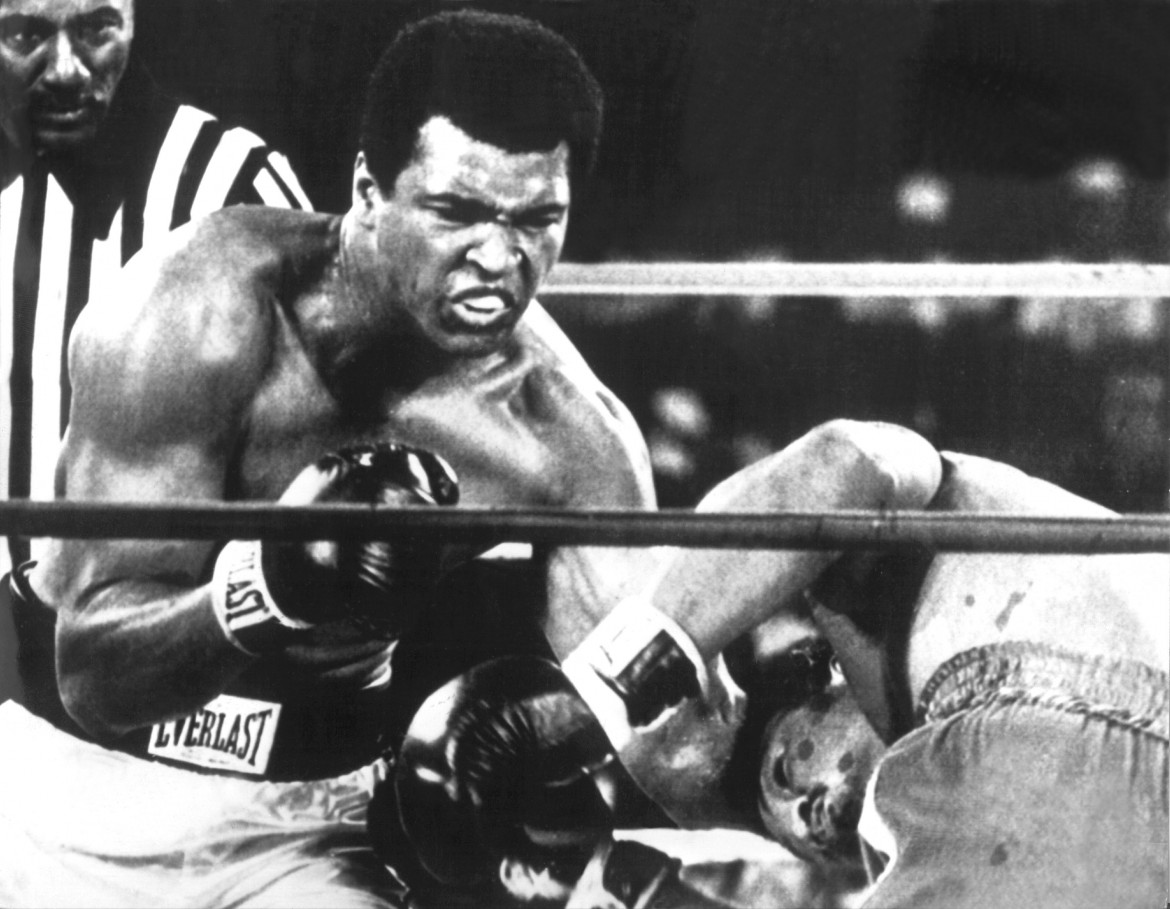Sos Costa d’Avorio
Reportage «L’instabilità politica provoca disastri sociali e ambientali, anche grazie agli «affari» con gli europei, che usano il paese africano come una pattumiera
 Costa d'Avorio
Costa d'AvorioReportage «L’instabilità politica provoca disastri sociali e ambientali, anche grazie agli «affari» con gli europei, che usano il paese africano come una pattumiera
Arrivando, a inizio anno, nella storica capitale di Abidjan, sono tante le considerazioni che si possono fare, soprattutto guardando i villaggi limitrofi, popolosi e desolati al tempo stesso. La fisionomia ambientale della Costa d’Avorio più in generale, ma soprattutto di quest’area, abitata da diversi gruppi etnici, come Akan, Mande, e in minima parte Gru, si presenta complessa e subito salta all’occhio il grande sforzo che queste popolazioni (ben più del loro governo) compiono per cercare di preservare il loro habitat dalla voracità europea, ma anche russa e cinese.
LA ZONA BOSCHIVA DELL’AREA IVORIANA si trova nella parte est ed è costituita da terreni forestali parzialmente bonificati per le piantagioni: eppure di quel grande patrimonio verde resta poco, anzi pochissimo, alle donne e agli uomini indigeni, che si affanno quotidianamente per il lavoro agricolo. Guardando la zona periferica di Abidjan si comprende, sempre più concretamente, come le diverse conferenze sul clima non trovino ancora alcun reale riscontro sulle politiche territoriali di gran parte del continente africano; ma, quel che è peggio, è il fatto che la transizione green di alcune parti del mondo va oggettivamente a svantaggio di altre, ben più povere.
È IL CASO, APPUNTO, DELLA COSTA D’AVORIO, spesso chiamata ad accogliere la plastica delle grandi aziende europee in cambio di denaro, che dovrebbe ipoteticamente, in seconda battuta, servire per rimettere in sesto aree già duramente compromesse dai disastri ambientali. È ovvio che qualcosa non torna, è ovvio che girando per quei territori, con parecchia difficoltà logistica, si respira un’aria di profonda ingiustizia sociale.
È EVIDENTE IL CORTOCIRCUITO CHE SI CREA fra il sistema dei «crediti» (soprattutto promossi dall’Unione europea) per lo smaltimento della plastica dei Paesi ricchi e gli pseudo-progetti ambientali delle zone ivoriane più povere, rimandati sempre all’anno dopo. A chissà quale anno dopo! Intanto il governo ivoriano accoglie i rifiuti europei e racconta alla sua popolazione che questo servirà, nel tempo, al loro progresso economico. E il dato ambientale? Nei documenti governativi risulta che la Costa d’Avorio, sin dal 2013, è leader nella lotta al cambiamento climatico, ma attualmente i dati ospedalieri fanno registrare ancora più di trentamila morti premature derivate da elementi tossici nell’atmosfera. Quasi diecimila di questi decessi sono bambini. Innanzitutto, al momento, si registra una ulteriore riduzione della copertura forestale, un impoverimento del suolo, l’ eutrofizzazione costante delle acque, l’inquinamento (spesso non monitorato) dell’aria e il deterioramento delle aree urbane. Quel che più va sotterraneamente a vantaggio dei grandi colossi europei – che smaltiscono plastica in questa zona dell’Africa occidentale in realtà così densa di parchi nazionali – è la confusione e l’occultamento, in loco, dei dati sull’ambiente, nonostante, dal 1974, sia stato istituito il Ministere des Eaux et Forets, con le varie denominazione cambiate negli anni. E mentre nuovi materiali di scarto arrivano in quelle aree, una riflessione, da lì, si impone sempre più nei nostri reportage.
A FARE LA SUA BUONA PARTE INQUINANTE c’è anche la produzione delle armi. Da lì si ripensa alla frase dell’aprile 2007, quando il presidente Gbagbo dichiarò: «La guerra è finita». È stato davvero così? I discorsi da fare su questo Paese sono tanti, spesso demoralizzanti e il viaggio lungo i viali di Yamoussoukro lascia basiti per tante ragioni: l’estrema povertà e lo spreco di risorse di chi ha persino sognato di ricostruire la copia della Basilica di San Pietro. Il risultato di questo progetto utopico? Ben 300 milioni di dollari, che hanno aggravato enormemente il debito pubblico del Paese, ne hanno deturpato le caratteristiche ambientali locali e hanno lasciato, sempre più persone, senza assistenza sanitaria di base.
A YAMOUSOUKRO C’ERA TANTO VERDE, ora si possono vedere viali in stile occidentale e spazi, sempre più ridotti, delle coltivazioni locali. Onestamente tante zone della Costa d’Avorio esprimono contraddizioni, che lasciano basiti. Poche settimane fa, il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, si è recato in Costa d’Avorio e ha potuto riscontrare, lì, gli effetti negativi derivati dalla recente instabilità politica, dalla guerra civile, dalla crescente corruzione, che poi permette affari illeciti a danno dell’ambiente.
NON VA DIMENTICATA, INFATTI, la questione del cacao, che, pur rappresentando una grandissima risorsa economica del Paese, contribuendo fino al 15% al Pil ivoriano, continua a incrementare soltanto le casse delle multinazionali europee, lasciando sul posto sfruttamento minorile, deforestazione, scomparsa della biodiversità, danni alle piantagioni. Ecco appunto quel che resta di una grande risorsa economica.
MICHAEL KOFFI, AGRICOLTORE LOCALE, sta tentando di segnalare quali siano gli effetti negativi degli interessi sul cacao nelle aree ivoriane. Ha detto: «Noi ivoriani ci stiamo votando al suicidio grazie al clientelismo europeo, che trova spazio, nelle nostre élites locali, in nome del progresso economico e delle cosiddette politiche di rilancio. Rilancio per chi? A favore di chi? A danno di chi? L’ha detto papa Francesco, guardando i nostri dati ambientali: non siete la discarica d’Europa! I danni, anche se ancora molto occultati, risultano evidenti: i fitofarmaci danneggiano i nostri territori, l’eccesso di umidità porta a disastri climatici; poi perdiamo le foreste a un ritmo esponenziale e, inoltre, questi grandi carichi di cacao causano problemi sulla nostra fragile rete viaria, che non è pronta a sostenere una catena di distribuzione così vorace. Le responsabilità non sono soltanto dei Paesi ricchi, che da sempre tentano di depredarci; il problema sono i nostri leader: com’è possibile che permettano una tale devastazione al territorio dove poi crescono i loro stessi figli?». Non c’è molto da esultare, né grandi risultati da evidenziare, in tal senso. E che dire dell’affaire plastica? Koffi ci ricordata quel che accadde nel ’73: «Ad Abidjan ci furono importanti manifestazioni al grido PlasticPollution, ma viaggiando verso il sobborgo Koumassi si vedono ancora enormi baraccopoli dove i bambini giocano fra i rifiuti di plastica, provenienti dall’estero».
LO STESSO KOFFI, PERÒ, CI HA ANCHE MOSTRATO alcune buone pratiche relative soltanto a quella porzione di plastica riciclabile, che viene smaltita in Costa d’Avorio. Innanzitutto bisogna parlare di plastiche. Esistono due grandi classi di plastiche: le termoplastiche e le termoindurenti. Al primo gruppo appartengono il polietilene, il polietilene tereftalato, il polipropilene, il polistirene e il polivinilcloruro (Pvc); al secondo appartengono le resine e i poliuretani. La plastica «buona», quando è riciclabile, ha gradualmente sostituito altri materiali in alcune applicazioni edili, soprattutto perché versatile, permettendo così di sperimentare soluzioni innovative. Una parte di plastica, in Costa d’Avorio, è utilizzata come risorsa edile. In tal senso il pvc può riservare sorprese, se utilizzato nell’ottica dell’economia circolare.
L’UNICEF, DA QUALCHE ANNO, sta affrontando, contemporaneamente, due sfide: quella dell’istruzione e quella della tutela dell’ambiente in quelle zone. In Costa D’Avorio, adesso, i rifiuti di plastica vengono concretamente utilizzati per costruire scuole, e questo grazie proprio ad un progetto lanciato dall’Unicef, in collaborazione con l’impresa Conceptos Plásticos.
CON QUESTO PROGRAMMA, è stato introdotto un approccio innovativo per creare nuove infrastrutture scolastiche: dai rifiuti di plastica raccolti si ricavano mattoni di plastica per costruire aule, se ne riduce la quantità nelle discariche e ciò contribuisce, a lungo termine, a migliorare anche l’ambiente nelle città e a ridurre il rischio che i bambini contraggano malattie la polmonite. Finalmente una speranza concreta per i bambini ivoriani.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento