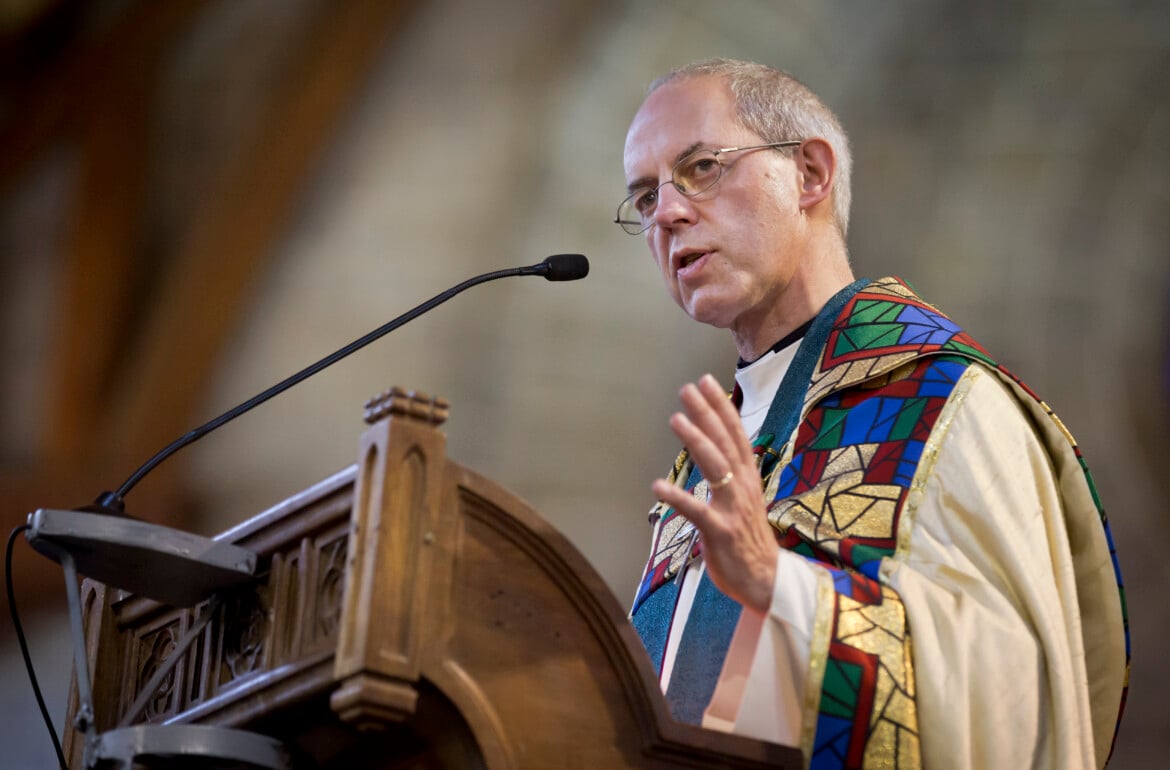Rachel Cusk, la lingua, arma prediletta; ma l’altro può spezzarla
A non prendere le cose come vengono, si rischia di passare per nemici del proprio tempo: di venire guardati con sufficienza, soprattutto se riluttanti a intonare il proprio lessico, e prima ancora le proprie considerazioni, alla rancorosa morale del qui e ora, indotta perlopiù dalla impossibilità di tirare fuori uno straccio di pensiero se non ci si è dati gli strumenti per costruirlo. Una sorta di introiettata paura di non ritrovarsi in sintonia con la propria epoca rende il rifugio nel senso comune la via di fuga più breve, più sicura, a prescindere dal fatto che il senso comune coincida o meno con il buon senso; come se questa fosse la strategia necessaria a sentirsi meno soli, meno investiti da un senso di inferiorità, persino a illudersi di interpretare un ruolo nella gestione della buona vita, nella redistribuzione dei diritti negati: per esempio contribuendo allegramente a stravolgere quel bene comune che è la lingua, con la pretesa di fare giustizia dei rapporti di forza tra i generi.
Arretrato precipitosamente dietro le quinte, il cosiddetto spirito critico di novecentesca memoria è in attesa di venire archiviato in quanto oggetto desueto, in rapido isterilimento se non altro perché le cassette degli attrezzi alle quali si alimentava sono state svuotate e rese superflue prima ancora che ci si rendesse conto di cosa contenevano. Ora giacciono accatastate in attesa di qualche artista di passaggio che le rimetta una sull’altra per farne una qualche evocativa installazione, anch’essa rappresentativa di ciò che è ormai estraneo al nostro tempo.
Maternità, croci e delizie
In quanto oggetto desueto, tuttavia, il pensiero indisponibile a una pacificata ratifica dell’esistente è ancora rintracciabile nelle pagine di qualche libro, che inchioda con zampate di assertività qualcosa di sfuggito al già detto, già sentito, già visto; qualcosa di non ancora sublimato nel lessico comune, e che va dunque riportato a galla, reso parlante. Quando lo si trova incorniciato in un libro a stampa, spersonalizzato dalla figura dell’autore, quel lavoro di scomposizione del reale che ci si offre attuato da altri è alla giusta distanza per venire persino ammirato.
Dev’essere perciò che la singolarissima prosa di Rachel Cusk, prima ancora di avere inventato una voce narrante capace di dire Io evitando rigorosamente di mostrarsi sulla scena, è stata letta come innovatrice del genere romanzesco e al tempo stesso come una minaccia per il genere umano: ad esempio quando, lungi dall’intonarsi al lirismo che quasi sempre accompagna il resoconto delle proprie esperienze di neo-madre, Cusk ha descritto le incombenze seguite alla nascita delle sue due figlie mettendo bene a fuoco quali mortificazioni della propria femminilità e delle proprie legittime aspirazioni di essere pensante essa abbia implicato: «Per agire come una madre, dovevo sospendere il mio carattere, che si era sviluppato seguendo una dieta di valori maschili. E anche il mio habitat, il mio ambiente, si era sviluppato allo stesso modo. S’imponeva un adeguamento… Eppure quella fede – la maternità – non era un luogo dove io potessi davvero vivere. Non c’entrava nulla con me: la sua letteratura e le sue pratiche, i suoi valori e codici di comportamento, la sua estetica, non mi appartenevano».
È un passaggio tratto dall’ultimo libro di Rachel Cusk, Coventry Sulla vita, l’arte e la letteratura (traduzione di Anna Nadotti e Isabella Pasqualetto, Einaudi, Stile libero Extra pp. 232, € 18,50) sommatoria eterogenea e diseguale di saggi, composti via via per accompagnare svariate contingenze, editoriali e non. Sembra, tra queste pagine, che la scrittura della autrice canadese – naturalizzata inglese e attualmente residente in Francia – sia il risultato di una spoliazione preventiva di tutte le sovrastrutturali imposizioni dello spirito del tempo, nonché del logos genitoriale e non solo, finché raggiunta una ideale nudità di sguardo sulle cose, Rachel Cusk si è finalmente sentita in grado di scrivere.
Questa ricercata verginità dal senso comune è dunque il frutto di una decostruzione del déja vu, déja entendu, a sua volta figlia di una intelligenza ribelle a quella dittatura del si dice e del si fa che Heidegger ha eletto a forma inautentica dell’esistenza. Tanto più esigente dunque è la domanda di Rachel Cusk nei confronti della lingua, al tempo stesso esente da velleitarismi sperimentalisti e investita di pretese semantiche tali da ottenere che ogni parola si attagli precisamente alla cosa da nominare. E, alla fin fine, la sua prosa suona effettivamente percussiva quanto le immagini del reale quando vanno a sbattere sulla percezione.
Terrestri metafore
Si direbbe che Cusk si industri a rendere trasparenti, di tutte le situazioni, la crudeltà intrinseca, la spietatezza, i risvolti più ingloriosi, come a una convocazione brutale di cose e persone alla resa dei conti. Da sempre interessata alle arti figurative, Cusk possiede, probabilmente suo malgrado, quella attitudine a irrompere con la sua prosa sulla scena della rappresentazione senza velature simboliche: come se invece di essere il risultato di un processo di sublimazione, l’arte fosse la più diretta espressione di un inconscio senza maschere. Per questa precipitazione del reale sulla scena, senza mediazioni, senza trasformazioni sublimatorie, Cusk ha inventato una nuova cornice, che non è quella del saggio e non è quella della finzione; e anche quando tende all’una o all’altra forma non aderisce mai né all’una né all’altra. Mette piuttosto in campo un Io oggettivato da uno sguardo che tutto ha compreso nel suo perimetro e tutto ha metabolizzato, e che restituisce di ogni boccone, meglio se amaro, l’originario sapore, scomposto tuttavia nei suoi ingredienti, riportati ognuno al proprio peso specifico e alla sua natura.
I ragionamenti di Rachel Cusk sono pieni di terrestri metafore, tutte strettamente interne alla condizione umana, e sia che scomponga gesti e pensieri della sua persona, sia che si applichi agli altri, la scrittura che ha elaborato è profondamente introspettiva senza perciò votarsi alla psicologia. Cerca di andare all’origine, alla vera motivazione, alla causa efficiente dei suoi stessi comportamenti, deponendo una a una le varie maschere indossate, ma evitando di addentrarsi nella descrizione di eventuali traumi pregressi. E se ricapitola il rapporto con la madre, una figura negativa, e con il padre, molto più amato, non è tanto per cavarne una qualche analisi delle sue difese caratteriali, quanto per marcare la distanza tra l’immagine di sé che quelle figure le hanno proiettato addosso e la faticosa costruzione di una propria personalità autonoma, che della distanza guadagnata accetti il conflitto e il dolore, senza soccombervi: «Quando parlavo con lei – scrive a proposito della madre – mi sembrava di rivolgermi a un tiranno contro il quale la mia unica arma erano le parole. Ma le parole erano per l’appunto ciò che scatenava la sua violenza perché, al cuore della sua vita, era stata da esse separata. La fatica, il ruolo materno, il suo status erano al di fuori dell’economia del linguaggio… Non badava a quello che diceva, o meglio, traeva dalle parole i licenziosi piaceri del maltrattamento; cosi facendo, confiscava la mia arma e me la spezzava davanti agli occhi».
In fondo, tutta la scrittura di Cusk parte da un tentativo di scrollarsi di dosso gli abiti sociali che si è ritrovata a vestire, per rivendicarne di più adatti alla sua persona, sempre e comunque senza rinnegare la propria origine borghese, della quale mette in forse soltanto, e non potrebbe essere diversamente, i conformismi ereditati. Nelle sue apparentemente fedeli trascrizioni del parlato altrui, quando sembra riportare come un microfono passivo le frasi ascoltate quasi per caso, la sua emotività, a volte inaridita a volte esaltata dalla spietata riconduzione di ogni frase alla sua ratio, seleziona ciò che va prelevato e ciò che va lasciato cadere, con una adesione ai suoi principi di verità così puntuale e necessaria da rimandare a una sorta di necessità vitale, che distingue ciò che le funziona da segnale significante da ciò è, per lei, solo rumore di fondo. «Svestita, la verità può risultare vulnerabile, goffa, indecente. Troppo agghindata, diventa una menzogna. La mia maggiore difficoltà nella vita e sempre stata quella di conciliare storia e verità…».
Scene da un matrimonio
Sebbene siano in campo, qui, solo necessità di ordine narrativo, Cusk sembra avere antenne ricettive così sensibili al superfluo, che immaginare di sacrificare a una maggiore essenzialità qualche brano della sua prosa è un esercizio fallimentare.
In questa sua ultima raccolta di saggi ha affrontato, fra l’altro, una capziosa «drammaturgia della strada», ovvero la differenza di prospettiva tra chi si ritrova dietro automobili che gli sembrano troppo lente e chi avverte, dalle case dislocate lungo le strade, questa stessa lentezza come un eccesso di velocità: «La guida come metafora» non è, del resto, che un pretesto, «un buon esempio di come il punto di vista corrode la verità».
In altre pagine, Cusk ha descritto la crisi del suo matrimonio, offrendone una prospettiva che, nonostante la distanza, tradisce ancora l’amarezza della disillusione: «Il copione cui ci attenevamo come famiglia è stato abbandonato molto tempo fa: il palcoscenico è stato smontato, quello spettacolo non viene più rappresentato. So che non è stato sostituito da nessun nuovo copione. Ci sono stati episodi pilota, sinossi, qualche idea sparsa; ma fondamentalmente, il futuro è uno spazio bianco».
Ma vattene a Coventry
In coda, alcuni saggi letterari, pregevoli e dissonanti rispetto al basso continuo che riporta insistentemente a vissuti di disadattamento, esemplificati nel capitolo da cui il titolo del libro, «Coventry»: non un ritratto della città che al tempo della seconda guerra subì perdite disastrose, ma – per consonanza con quel passato – la destinazione alla quale gli inglesi inviano, colloquialmente, chi vogliono mandare al diavolo: «A volte ci metto un po’ ad accorgermi che i miei genitori mi hanno mandata a Coventry. Non è molto diverso da quando si rompe la caldaia del riscaldamento: nessuna esplosione, nessuna scena o schianto orribile, solo una crescente sensazione di disagio che deriva dal graduale abbassarsi della temperatura e che può essere incredibilmente arduo – dipende dalle capacita di adattamento di ognuno – attribuire a una causa specifica. Come il freddo, il silenzio avanza, facendosi notare non per presenza ma per assenza, per anomalie così impercettibili che vengono registrate solo a livello subconscio e invece aumentano, così che se ne diventa davvero consapevoli solo quando il processo è compiuto».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento