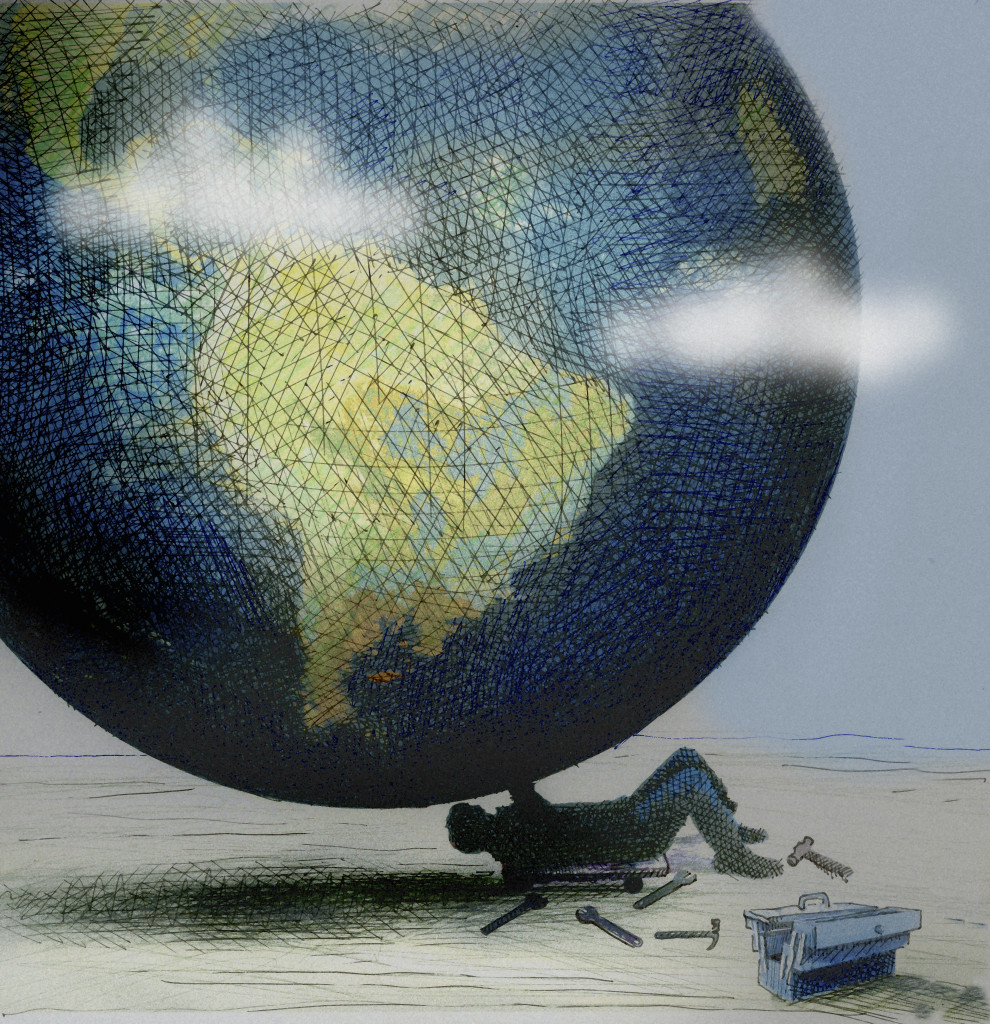«Nuove trivellazioni illegittime», respinto il piano Cingolani
Trivelle 5 regioni e 24 comuni bocciano le inutili perforazioni per la ricerca di idrocarburi e ricorrono al Tar del Lazio: «Pitesai da annullare»
 Una manifestazione contro le trivellazioni dei mari italiani – o Ufficio stampa Greenpeace/LaPresse
Una manifestazione contro le trivellazioni dei mari italiani – o Ufficio stampa Greenpeace/LaPresseTrivelle 5 regioni e 24 comuni bocciano le inutili perforazioni per la ricerca di idrocarburi e ricorrono al Tar del Lazio: «Pitesai da annullare»
Il fronte antitrivelle è costituito, ora, anche da 24 Comuni, di cinque regioni – Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia e Piemonte -, che hanno presentato ricorso ai giudici contro il Pitesai – Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee, strumento volto ad individuare, sul territorio nazionale, le zone «dove è consentito lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi».
VOCI DI PROTESTA, da più parti, si erano già levate ad inizio anno, con la conclusione dell’iter di adozione. Ora il documento è stato impugnato, davanti al Tar del Lazio, dai Comuni di Alba Adriatica (Teramo), Atella (Potenza), Atena Lucana (Salerno), Baragiano (Potenza), Barile (Potenza), Buonabitacolo (Salerno), Carpignano Sesia (Novara), Lavello (Potenza), Lozzolo (Vercelli), Martinsicuro (Teramo), Maschito (Potenza), Montemilone (Potenza), Monte San Giacomo (Salerno), Montesano sulla Marcellana (Salerno), Noto (Siracusa), Padula (Salerno), Pineto (Teramo), Polla, (Salerno), Rionero in Vulture (Potenza), Ripacandida (Potenza), Sala Consilina (Salerno), Silvi (Teramo), Teggiano (Salerno), Venosa (Potenza). Hanno insieme proposto ricorso contro il ministero della Transizione ecologica (Mite), il ministero della Cultura e il ministero dello Sviluppo economico.
L’ATTO, DEPOSITATO l’altro ieri, porta la firma dell’avvocato Paolo Colasante, del Foro di Roma, che ha collaborato col costituzionalista abruzzese Enzo Di Salvatore. A unire i Comuni è stato il Coordinamento nazionale No Triv, come spiega il cofondatore Enrico Gagliano: «Hanno aderito non solo i territori sui quali insistono importanti attività di trivellazione ma anche quelli che vedono il proprio futuro minacciato». Il ricorso si basa su quattro punti, per arrivare a chiedere l’annullamento del Pitesai e di tutti gli atti che hanno portato alla sua definizione. Innanziutto viene fatto presente che il Piano avrebbe dovuto essere adottato, tassativamente, entro il 30 settembre 2021. Invece esso reca la data del 28 dicembre scorso ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo l’11 febbraio 2022, pertanto «è fuori termine» e «deve essere dichiarato illegittimo». «Nonostante la lunga elaborazione – viene poi evidenziato -, esso si appalesa problematico anche sotto altri profili, fra cui la mancata considerazione degli effetti cumulativi dei progetti esistenti e di quelli che potranno essere richiesti. Non vi è traccia alcuna di ciò, quindi ne «deriva che il provvedimento si pone in palese contrasto con il diritto dell’Unione europea». Ma le pecche continuano.
«IL PITESAI NON REALIZZA l’obiettivo che gli era stato assegnato», che è quello «di individuare un quadro preciso di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Non va a definire «zone aperte» e «zone chiuse» alle attività minerarie, con mappature chiare. E’ piuttosto un «atto di indirizzo generale», in buona sostanza un vademecum o un documento recante linee guida per orientare” future decisioni. Altra questione del contendere è quanto emerso dalla Conferenza unificata di Regioni ed enti locali, che ha dato parere positivo “subordinatamente alla garanzia che, nelle aree idonee definite dal Piano, il prosieguo delle attività connesse ai permessi di ricerca di idrocarburi si limitino esclusivamente al gas”, e non al petrolio. “L’adesione del Mite alla condizione posta – si evidenzia nel ricorso – è, per un verso, illegittima e, per altro verso, inutile”. Perché non si può stabilire a priori, prima delle perforazioni, se in un posto ci sarà solo gas.
SULLE CRITICITÀ DEL PITESAI si pronunciano anche Greenpeace, Legambiente e Wwf che rimarcano come contenga «situazioni che non fanno presagire nulla di buono riguardo, sia in mare che in terra, all’inviduazione di zone idonee e non. «Se un’area – riflettono – è stata individuata come “non idonea” da un punto di vista ambientale, economico e sociale, non si capisce perché possa diventare magicamente “compatibile” se c’è una parvenza misera di gas da sfruttare». E aggiungono: «La quasi totalità del gas estratto in Italia proviene da 15 concessioni di coltivazione, mentre le restanti 86 contribuiscono ognuna pochi decimi percentuali rispetto al totale. In ottica di produzione ed economicità sarebbero quindi tutte da dismettere perché vivono senza dare alcun apporto significativo, strategico o economico alla comunità».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento