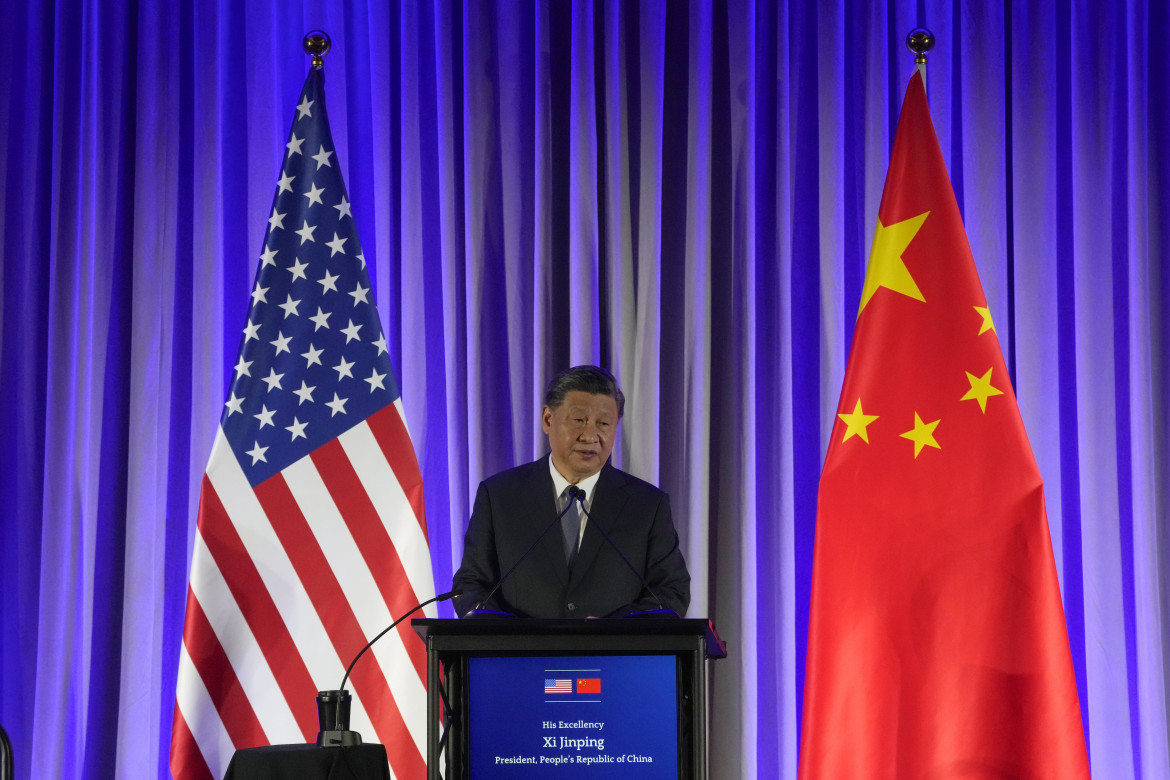Norme, non solo armi: l’arsenale di Pechino per prendersi Taiwan
Cina/Taiwan Intervista allo storico Wu Rwei-ren, il primo taiwanese a rischiare la condanna ai sensi della legge di sicurezza nazionale di Hong Kong
 Academia sinica a Taiwan – Lorenzo Lamperti
Academia sinica a Taiwan – Lorenzo LampertiCina/Taiwan Intervista allo storico Wu Rwei-ren, il primo taiwanese a rischiare la condanna ai sensi della legge di sicurezza nazionale di Hong Kong
“Vogliono fare di me un simbolo di tutti i taiwanesi e di tutti gli accademici”. Parlando nel suo studio all’Academia Sinica, Wu Rwei-ren dice di non avere paura (“non credo che verranno qui a rapirmi”) ma non nasconde l’inquietudine per essere il primo taiwanese a rischiare la condanna ai sensi della legge di sicurezza nazionale di Hong Kong.
Mentre a favore di radar e retorica vengono mostrate le armi, e mentre dopo l’invasione russa in Ucraina si rincorrono le previsioni temporali di un’ipotetica invasione su larga scala, la vicenda di Wu è fondamentale per capire come la Repubblica Popolare Cinese stia affilando l’arsenale normativo a disposizione per provare a soggiogare Taiwan senza l’utilizzo della forza.
Storico e politologo, Wu studia da decenni pensiero politico e nazionalismo comparato. Dopo aver lavorato negli Stati Uniti e in Giappone ha fatto ritorno a Taipei dove lavora presso l’istituto di ricerca nazionale della Repubblica di Cina. Tra i suoi studenti anche tanti attivisti del movimento dei girasoli (compreso il leader Lin Fei-fan), l’esperienza di protesta con istanze identitarie che ha rivitalizzato l’allora smarrito Partito democratico progressista targato Tsai Ing-wen.
Poco più di un mese fa, il media di Hong Kong pro Pechino Ta Kung Pao ha scritto che Wu ha violato la legge sulla sicurezza nazionale, lo strumento normativo entrato in vigore nel 2020 che ha di fatto prepensionato il modello “un paese, due sistemi” e ha portato allo smantellamento dell’opposizione politica dell’ex colonia britannica.
Da lì è partita una campagna mediatica nei confronti di Wu che potrebbe sfociare in un processo e in una condanna da 10 a 30 anni di carcere per sovversione e sedizione. Il motivo? Un articolo dal titolo “Per una rivoluzione incompiuta” sui movimenti di protesta di Hong Kong, tra i vincitori dello Human Rights Press Awards organizzato dal Foreign Correspondents’ Club.
“Ho iniziato a essere coinvolto nelle vicende di Hong Kong poco prima della rivoluzione degli ombrelli”, racconta Wu. “Il movimento studentesco si interessò a me perché sono il traduttore in mandarino di Imagined Communities di Benedict Anderson (sociologo irlandese nato in Cina di approccio marxista e autore di un volume considerato imprescindibile sul tema del nazionalismo, ndr). Ho visto coi miei occhi un malessere localista e un patriottismo rudimentale diventare un vero e proprio sentimento nazionalista. Un fenomeno che ho commentato e analizzato in un articolo intitolato The discourse on Hong Kong nationalism“.
Wu sostiene che “la parola ‘nazionalismo’ non esisteva in riferimento a Hong Kong prima del 2014. Ad aiutarne la diffusione sono state la mancata comprensione delle proteste da parte del Partito comunista. L’autonomia di Hong Kong si è sempre basata solo sulle parole: se Xi Jinping avesse fornito garanzie legali in senso federale di quel sistema avrebbe probabilmente circoscritto le proteste diminuendo lo slancio nazionalista di cui si sono nutrite per l’aggressività di Pechino”, sostiene Wu. “Scrivendo articoli non mi sono aggregato al movimento di protesta, ho semplicemente analizzato quanto stava accadendo come il mio lavoro richiede. Anzi, Xi avrebbe potuto cogliere qualche consiglio”.
Alle autorità, invece, i suoi articoli non sono piaciuti. Nonostante questo, gli è stato consentito più volte di tornare a Hong Kong per presenziare a conferenze. Perché dunque accusarlo ora, all’improvviso? E perché accusare proprio lui? “Ritengo ci siano tre risposte a questa domanda”, dice Wu. “La prima riguarda il contesto di Hong Kong.
Dopo aver smantellato l’opposizione politica e quella civile, le autorità vogliono completare la stretta sui media. Il mio caso verrà utilizzato per colpire il club dei giornalisti di Hong Kong e il Foreign Correspondents’ Club. La seconda riguarda tutti gli accademici, che saranno il prossimo target del governo locale e di quello di Pechino. Incriminando me si vogliono intimidire professori, ricercatori e istituti di tutto il mondo che decidono di occuparsi di temi legati a Hong Kong e, più in generale, di temi legati alla Cina. La terza riguarda invece il mio passaporto: colpendo me si colpisce tutta la popolazione taiwanese. Non credo pensino di impaurire o ridurre al silenzio me, per me ormai è troppo tardi, ma ritengono di poterlo fare con tanti altri taiwanesi”, prosegue Wu.
“L’Academia Sinica ha fatto qualcosa di inusuale: ha preso immediatamente le mie difese con una dichiarazione molto netta a difesa della libertà di espressione. Ma nell’ultimo paragrafo si chiedeva a tutte le istituzioni accademiche taiwanesi di aggregarsi e firmare pubblicamente quel documento. Sa in quante lo hanno fatto? Zero. Università e accademie hanno diversi progetti di cooperazione con istituti cinesi, in molti ricevono dei fondi: è difficile che prendano una posizione pubblica che possa mettere a rischio i loro rapporti”, spiega Wu.
“C’è poi anche un discorso individuale: in tanti studiosi meno conosciuti di me possono da qui in avanti avere più paura di farsi coinvolgere sul tema di Hong Kong. Così come i tantissimi taiwanesi che prima del Covid andavano a Hong Kong due volte l’anno per turismo e shopping potrebbero non andarci più nel timore di essere accusati per un post o una fotografia sui social”.
Si tratta dello stesso schema utilizzato col recente annuncio della lista nera che include diversi politici di primo piano del governo taiwanese. I bersagli sono loro solo a livello superficiale. Il vero target sono i cittadini taiwanesi, in particolare chi ha interessi sul territorio della Repubblica Popolare. Sintomatica la vicenda di Far Eastern Group, uno dei più grandi conglomerati taiwanesi attivi in Cina.
Dopo le sanzioni economiche e la minaccia di esproprio dei terreni alle aziende taiwanesi “colluse” con figure indipendentiste, il patron Douglas Hsu si è esposto pubblicamente dicendosi contrario all’indipendenza taiwanese. “Questi esempi dimostrano che questo tipo di intimidazioni hanno un effetto”, sostiene Wu.
I taiwanesi sono abituati a trovarsi in prima linea e le intimidazioni militari hanno successo solo in parte. Anzi, le manovre dell’Esercito popolare di liberazione sembrano per ora più rivolte al “pubblico” interno e a quello internazionale, mostrando la risolutezza della leadership di Pechino di non concedere nessuno spazio di negoziazione sull’obiettivo “storico” della “riunificazione”. Sui taiwanesi, invece, sembrano fare più presa le mosse che intaccano in maniera più diretta gli interessi economici o la sicurezza personale. Il tutto mentre proseguono i tentativi di Pechino di ampliare la cosiddetta “zona grigia”, come nel caso del progetto di costruzione di un aeroporto a Pingtan, l’isola cinese più vicina all’isola principale di Taiwan, e quello di un ponte per collegare Xiamen a Kinmen.
Ma, secondo Wu, Taiwan ha superato il “punto di non ritorno” a gennaio 2020, con la seconda elezione di Tsai Ing-wen. “Così come è stato il Partito comunista a fomentare il nazionalismo di Hong Kong, allo stesso modo è stato Xi a salvare Tsai. A fine 2018 lei e il suo governo erano in grande crisi. Ma nel discorso di capodanno 2019, Xi ha spiegato che per Taiwan esiste una sola ipotesi: un paese, due sistemi. Visto quanto accaduto a distanza di pochi mesi a Hong Kong, quelle parole hanno decretato la fine delle possibilità di qualsiasi riavvicinamento politico. Taiwan si sta muovendo su un terreno sempre meno ambiguo sul proprio status e sulla propria identità, seppure in modo saggiamente molto cauto e pragmatico”, sostiene Wu.
“Fare passi avventati e recidere il legame con la sfera storico-culturale cinese, come per esempio cambiare il nome Repubblica di Cina, avrebbe conseguenze non sul piano esterno con la prevedibile reazione di Pechino ma anche sul piano interno. Una parte della popolazione taiwanese non vuole perdere quel legame: seppure non si opponga all’indipendenza de facto percepisce ancora l’appartenenza al mondo cinese. Se non dal punto di vista politico, quantomeno da quello culturale ed emotivo. Negli anni Novanta il processo di democratizzazione di Taiwan è stato costruito proprio sul compromesso tra l’élite politica cinese del Guomindang e la società taiwanese. Lee Teng-hui è stato l’anello di congiunzione che ha consentito il superamento delle tensioni interne. Ora la composizione politico-sociale è cambiata ma Taiwan non si può permettere un ritorno a turbolenze interne in grado di indebolirla e rallentare il suo percorso”, conclude Wu. Arsenali permettendo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento