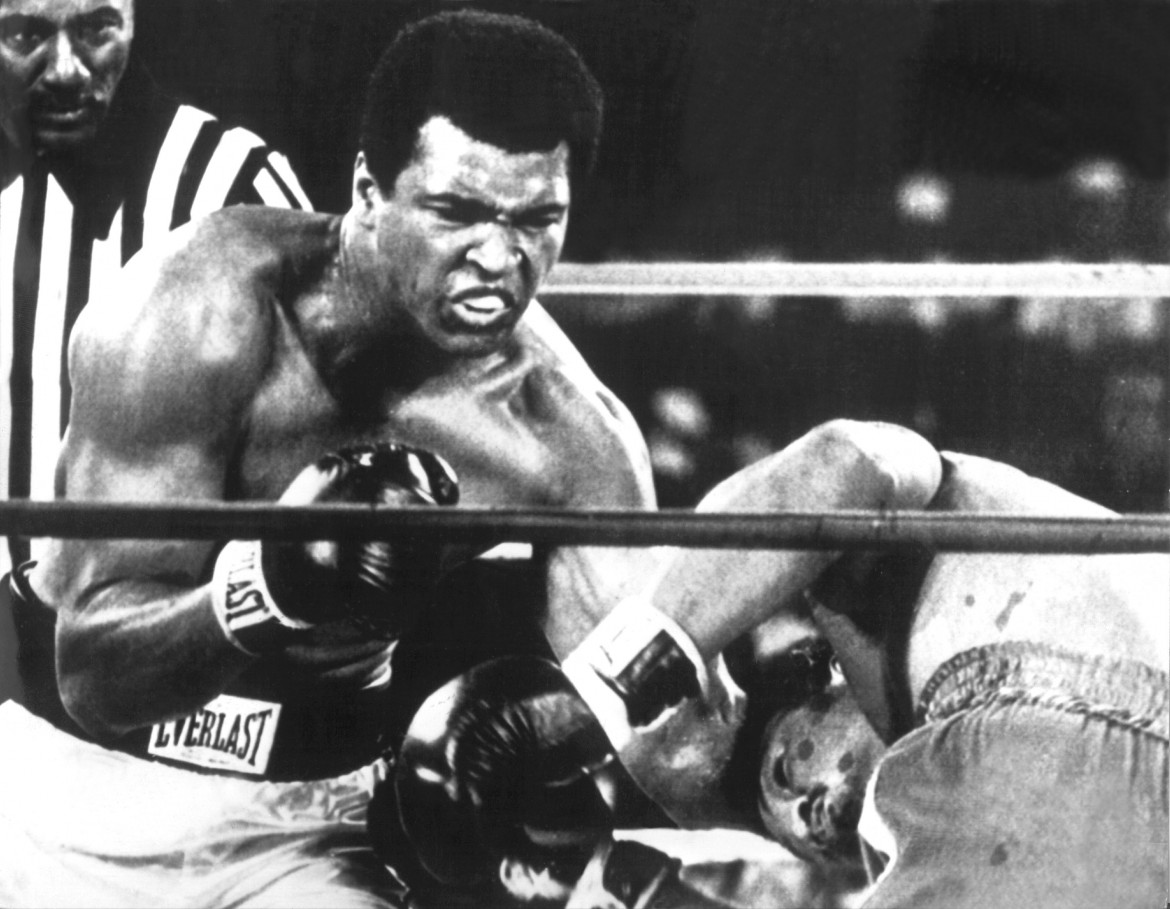Maaza Mengiste, il viaggio dell’Africa che è dentro di noi
Tempi presenti Intervista alla scrittrice etiope-americana che interverrà venerdì a «Incroci di civiltà», il Festival internazionale di letteratura, che si apre oggi a Venezia. «Cultura post-coloniale? Non ci siamo ancora: il dominio ha solo cambiato maschera. Ma l’Etiopia era già presente nei testi romani». «Vivo in un Paese che ha paura del pensiero e dell’immaginazione. Ma chi vuole bandire i libri non capisce che si può cancellare un testo, non la mente. Un uomo può essere ucciso, un’idea no»
 Un ritratto di Maaza Mengiste firmato da Nina Subin
Un ritratto di Maaza Mengiste firmato da Nina SubinTempi presenti Intervista alla scrittrice etiope-americana che interverrà venerdì a «Incroci di civiltà», il Festival internazionale di letteratura, che si apre oggi a Venezia. «Cultura post-coloniale? Non ci siamo ancora: il dominio ha solo cambiato maschera. Ma l’Etiopia era già presente nei testi romani». «Vivo in un Paese che ha paura del pensiero e dell’immaginazione. Ma chi vuole bandire i libri non capisce che si può cancellare un testo, non la mente. Un uomo può essere ucciso, un’idea no»
Intervenendo qualche anno fa sul Guardian, che pubblica da tempo i suoi scritti al pari di molte altre testate internazionali, come, tra gli altri, il New Yorker, Granta e il New York Times, Maaza Mengiste si chiedeva, tra il polemico e il divertito, cosa facesse di un autore o un’autrice dei «veri africani», lamentando come agli scrittori del continente venissero rivolte principalmente domande attinenti la loro identità piuttosto che le loro opere.
Una riflessione che può stupire solo chi non conosca l’itinerario seguito da Maaza Mengiste, scrittrice etiope-americana, nel senso che nata a Addis Abeba nel 1971 è arrivata negli Stati Uniti, dove vive ancora oggi, a New York, quando aveva solo tre anni, e ha continuato a guardare alle proprie origini – la famiglia fuggì dall’Etiopia nel 1974 dopo il colpo di Stato guidato da Menghistu che mise fine al regno di Hailé Selassié -, intrecciando l’internità all’analisi in campo aperto.
Come rivelano le sue opere, Lo sguardo del leone (Neri Pozza, 2010), Il re ombra (Einaudi, 2019) e la cura dell’antologia Addis Ababa Noir (Akashic Book, 2020), l’Africa di Mengiste è il palcoscenico dove si sono giocate alcune tragedie di dimensioni globali, ma anche lo spazio intimo della memoria dei propri cari. Al centro del suo sguardo, il ruolo delle donne nei conflitti che hanno attraversato l’Etiopia, ma anche la loro apparente «scomparsa» dal ricordo pubblico di tali eventi. Ad Incroci di civiltà, dove interverrà – collegata da New York – venerdì (ore 15, Auditorium S. Margherita) Mangiste dialogherà con lo scrittore critico d’arte nigeriano Emmanuel Iduma con Lucio De Capitani lungo una rotta che da Lagos conduce fino a Venezia.
Al centro delle sue opere c’è spesso il ruolo svolto dalla memoria collettiva nelle traiettorie esistenziali di ciascuno di noi. In questo senso, qual è il rapporto tra passato e presente nel suo itinerario di autrice?
Credo che il passato si intrometta costantemente nel presente e che, anche nel mondo attuale, esistiamo non solo nel presente, ma anche nel passato. Per uno scrittore, cercare di capire come le persone ricordano ciò che gli viene detto di ricordare, ma anche ciò che è realmente accaduto, non rappresenta un lavoro intorno alla Storia, quanto piuttosto qualcosa che guarda al futuro. E come scrittrice, è questo «il territorio» in cui preferisco muovermi, non solo per interesse storico, ma perché rappresenta una speranza nella direzione di un avvenire migliore.

Perché in realtà questo tipo di violenza contro le donne, contro i corpi delle donne, è una sorta di «estensione» di qualunque guerra. Quando i soldati invadono un territorio, una delle prime cose che fanno è violentare le donne che vivono lì. Non rivendicano solo il loro dominio su quella terra, ma capiscono che violando le donne, stanno distruggendo una comunità: stanno distruggendo il futuro di quella comunità per i bambini che potrebbero nascere da quelle violenze. In questo modo vogliono cancellare qualsiasi senso di pace e di benessere che quella comunità potrà mai avere in futuro.
«Lo sguardo del leone» affronta le tragedie che hanno accompagnato la fine di Hailé Selassié. Nella riflessione sulla cultura postcoloniale c’è spazio anche per i conflitti sorti in Africa dopo la fine del colonialismo europeo?
C’è abbastanza spazio? Questa è una domanda molto interessante. È anche piuttosto vasta. Non posso analizzare tutti i Paesi africani. Ma una cosa chiara posso dirla: non credo che siamo in un mondo post-coloniale. Forse qualche anno fa pensavo che l’avessimo superato, ma ora credo che il colonialismo abbia solo cambiato la propria maschera. Lo vediamo nel commercio di armi, nel modo in cui vengono concessi o meno gli aiuti finanziari, o gli aiuti umanitari. Lo vediamo nelle pressioni politiche che vengono esercitate sui diversi Paesi. Un esempio? Basta guardare agli Stati Uniti, che sono un Paese imperialista, coloniale. O a quello che sta facendo Israele a Gaza: un’impresa coloniale. Il colonialismo non è ancora finito. E credo che se me lo si chiede come americana, e non solo come scrittrice etiope, dovrei anche indicare le esperienze degli afroamericani, le esperienze dei nativi americani negli Usa. Non abbiamo ancora finito: la lotta continua, ma ha cambiato forma. C’è un’energia collettiva che si sta raccogliendo: spero sia questo slancio a condurci ad un mondo veramente decolonizzato.
Lei ha curato una raccolta di racconti dal titolo «Addis Ababa Noir» (inedita in Italia). Nell’introduzione spiega come queste storie indaghino «gli angoli oscuri del Paese»: cosa emerge, quale volto dell’Etiopia?
Ho trovato molto interessante il fatto che molti scrittori stiano ancora esaminando gli effetti della rivoluzione del 1974. Ho parlato con uno degli autori coinvolti che mi ha confessato di pensare a quel periodo come se fosse oggi: «Sai, Maaza – mi ha detto -, il ricordo non ti abbandona mai e tu non lasci mai quel periodo. È sempre con te». La memoria di quell’epoca è davvero presente in almeno una o due generazioni di etiopi e questo anche a causa del fatto che non c’è stata alcuna riflessione collettiva su tale argomento. Ciascuno sta ancora facendo i conti da solo con quanto è successo allora: alla propria famiglia, come a un’intera generazione che è semplicemente scomparsa.
Lei è una scrittrice e un’insegnante di letteratura che ha sempre analizzato il passato coloniale: come guarda al fatto che nel suo Paese si mettono al bando i libri e che un uomo che non fa mistero delle proprie idee razziste come Trump possa tornare alla Casa Bianca?
Vivo in un Paese che ha molta paura delle idee e dell’immaginazione. Quello che le persone che vietano i libri non capiscono è che l’immaginazione sarà sempre libera: si può cancellare un libro, ma non un cervello, una mente, un pensiero, un’idea. Non si può uccidere un’idea. Anche se si può uccidere un essere umano e distruggere un libro. E credo che la prossima battaglia sia proprio questa: per il diritto di pensare e di esistere nel modo in cui ciascuno preferisce. Perciò, penso che sia un momento spaventoso per una scrittrice, ma che si possa nutrire anche un po’ di speranza visto che il mondo comincia a sollevarsi: il segnale che le cose stanno iniziando a cambiare. Non so quanto velocemente cambieranno, ma sta emergendo un rifiuto collettivo di vivere sotto ogni forma di oppressione. E spero che questo slancio continui.
Il tema del viaggio è al centro di «Incroci di civiltà», venerdì lei parlerà del libro di Emmanuel Iduma che racconta un itinerario da Lagos a Venezia: si guarda al viaggio in modo diverso a seconda del luogo da cui si parte? E ci può anticipare il senso di ciò che dirà al Festival?
Senza dubbio nel modo in cui pensiamo ad un viaggio, o ci mettiamo in cammino, gioca un ruolo importante il luogo in cui viviamo. Iduma viene dalla Nigeria, ma vive nel Regno Unito. Nei suoi viaggi porta entrambe le prospettive. Al Festival riflette sul suo sguardo di africano, ma di un africano cosmopolita che parla più lingue, scrive libri, vive in varie parti del mondo. E ciò che vede a Venezia è qualcosa di unico: si interessa a come un’idea diventa una parola, quindi un paragrafo, infine un mondo. E si interroga su come questo processo si colleghi alla fotografia. Ma credo anche che a Venezia, e più in generale in Italia, sia rimasto affascinato dalla storia del Paese, dalla sua bellezza, ma anche dal fatto che l’Africa vi è sempre stata presente. Posso leggere dei testi romani e trovare citata l’Etiopia. Credo che Iduma abbia trovato il modo di attingere da questa storia millenaria. Discuterò con lui della scrittura e del rapporto con l’immaginario e la fotografia, ma anche di ciò che la sua presenza, come africano, ha significato per lui a Venezia.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento