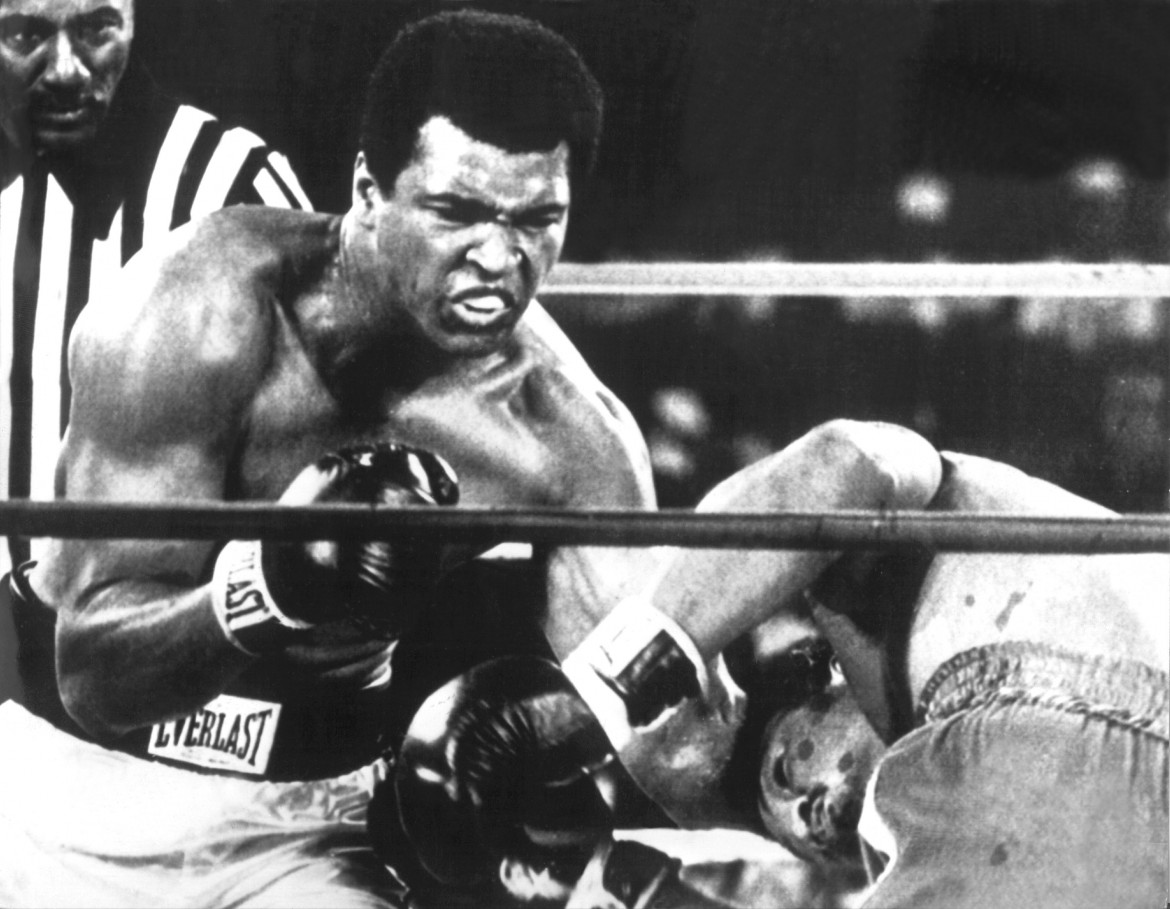L’Italia, impotenza coloniale
5 maggio Il 5 maggio ricorre sia l’inizio che la fine, cinque anni dopo, dell’occupazione fascista in Etiopia. Tema da sempre tabù nel nostro paese. Più che mai oggi, grazie anche alla retorica del Piano Mattei. Un’altra occasione persa per rimuovere gli scheletri dall’armadio è stata la riconsegna del primo aereo costruito nel paese africano, che all’epoca fu «requisito» dagli italiani
 Roma, febbraio 2024, il ministro Crosetto riconsegna al premier etiope Abiy Ahmed «Tsehay», aereo intitolato alla figlia dell'imperatore Selassié – Ministero della Difesa
Roma, febbraio 2024, il ministro Crosetto riconsegna al premier etiope Abiy Ahmed «Tsehay», aereo intitolato alla figlia dell'imperatore Selassié – Ministero della Difesa 5 maggio Il 5 maggio ricorre sia l’inizio che la fine, cinque anni dopo, dell’occupazione fascista in Etiopia. Tema da sempre tabù nel nostro paese. Più che mai oggi, grazie anche alla retorica del Piano Mattei. Un’altra occasione persa per rimuovere gli scheletri dall’armadio è stata la riconsegna del primo aereo costruito nel paese africano, che all’epoca fu «requisito» dagli italiani
Accordi, scambi commerciali, viaggi, incontri, ma di riconoscere un passato comune, spesso violento e di sfruttamento, lo stato italiano non ne ha proprio voglia. Il nostro rapporto con le ex colonie continua a essere problematico, irrisolto, ma soprattutto volutamente omesso. Eppure le occasioni e le date non mancherebbero, come oggi, 5 maggio, il giorno che ricorda l’inizio dell’occupazione italiana dell’Etiopia (1936) e il ritorno dell’imperatore Hailé Selassié, lo stesso giorno solo cinque anni dopo. In Etiopia è festa nazionale, «Giorno della vittoria dei patrioti etiopi», anche detto Meyazia 27.
Dal basso, qualcosa, piano piano si sta muovendo, con le celebrazioni intorno a Yekatit 12 (massacro di Addis Abeba), ma a livello governativo quando si parla di colonialismo lo si fa in modo sbilenco e in genere non lo si fa. Un’altra occasione persa per farlo, a febbraio, la riconsegna all’Etiopia del primo aereo costruito nel paese. Secondo una nota del Ministero della Difesa (italiano), «L’aeroplano realizzò il suo primo volo nel dicembre del 1935 e totalizzò in totale circa 30 ore di volo per poi essere abbandonato ad Addis Abeba nel maggio 1936, prima dell’arrivo degli italiani, che lo requisirono per poi esporlo, nel 1941, nel Museo dell’Accademia Aeronautica di Caserta».
COSA FACEVANO GLI ITALIANI ad Addis Abeba nel 1936? Perché si parla di requisire e non, più correttamente, di espropriare, rubare, depredare, saccheggiare? Non sfugga anche il particolare dell’abbandono, a cui sta dietro una delle mistificazioni (neo)coloniali più dure a morire: gli africani, incapaci di usare le proprie risorse (naturali o meno), sanno solo abbandonarle a loro stesse. Nella nota ministeriale si parla di «rapporto storico tra Etiopia e Italia», insistendo su una retorica depauperata di qualunque riferimento a rapporti di dominio, sfruttamento, crimini coloniali che è pressoché invariata da quella che si affermò nel primo dopoguerra. Perché non è vero che di colonialismo in Italia non si è parlato, come purtroppo una leggenda dura a morire sostiene: se ne è sempre parlato, il problema è il come, il chi, omettendo cosa, concentrandosi su quali aspetti («italiani brava gente»). In questo caso, la riconsegna dell’aereo sta in un ambito significante che è quello delle restituzioni seguite alla fine degli imperi, questione che l’Italia sta affrontando di recente e in maniera molto complessa (si veda l’Obelisco di Axum).
NEANCHE GLI INFAUSTI ACCORDI per costruire due centri di prigionia per migranti in territorio albanese, gestiti dall’Italia e in cui verrà applicata la legislazione italiana e della Ue, hanno suscitato echi coloniali. Un ritorno in grande stile, in un paese che l’Italia ha controllato solo per pochi anni durante la guerra mondiale – lasciando però un segno, anche architettonico, indelebile – ma la cui influenza è durata per decenni. Sarebbe forse bastato anche meno di un mea culpa, ma anche in questo caso di colonialismo non si parla, eppure la questione dei rimpatri dei coloni italiani dall’Albania si è risolta definitivamente con la concessione della pensione ai pochi rimasti in vita solo a inizio anni 2000, praticamente l’altro ieri. L’Italia può avere la sua piccola Guantanamo al di là del canale d’Otranto senza svegliare nessun morto albanese, o italiano rimasto bloccato per decenni in un paese straniero per colpa di un’impresa coloniale.

In occasione della riconsegna dell’aereo all’Etiopia, Crosetto ha insistito sull’importanza del fumoso Piano Mattei per l’Africa. Non a caso, ci si concentra sulla figura dell’ex presidente dell’azienda petrolifera di stato e, pur restituendo al governo etiopico “Tsehay”, il primo aereo costruito nel paese e intitolato alla figlia di Hailé Selassié, si sorvola sul colonialismo. Eppure, i legami non mancherebbero: non si tratta soltanto dei territori e delle popolazioni coinvolti, che in parte corrispondono a quelli che l’Italia ha colonizzato. Riguarda anche, se non soprattutto, l’attitudine con la quale l’Italia si relaziona a quelle popolazioni e come “vende” sé stessa. Oggi come ieri i governi e le istituzioni italiane utilizzano una retorica che elude la storia coloniale del paese, e che presenta gli italiani come buoni alleati alla pari, non come membri di una ricca élite economico-politica occidentale.
IERI, IN UN’ITALIA che aveva ormai perduto le colonie, e fino al 1960 manteneva in Somalia una amministrazione fiduciaria per conto dell’Onu, si affermò una retorica di un paese quasi terzo, anche se inserito nell’alleanza atlantica e ben saldamente legato a paesi che crimini coloniali continuava a commetterli (Francia, Portogallo), capace quindi di parlare ai paesi del sud globale come partner. Un posizionamento geopolitico decisamente complesso, in cui l’Eni di Enrico Mattei poteva vendere ai paesi nordafricani l’immagine di una Italia cooperante pacifica, estranea o comunque emancipatasi dal processo di sfruttamento messo in atto col colonialismo dagli altri paesi europei e perciò un partner affidabile e leale, rispetto a Gran Bretagna e Francia, per i paesi che avevano costruito la loro nuova indipendenza attraverso le lotte anticolonialiste.
Quei paesi dovevano aprirsi alla tecnologia italiana e scegliere il paese come partner. Una ricetta retorica che aveva e continua ad avere un grande successo nella penisola, convinti come sono, gli italiani, che il loro colonialismo sia stato speciale, più buono degli altri e, in fin dei conti, soltanto un movimento migratorio di disoccupati verso le colonie. Solo che ieri in Italia si muovevano effettivamente attivi movimenti di solidarietà anticoloniale, i leader terzomondisti (Frantz Fanon, Amílcar Cabral) trovavano qui rifugio e riconoscevano un ruolo di famigliarità con ampi settori della società italiana, Mattei supportava anche apertamente le lotte di indipendenza e pronunciava discorsi incendiari che gli costarono richiami – e probabilmente la vita.
OGGI, IN UN’ITALIA MOLTO DIVERSA da quella di Mattei, ritroviamo la stessa retorica che accompagna e avvolge gli accordi commerciali che il governo del paese propone ai paesi africani e all’Albania, ma senza un centesimo di quel contesto.
Un paese senza «scheletri coloniali nell’armadio» (come scrisse qualche anno fa il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano), per il quale le riparazioni coloniali verso la Libia, siglate dal governo Berlusconi nel 2008, la restituzione della stele di Axum all’Etiopia nel 2005, e nel 2024 la restituzione ai legittimi proprietari del primo velivolo etiopico non sono mai stati dei momenti che hanno coinvolto società e istituzioni in un ripensamento del passato coloniale del paese e di come quella storia sia diventata centrale nel costruire l’identità nazionale italiana dal 1946 a oggi. Un’Italia che non ha mai avuto, se non nel 1997 con il discorso di Oscar Luigi Scalfaro ad Addis Abeba, la forza di aprire quell’armadio e di iniziare a rovistarci dentro per ragionare su come organizzare il cambio di stagione, cosa tenere e cosa buttare. Quell’armadio continua a rimanere chiuso e l’abito coloniale con cui il paese va in giro è ormai strappato in più punti; è arrivata l’ora che le istituzioni italiane lo mettano da parte, dismettendo per sempre anche il caschetto coloniale. E di farlo sempre, magari proprio a partire da queste date, come il 5 maggio, già piene di significato.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento