La vita eterna dei ricordi, tra Ninfe, Bot, e Asimov
Mnemosyne e dintorni Per comprendere cosa significhi la memoria bisogna necessariamente indagare, o forse sarebbe meglio dire indagarla, nella sua relazione con l’eternità...
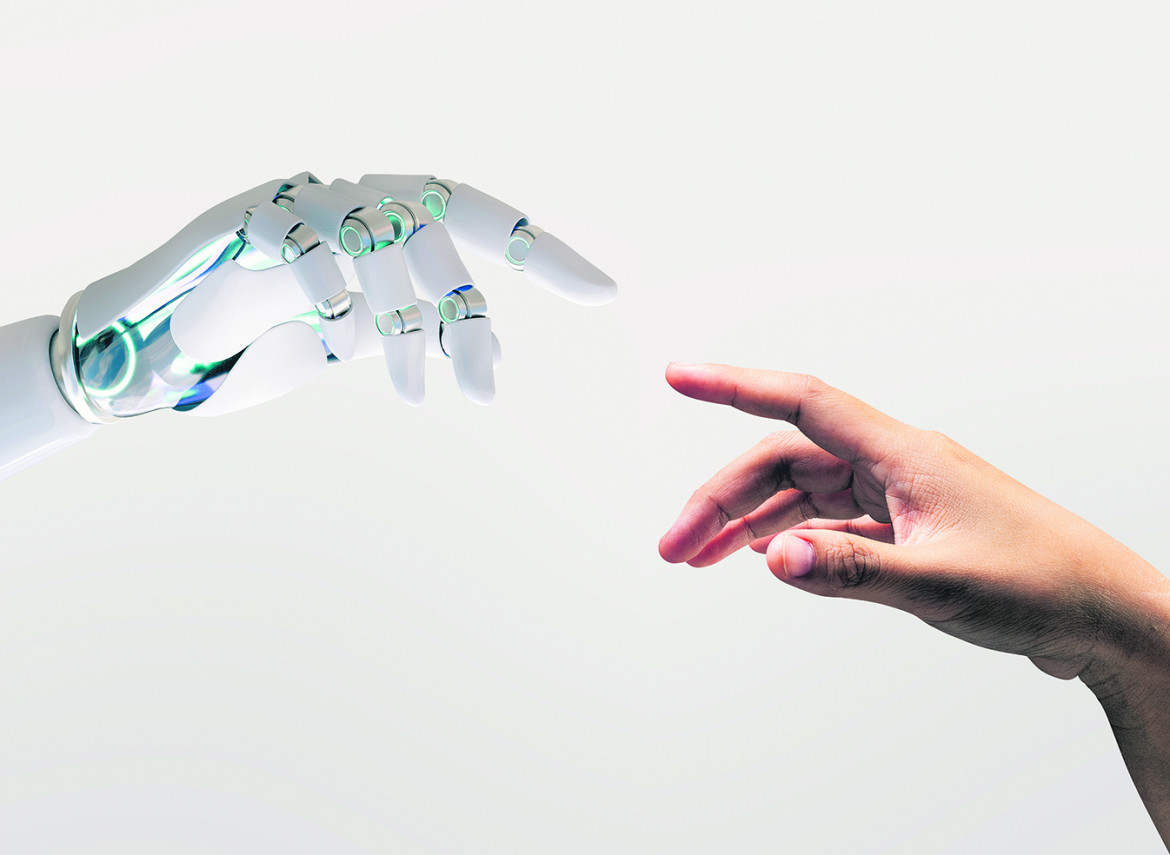
Mnemosyne e dintorni Per comprendere cosa significhi la memoria bisogna necessariamente indagare, o forse sarebbe meglio dire indagarla, nella sua relazione con l’eternità...
«E, infatti, nelle laminette orfiche si dice ’sono riarso dalla sete e muoio, ma datemi la fredda acqua che sgorga dalla palude di Mnemosyne’. Quest’ultima, la memoria, disseta l’uomo, gli dà la vita, lo libera dall’arsura di morte. Con l’aiuto della memoria «sarai un dio anziché un mortale». Memoria, vita, dio sono la conquista misterica contro l’oblio, la morte. Recuperando l’abisso del passato l’uomo si identifica con Dioniso».
Così G. Colli introduce la visione antica che lega rinascita e memoria. La natura misteriosa dei ricordi ha sempre affascinato l’umanità. Dai Riti Misterici dell’antichità, che promettevano agli iniziati una rinascita nell’eternità dello Spirito Universale, sino al cristianesimo che afferma la resurrezione dei morti nella carne attraverso il ricordo ritualizzato della vita, morte e resurrezione del Cristo, questa fascinazione universale si è espressa in varie forme, filosofiche, religiose, artistiche, sino a cercare anche nella tecnologia le sue risposte.
Breve storia dell’eternità
E allora, come dice giustamente J. L. Borges nel suo Storia dell’eternità, per comprendere cosa significhi la memoria bisogna necessariamente indagare, o forse sarebbe meglio dire indagarla, nella sua relazione con l’eternità. Il veggente cieco di Buenos Aires riassume tutto questo nell’incipit del suo racconto L’Aleph: «L’incandescente mattina di febbraio in cui Beatriz Viterbo morì , notai che le armature di ferro di piazza della Costituzione avevano cambiato non so quale avviso di sigarette; il fatto mi dolse, perché compresi che l’incessante e vasto universo già si separava da lei e che quel mutamento era il primo d’una serie infinita».
La filosofia, la scienza e la religione, si interrogano vicendevolmente da sempre sulla natura del tempo eterno, di questa infinità al di là di qualunque misurazione convenzionale, indipendente da ogni fattore condizionante: un tempo in sé. Molte tradizioni sapienziali si sono impegnate a descriverlo: in oriente tutte le filosofie del risveglio lo hanno trattato come il luogo soggettivo nel quale avviene l’esistenza liberata dalla ruota della causalità (samsara). Nel buddismo Zen, ad esempio, come ci ricorda A. Watts nel suo celebre La via dello Zen, vero manuale della beat generation, l’illuminazione, il satori della comprensione totale, si genera nell’esperienza istantanea di tempo assoluto.
Per i Vedanta indù il tempo del divenire differisce da quello dello Spirito poiché è mutevole in forma e contenuto, a seconda degli stadi della manifestazione individuale. In Occidente anche un padre della chiesa come Agostino, in cerca del «tempo di Dio», si ferma dinanzi alla definizione del tempo oggettivo: «Il tempo lo comprendo sinché non ne parlo». Questo tempo assoluto, dunque, viene identificato con l’eternità stessa – il tempo che contiene tutto il tempo – e allora, immancabilmente, ci si è interrogati sulla natura del suo scorrere che, secondo Parmenide è illusoria poiché esso: «Non è mai stato, né mai sarà, perché sempre è», sancendo così la sua oggettiva eternità nell’immobilità, come afferma specularmente Eraclito l’Oscuro che ne postula l’immutabilità nel movimento perenne: il panta rei a lui indirettamente attribuito.
Ma i due grandi «filosofi sovraumani», come li definiva G. Colli, parlano dello stesso tempo? Dello stesso scorrere? Lasciamo ancora una volta al Maestro di Buenos Aires il piacere di condurci per mano nel fluire del tempo, alla cui soggettività poetica l’autore dedica il suo personalissimo ed illuminante pensiero: «Se il tempo è un processo mentale, come possono condividerlo migliaia di uomini o anche solo due uomini diversi?».
È la stessa contraddizione che porta lo scultore Rodin a dire che la pittura ha «ragione» e la fotografia «torto», perché il cavallo dipinto in corsa suggerisce «la metamorfosi del tempo» – dato che non accampa nessuna pretesa di descriverne oggettivamente la realtà – mentre la foto immobilizza gli istanti di ciò che non si può, né si deve, fermare, come ci ricorda Merleau-Ponty. In realtà queste metafore, perché tali sono, coincidono tutte nella impossibilità di designare un tempo oggettivo, che esista al di fuori delle scansioni arbitrarie, soggettive. Anche Heidegger fa notare che «l’esserci ha il suo tempo» il suo esserci. Bergson, nella riflessione sulla durata, sovrappone il tempo alla vita interiore, assolutamente soggettiva e mutevole in ogni istante. Anche Marx – nel tentativo di comprendere le ragioni del capitale – si è applicato all’analisi del tempo alienato del lavoratore massificato e della sua liberazione, concludendo che il tempo oggettivato è una delle funzioni fondamentali della produzione capitalista, e che la liberazione del tempo sarà una componente del suo superamento.
Eppure, ancora una volta, è il genio poetico e poietico di Borges ad offrirci una sintesi nella quale, forse, tutti nel profondo ci riconosciamo; dicono gli ultimi versi della sua Fine d’anno: «Generale e confuso dall’enigma del Tempo; è lo stupore davanti al miracolo che, malgrado gli infiniti azzardi, che malgrado siamo le gocce del fiume di Eraclito, perduri qualcosa in noi: immobile».
La Ninfa di Warburg
E dunque, se così stanno le cose, possiamo dire che il tempo è una variabile soggettiva che, però, ci situa contemporaneamente nel passato, nel presente e nel futuro. Qui, allora, entra in gioco il ruolo del ricordo, di quel tempo passato che qualcosa può far rivivere nel presente e, perché no, proiettare verso il futuro. Un buon esempio ne è certamente l’inclinazione di Aby Warburg che, nel suo celebre atlante Mnemosyne, descrive la forza analogica dell’Urphänomen: il «fenomeno originario», che egli attribuisce paradigmaticamente a Ninfa.
Questo studioso di storia dell’arte, che si definiva «ebreo di sangue, amburghese di cuore, fiorentino di anima» arriva, mediante un’originale ricerca sul significato archetipico di alcuni stilemi posturali, ad individuare il particolare potere di figure che, facendo un allusivo riferimento a questi, ne ricreano e tramandano il pathos originario, la loro essenza eterna pur nelle variazioni formali di epoca in epoca: non a caso chiama il suo atlante come la divinità della memoria.
Per Warburg, tra immagine riprodotta – le varie immagini della ninfa proposte nell’atlante – ed il «fenomeno originario» Ninfa, cioè l’archetipo della sensualità misteriosa e naturale, si crea una continuità emozionale. Ninfa diventa allora una Pathosformel, cioè una immagine «formula di pathos», catalizzatrice di senso e sensuosità, trasportatrice, attraverso il tempo ed i tempi, sempre dello stesso contenuto originario – il suo Ur appunto – seppur rappresentato da gesti e figurazioni analoghe. E cos’è questo Ur se non la «trama nascosta», l’ousía platonica che la figura ha il potere di mostrare in transito, e dunque in analogia, attraverso un continuum che lo propaga, lo metaforizza, universalmente seppur attraverso forme diverse?
«Ninfa, Aura, Gradiva, dove vanno le ninfe di quel sottile pantheon (pantheon della memoria e del tempo, del vento e del panneggio, del lutto e del desiderio)? Qual è lo scopo del loro passo danzante? Dove si fisserà la loro grazia fondamentale? Non ha senso porsi queste domande. Ninfa non va mai da ‘qualche parte’. Appare sempre nel presente dello sguardo e questa apparizione svela un eterno ritorno. Non ha senso nemmeno chiedersi dove Ninfa inizi la sua corsa, né dove finirà. Per Warburg, Ninfa designa l’eroina impersonale del Nachleben, la ‘sopravvivenza’ di quelle paradossali cose del tempo, appena esistenti e tuttavia indistruttibili, che vengono a noi da lontano», dice Didi-Huberman.
Ed è in forza di questo stesso, paradossale, «presente dello sguardo», che Ninfa riesce ad addensare, ed a trasmettere nel tempo e nei tempi, l’ousía nelle sue analoghe manifestazioni – il pathos della figura paradigmatica – ed a conservare l’enigma del transito, in «quelle paradossali cose del tempo, appena esistenti e tuttavia indistruttibili, che vengono a noi da lontano». È, allora, in virtù di questi «operatori» che Ninfa diviene un analogon, poiché essa ha la capacità di mostrare il suo Ur; in altre parole, portarsi appresso la suggestione della «trama nascosta» eraclitea, ricordandoci al tempo stesso che: «Ciascun fenomeno si tiene in relazione con innumerevoli altri, nel modo in cui diciamo, di un punto luminoso liberamente oscillante, che esso manda i suoi raggi in ogni direzione», come fa notare G. Agamben.
È così, ad un tratto, illuminati dalla luce del tempo che emana da queste forme empatiche, ci accorgessimo che il ricordo è formato da un intreccio di cose sino a quel momento nascosto e che, ripercorrendone la trama a partire anche da una sola di esse, noi ci si possa orientare tanto da percepire, come un riflesso, la sua Immagine completa. Dice ancora Didi-Huberman: «Per portare alla luce una funzione così cruciale – così antropologicamente formativa delle immagini, occorre aprire gli occhi su tutto ciò che passa, secondo il concetto benjaminiano dello «storico straccivendolo» . Ma occorre anche chiudere gli occhi per lasciar venire a noi i blocchi di relazioni, le condensazioni, gli spostamenti, le genealogie inosservabili a occhio nudo . Se è vero che Warburg, prima di Benjamin, chiede alla storia delle immagini di assumersi il compito di «interpretare i sogni» (die Aufgabe der Traumdeutung) allora si deve accettare che l’interprete diventi parte ricevente».
I Thanabot
E allora, se Aby Warburg fosse ancora vivo, così come Benjamin che riteneva il cinema e la fotografia dispositivi per mortificare l’aura delle immagini, la loro unicità sacrale, cosa ci direbbero della realtà dei cosiddetti dispositivi thanabot, parola che lega insieme il termine thanatos, morte in greco e bot derivato dalla tecnologia informatica. Il bot (a sua volta abbreviazione di robot) è un programma che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti, ad esempio quando si navigazione nel web, per i messaggi in una chat, nei videogiochi, e così via. Con bot si può inoltre designare un programma che, nei social, fa credere all’utente di comunicare con un’altra persona. Questi programmi migliorano continuamente la loro interazione, per cui diventa sempre più difficile distinguere un bot da una persona reale; direbbe Warburg l’Ur dalla sua attualizzazione o, per usare una parola cara a Benjamin, dalla sua riproducibilità.
Nel caso dei thanabot si è utilizzata ChatGPT, lo strumento sviluppato da OpenAI, per riprodurre le caratteristiche comunicative delle persone defunte. Nello specifico si tratta di caricare sul programma di intelligenza artificiale un numero adeguato di particolari inerenti alla biografia della persona defunta: fotografie e audiovisivi, audio registrati, testi scritti e via enumerando. ChatGPT sembra in grado di replicare, rielaborando tutto questo materiale, lo stile ed il modo di comunicare del soggetto morto. Se a questo si aggiunge la possibilità di riprodurre perfettamente la voce dello stesso, si può vivere l’illusione di continuare, in qualche modo, a comunicare con il trapassato. Una sorta di evoluzione dell’album di fotografie e del fonografo, come fa notare il tanatologo D. Sisto nel suo La morte si fa social.
Se la sola voce riprodotta non bastasse ancora, è disposizione il Life Story Avatar, la versione interattiva di una biografia personale. L’applicazione, facilmente reperibile in rete, si chiama Here After AI. Si presenta come una raccolta di memorie personali in cui inserire episodi della propria vita, fotografie, risposte ad eventuali domande. L’IA rielabora il tutto rendendolo interattivo sia con se stessi, sia con chi si vuole, rispondendo ad eventuali domande dei terzi con la voce campionata del soggetto. A completamento di questa già disponibile possibilità, chi può permetterselo aggiunge una immagine olografica, già molto usata per riesumare cantanti, o divi del cinema defunti per farli comparire in spettacoli. Chi fosse transitato ultimamente per gli Studios di Hollywood avrebbe visto un intero show di ologrammi, da quello di Vim Diesel che spunta dal sottosuolo con la sua famiglia di Fast and Furiouos, ad una intera troupe di ballerini.
Questa modalità di registrazione in ambito virtuale fa sì che ogni dato permanga, in questo modo, a prescindere dalla vita o dalla morte del soggetto che l’ha prodotto. Facebook, o Istagram, per esempio, contengono al loro interno decine di milioni di profili di utenti già deceduti: una specie di enciclopedia digitale dei trapassati o, se si vuole, nel futuro prossimo, un reliquiario virtuale, un neo-luogo nel cyberspazio decisamente distopico, secondo la nota definizione di Foucault, in quanto includerà più profili di utenti trapassati che in vita; una sorta di aldilà digitale popolato da tracce spettrali condannate, come in un inedito girone dantesco, a ripetersi senza sosta senza mai nulla di nuovo.
L’ultima domanda
E se un giorno, arrivati a quelle che viene definita la «singolarità», cioè il momento in cui l’IA diventerà cosciente e probabilmente supererà quelle umana, forse ciò che rimarrà dell’umanità saranno solo queste vite fatte da ricordi passati. A questo proposito vale la pena chiudere citando un racconto di Asimov del 1956, L’ultima domanda. È la storia dell’evoluzione di un super computer chiamato Multivac o AC e del suo rapporto con l’umanità, narrata attraverso sette diverse fasi temporali; la prima è ambientata nell’anno 2061. Considerando che le previsioni del futurologo R. Kurtzweil sulla «singolarità», danno il fenomeno nel 2045, Asimov sembra essere consonante con questa previsione. In ognuna delle prime sei ambientazioni uno dei personaggi pone al computer una domanda, cioè come si possa affrontare la minaccia alla sopravvivenza umana causata dalla morte termica dell’universo, come a dire: può la seconda legge della termodinamica essere invertita? Ma ogni volta il computer si trova nell’incapacità di rispondere per mancanza di dati sufficienti. Segue una evoluzione del computer fino al capitolo finale, in cui il Multivac, unica entità ancora senziente in un universo ormai spento, dopo aver raccolto dall’estinzione di ogni singolo atomo di materia tutti i dati possibili, finalmente trova la risposta all’ultima domanda. E così, alla fine, AC riesce a ricreare un nuovo universo: «Per un altro intervallo senza tempo, AC pensò come potesse al meglio approdare a una conclusione. Organizzò con cura il programma. AC metteva insieme con cognizione di causa tutto ciò che un tempo era stato un Universo e ponderava ciò che ora era un Caos. Un passo dopo l’altro, una soluzione ci dev’essere. Ed ecco che AC disse: «La luce sia!» E la luce fu…».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




