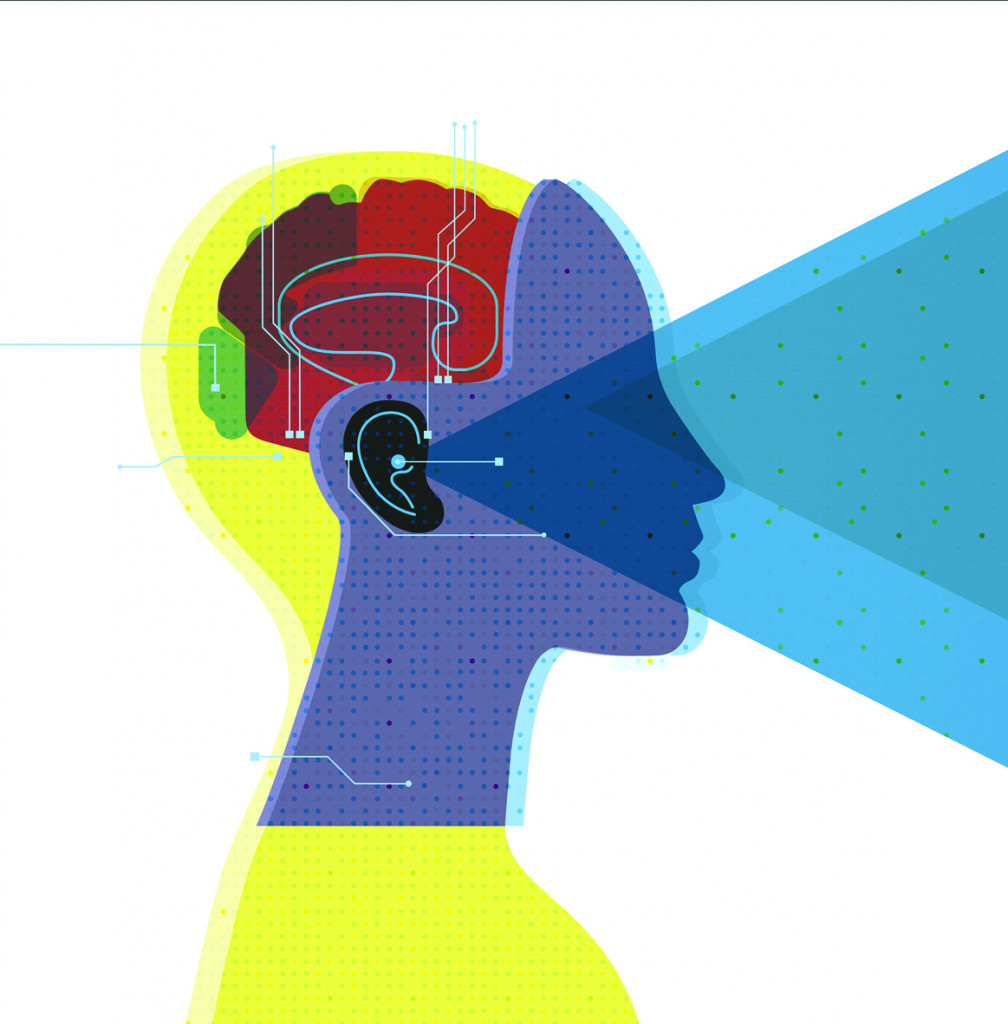Ken Kalfus, concrete distopie tra stelle e strisce
Festivaletteratura Intervista all’autore di «Le due del mattino a Little America», edito da Fandango. «Travisare di continuo la verità oggettiva ha fatto crollare la società americana: nel mio romanzo interrogo le nostre vite immerse nelle fake news». Lo scrittore di New York interviene domenica a Mantova alla vigilia dell’anniversario dell’11 settembre insieme a Giancarlo De Cataldo
 «The Sphere» di Fritz Koenig, posta per alcuni anni nel Battery Park di New York in omaggio alle vittime dell’11 settembre
«The Sphere» di Fritz Koenig, posta per alcuni anni nel Battery Park di New York in omaggio alle vittime dell’11 settembreFestivaletteratura Intervista all’autore di «Le due del mattino a Little America», edito da Fandango. «Travisare di continuo la verità oggettiva ha fatto crollare la società americana: nel mio romanzo interrogo le nostre vite immerse nelle fake news». Lo scrittore di New York interviene domenica a Mantova alla vigilia dell’anniversario dell’11 settembre insieme a Giancarlo De Cataldo
La società americana è implosa, le radicali contrapposizioni politiche cresciute negli ultimi anni si sono trasformate in una autentica guerra civile. E in molti, come Ron Patterson, hanno preso la strada dell’esilio pur di non dover uccidere o essere uccisi da dei vicini di casa o da un amico d’infanzia. Così, passando da un Paese all’altro, inseguito dalla stigmate che l’essere americano comporta – gli Usa che hanno dato a lungo lezioni al mondo sono ormai considerati un coacervo di derive e disgrazie, si scopre ad ammettere Ron -, cerca di sopravvivere e di far fronte all’ostilità verso gli stranieri che cresce via via anche nelle nazioni dove ha cercato rifugio. Un’esistenza solitaria e malinconica, che si nutre solo dei ricordi del passato, nella quale farà la sua apparizione dapprima una donna, anch’essa emigrata da un altro Paese, Marlise, e quindi una piccola comunità di esuli statunitensi che cercano di ricreare a decine di migliaia di chilometri da casa qualcosa che assomigli, più che all’America che hanno lasciato, alle proprie vite perdute e agli affetti che ne facevano parte.
In Le due del mattino a Little America (Fandango, pp. 230, euro 19,50), grazie al suo stile ineffabile, dove realtà e distopia, cronaca e satira si intrecciano inestricabilmente, Kalfus costruisce il racconto di un Paese forse possibile nel futuro, o meglio di ciò che resta di quello che è stato e della sua storia. Nato a New York nel 1954 in una famiglia di ebrei provenienti della Russia zarista, a lungo giornalista, Kalfus è da tempo una delle voci più innovative e stimolanti della letteratura statunitense. Nei suoi romanzi e raccolte di racconti – tra cui, editi da Fandango, Sete (2002), Uno stato particolare di disordine (2006), Plutonio 239 e altre fantasie russe (2011), Il compagno Astapov (2010) – l’indagine narrativa mette sempre in qualche modo in discussione ciò che del mondo circostante siamo soliti dare per scontato. Al Festivaletteratura di Mantova partecipa domenica all’incontro «Distopica America», insieme a Giancarlo De Cataldo (14,30, Palazzo Ducale).

Il protagonista del romanzo, Ron Patterson, è in fuga da un Paese all’altro ma porta con sé ovunque l’immagine negativa che gli Usa si sono costruiti nel mondo. Costretto all’esilio, convive con l’ombra ingombrante del mondo da cui proviene?
Molti miei concittadini non riconoscono ancora come sia già da tempo che l’America sta costruendo la propria immagine negativa. Sebbene Ron si consideri apolitico, i suoi viaggi da migrante lo hanno reso sensibile verso questa sorta di gioia globale per le disgrazie altrui con cui si guarda al Paese da cui proviene. Così, come scrivo nel libro, scopre che «le persone in tutto il mondo condividevano il disprezzo per quanto in basso fosse caduto il nostro Paese. Parte di quel disprezzo veniva espresso con piacere. Ricordavano il nostro antico orgoglio nazionale, che già allora avevano considerato vano e arrogante. Ricordavano anche come avevamo dominato la politica internazionale e la cultura popolare globale e i numerosi errori, o crimini, che avevamo commesso in patria e all’estero». Così, a volte Ron trova conveniente dire che è canadese.
Attraverso la figura di Ron, e della comunità di esuli statunitensi di Little America, quella che è stata definita come una «cultura-mondo» – tra i tanti, Serge Latouche ha parlato di «americanizzazione del mondo» – fa per la prima volta l’esperienza di essere minoranza?
Una delle idee che esprimo nel libro è che l’«americanizzazione» finirà con l’America. Se esiste ancora una cultura mondiale, nel mondo in cui è ambientato il romanzo, questa non include la musica americana, i jeans e le scarpe da ginnastica americani, i costumi americani o gli hamburger americani. Le persone hanno persino smesso di parlare inglese. Ovviamente, questa è pura fantasia: se gli Stati Uniti svanissero avremmo ancora una cultura mondiale dominata dagli americani, per non parlare di un miliardo di anglofoni globali. Ma spero che i miei lettori non diano per scontato o permanente questo dominio culturale. Come americano che ha avuto il privilegio di vivere anche all’estero, non sono mai stato troppo lontano dagli atteggiamenti culturali e dalle pratiche comuni della vita del mio Paese. Ma per coloro che sono costretti ad emigrare, o sono rifugiati, può essere doloroso e disorientante lottare per la sopravvivenza all’interno di società radicalmente diverse e con «strani» costumi. Per questo i migranti americani che racconto cercano di ricreare la loro società in miniatura, a partire dai consumi che gli erano propri, come lo frozen yogurt. Spero che i lettori apprezzino la satira in tutto ciò.
Nell’incertezza che domina la vita di Ron, anche a causa di norme inumane e della diffusione della xenofobia, si coglie un’eco dei milioni di migranti che vivono negli Usa ma non diventeranno mai cittadini americani. Questa è anche la loro storia?
La situazione dei migranti americani del libro non è dura come quella di chi sta cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraverso il confine meridionale. Allo stesso modo, anche i migranti che fuggono dall’Africa verso l’Europa affrontano enormi privazioni, per loro è questione di vita o di morte. Certo, i migranti del romanzo si trovano in difficoltà, ma ero più interessato ad esplorare le loro esperienze in termini di perdita e di spostamento da un luogo all’altro. Scrivendo, pensavo alla Jugoslavia e alla diaspora balcanica, non per minimizzare le difficoltà affrontate da quei migranti, ma per riflettere sulle nuove vite e sulle comunità che hanno costruito all’estero. Ricordavo anche i miei nonni, fuggiti dai pogrom antiebraici in Russia per venire a New York. Anche loro erano disorientati e si sentivano estranei, eppure riuscirono a costruire per sé delle vite americane
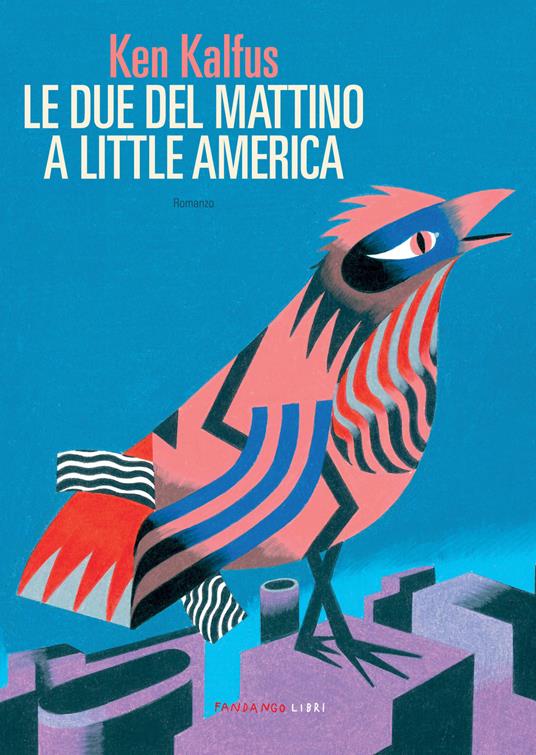
Mi sono sempre ripromesso di vedere quel film. E anche il mio romanzo ha toni da commedia. Del resto, se si guardasse all’oggi diciamo dalla prospettiva di 25 anni fa, penso che molte persone direbbero che siamo già gradualmente scivolati in una realtà distopica, segnata da gravi cambiamenti climatici e incendi, guerre, migrazioni di massa disperate, radicalizzazione delle divisioni politiche nella vita quotidiana e sorveglianza diffusa. Poi, in particolare in America si soffre a causa di autentiche «epidemie» infernali come la dipendenza da oppioidi e la violenza armata. Ho iniziato a scrivere il libro prima dell’insurrezione del 6 gennaio, anche se ovviamente gli eventi di quel giorno peseranno nella mente dei lettori. Mentre ci avviciniamo ai processi di Trump e alle elezioni presidenziali, un conflitto civile e un’implosione del Paese sembrano possibili. Credo, tuttavia, che questo conflitto sia evitabile e che si possano superare anche le altre sfide che il mondo deve affrontare.
Italo Calvino, un autore che le è caro – e di cui il 15 ottobre ricorre il centenario della nascita – parlava della «funzione esistenziale» della letteratura, attraverso cui è possibile svelare la realtà. Per lei dove si situa il confine tra letteratura e realtà, specie in questi anni dominati dalla «post-verità» o dalle fake news?
L’opera di Calvino è uno dei momenti salienti della mia vita di lettore, a cui torno più e più volte per trarre ispirazione. Sono stato felice di averlo sentito leggere la sua storia Ice sulla 92nd Street Y di New York. Nella mia prima raccolta di racconti, Sete, ho scritto una piccola parodia-omaggio a Calvino, «Centri commerciali invisibili». Quanto alla sua domanda, la speranza per gli scrittori è sempre quella di utilizzare gli strumenti del linguaggio per scavare in profondità nella struttura della realtà: raccontare la vita così come è vissuta, la storia come è vissuta, l’universo come è realmente organizzato. È vero, viviamo nell’epoca della «post-verità», in cui le persone si basano sulle loro «verità personali» e discutono di «verità relative». Nel mio romanzo è proprio questo travisare di continuo la verità oggettiva che ha fatto crollare la società americana.
In «Uno stato particolare di disordine» riflette sulla tragedia dell’11 settembre a partire dalla crisi di una coppia di New York, Joyce e Marshall. Insieme alle torri vanno in pezzi anche le nostre certezze quotidiane e quelle di un’intera società?
Sono molto interessato a come i media, soprattutto quelli elettronici, abbiano alterato il rapporto tra individuo e società. Ne Il Compagno Astapov mi concentro sull’ascesa dell’immagine in movimento al servizio della propaganda, nel caso quella cinematografica bolscevica degli anni ’20. E, in qualche modo, sono stato costretto a scrivere Un stato particolare di disordine dal clima mediatico dell’epoca, prima e dopo l’11 settembre: in particolare dai notiziari via cavo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che hanno colonizzato quasi totalmente la nostra immaginazione. Le notizie generate dagli eventi pubblici si sono intrecciate con la nostra vita privata, sono spesso le ultime cose di cui parliamo la sera prima di spegnere la luce. Speravo di rendere in modo drammatico, o forse satirico, il modo in cui siamo diventati ostaggio delle notizie. Ciò accadeva 20 anni fa, e ora il potere della propaganda elettronica e l’effetto totalizzante dei media si sono intensificati, al punto che non possiamo più distinguere ciò che è reale e ciò che non va oltre le narrazioni mediatiche concorrenti cui siamo esposti.
Lei interviene a Mantova alla vigilia dell’11 settembre. Quanto è cambiato il modo degli americani di guardare alla tragedia?
Naturalmente, quando pensiamo a quel dramma, ricordiamo anche le nostre guerre fallimentari in Afghanistan e Iraq. Per molti americani, penso che gli eventi dell’11 settembre, la grande perdita di vite umane, le rovine fumanti e le sirene continue nelle nostre strade abbiano rappresentato i primi giorni della realtà distopica di cui parlavamo prima. Forse viviamo ancora in quel mondo, ma la storia non finisce mai. E nuovi mondi sono possibili, sia buoni che cattivi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento