Katja Petrowskaja, l’empatia come la memoria è scritta anche sui corpi
L'intervista Parla la scrittrice nata a Kiev, autrice di «Forse Esther» (Adelphi), tra gli ospiti di Libri Come che si apre domani a Roma. Domenica alle 20,30 partecipa all’incontro «Il potere della scrittura». «Mia madre ha 87 anni, parte della sua famiglia fu uccisa dai nazisti. Lei fuggì negli Urali. Non riesce a credere che la Russia sia diventata una dittatura fascista». «Dal giorno dell’invasione molti berlinesi si sono mobilitati per accogliere i profughi ucraini. Partecipo anch’io. Non si tratta solo di aiutare gli altri, ma di restare umani»
 La scrittrice Katja Petrowskaja – foto Ap
La scrittrice Katja Petrowskaja – foto ApL'intervista Parla la scrittrice nata a Kiev, autrice di «Forse Esther» (Adelphi), tra gli ospiti di Libri Come che si apre domani a Roma. Domenica alle 20,30 partecipa all’incontro «Il potere della scrittura». «Mia madre ha 87 anni, parte della sua famiglia fu uccisa dai nazisti. Lei fuggì negli Urali. Non riesce a credere che la Russia sia diventata una dittatura fascista». «Dal giorno dell’invasione molti berlinesi si sono mobilitati per accogliere i profughi ucraini. Partecipo anch’io. Non si tratta solo di aiutare gli altri, ma di restare umani»
Nel suo romanzo Forse Esther, recentemente riproposto da Adelphi (traduzione di Ada Vigliani, pp. 241, euro 12), Katja Petrowskaja guidava il lettore in una sorta di viaggio iniziatico attraverso il mondo perduto dell’ebraismo dell’Europa centro-orientale, ripercorrendo a ritroso l’albero genealogico della propria famiglia che da Vienna a Varsavia, da Odessa a Kiev, dagli shtetl della campagna polacca alla Mosca della rivoluzione bolscevica, racconta delle ferite e delle speranze sorte nel cuore d’Europa e di quanti, sopravvissuti alla Shoah, hanno creduto nella nascita dell’uomo nuovo sovietico per poi subire il tragico contraccolpo dell’avvento dello stalinismo. Nata (nel 1970) e cresciuta a Kiev, e dal 1999 stabilmente a Berlino, Petrowskaja è tra le protagoniste di Libri Come che si apre domani all’Auditorium Parco della Musica di Roma – parteciperà domenica alle 20,30 al Teatro Studio Borgna all’incontro dal titolo «Il potere della scrittura».
Per scrivere «Forse Esther» è tornata fisicamente nei luoghi dove l’Olocausto e il terrore staliniano avevano cambiato il corso delle vita dei suoi famigliari. Cosa prova ora di fronte al fatto che i luoghi della sua infanzia, come Kiev o Bucha, sono teatro di crimini terribili?
Vivendo a Berlino affronto le tracce della Seconda guerra mondiale nella stessa topografia della città. E forse la mia origine le «attiva» e le rende più affilate. Considero il mio libro come la storia di una persona che inciampa nella guerra mondiale mentre attraversa l’Europa. La memoria è una sensazione corporea. Sono cresciuta in una città dove 100mila persone sono state uccise in un fossato di periferia. Ora questo luogo si trova praticamente in centro, tra una stazione della metropolitana e una chiesa del XII secolo. Come vivere in una città così? Chi deve trasmettere la memoria? Quanto a Bucha, ciò che è accaduto va al di là di ogni tentativo di comprensione. Mi chiede come mi sento? Provi solo a immaginare che alle porte di Firenze ci sia una colonna di 60 chilometri di carri armati; nel nostro caso pronti ad entrare in una città di 3 milioni di abitanti. Lì ci sono tutti i miei amici. E da bambina trascorrevo molto tempo a Bucha. C’è un bellissimo lago con un’isola nel mezzo, e con un amico amiamo trascorrervi le giornate. Ora, riesce ad immaginare una fossa comune in Toscana? Delle persone uccise in quel modo?
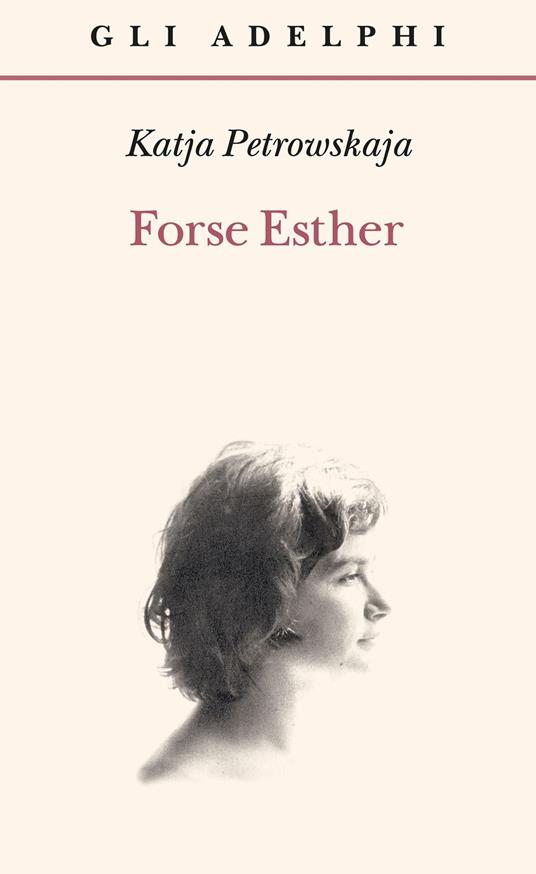
Scontro tra nazionalismi? Chi lo può affermare dopo un anno di questa guerra insensata? Suona cinico. C’è differenza tra vittima e invasore. Una dittatura ha invaso un Paese democratico che non ha mai iniziato nessuna guerra. L’Ucraina poteva essere una potenza nucleare, ma nel 1994 ci ha rinunciato unilateralmente purché fosse garantita la sua sovranità nazionale. Nel frattempo, a partire dalla Seconda guerra cecena, in Russia si sono ridotte le libertà democratiche all’interno, mentre si è esportata la guerra all’esterno: l’unico modo per Putin per rimanere al potere. Una costante escalation: la Georgia nel 2008, Crimea e Ucraina orientale nel 2014, quindi la Siria e ora la guerra su vasta scala contro l’Ucraina. E l’Europa, che ha provato a negoziare con Putin – che però andava fermato già 20 anni fa in Cecenia – è responsabile di come si è costruita la guerra in corso ed è perciò responsabile del destino dell’Ucraina. È incredibile come molte persone in Europa non capiscano che gli ucraini stanno fermando l’esercito di Putin con i loro corpi e hanno bisogno di più armi solo per non morire. Stanno lottando per la propria sopravvivenza fisica, non solo per la loro dignità. Molte città non esistono più, sono state rase al suolo dall’esercito russo: forse renderle un deserto è un’idea di liberazione. Una volta Putin ha detto che vuole riportare l’Ucraina all’età della pietra. Non sta ottenendo il successo sul campo di battaglia e quindi il suo esercito sta bombardando le case con dentro le persone che dormono e le infrastrutture per rovinare la vita degli abitanti. Ovviamente tutti vogliamo che questa guerra finisca, ma c’è solo un modo: la sconfitta russa, il ritiro delle truppe di Putin. Abbiamo già visto cosa significa la «pace» russa: camere di tortura, case in rovina, luoghi della cultura distrutti e fosse comuni. Mia madre, che ha 87 anni, ed è stata per 60 anni insegnante di storia a Kiev, ora è rifugiata e vive con me a Berlino. Parte della sua famiglia fu uccisa nel 1941 dai nazisti, lei con sua madre fuggirono negli Urali. Potete immaginare cosa significhi per lei assistere a come la Russia si sia trasformata in una dittatura fascista.
Le radici della sua famiglia sono nell’yiddishland spazzato via dalla Shoah ma anche nell’idea della costruzione di una nuova società poi naufragata in Urss. Parla russo, ucraino e ha scritto il suo libro più noto nella «lingua del nemico», il tedesco. A partire dalla sua esperienza come racconterebbe la società ucraina di oggi?
Ho scritto il mio primo libro in tedesco per renderlo innocente ai miei occhi. «Lingua del nemico» è solo una citazione, non un’affermazione, adoro la letteratura romantica tedesca, e quindi so che non è la lingua ad essere colpevole, ma le persone che ne fanno un uso improprio. Quanto alla società ucraina, non è facile descriverla, perché si tratta di un Paese molto vario e più grande della Germania. L’Ucraina è indipendente dall’inizio degli anni ’90, ma per molti europei è ancora difficile capire che esprime una propria soggettività, il diritto di decidere da sé. Per capire davvero forse si deve considerare il fenomeno più importante dell’Ucraina odierna: il fatto che si tratta di una società formata da individui che vogliono prendere da soli le decisioni. Non Zelensky o i ministeri. E questo spiega anche l’enorme volontà di resistere cui stiamo assistendo. Questa indole è emersa durante le proteste di Maidan, quando centinaia di migliaia di persone sono rimaste in piedi giorno e notte nella piazza principale di Kiev sostenendosi a vicenda, e non si trattava solo di un’unità spirituale, ma di un aiuto concreto, materiale, sopperire alle necessità quotidiane o trovare le medicine: un’esperienza comune di aiuto, protezione, azione. Questa volontà di sopravvivere di ciascuno e, allo stesso tempo, di difendere la condizione umana di tutti è oggi parte fondamentale della società ucraina. E in questa guerra è in pericolo l’intera vita ucraina, aggredita e offesa. Milioni di persone strappate alle loro case, che vivono sotto i bombardamenti o in pericolo costante. L’unico modo per sopravvivere è aiutarsi a vicenda, e vedo una forte tendenza ad aiutare i «dimenticati». Ho amici – e sono poeti e designer – che da Kiev si spostano per portare le medicine alle persone povere di Kherson, nessuno ha detto loro cosa fare, come ai gruppi di volontari che stanno evacuando la gente dalle aree a rischio o portano cibo nei villaggi, ho un’amica che ha cinque figli e si occupa di questo. Alcuni dei miei amici aiutano a ripulire dalle rovine aree come Irpin o Bucha. E , di nuovo, tutto ciò non ha nulla a che fare con il governo o qualsiasi tipo di istituzione: milioni di persone decidono da sole come resistere all’invasione. Non è la vittima, l’Ucraina, che cerca di difendersi ad essere militarista, bensì l’aggressore. Alcuni intellettuali occidentali – anche in Germania – pensano ancora che si possa firmare un trattato di pace con Putin e che l’Ucraina debba arrendersi. E mi chiedo come sia possibile che una parte delle femministe e della sinistra sembrino completamente privi di empatia verso le vittime, con coloro che lottano per la propria libertà e anche di fronte agli stupri delle donne da parte dei russi, quasi incolpino l’’Ucraina per la volontà di resistere, spiegando che questo allontana la pace. Sono molti i pacifisti in Germania come in Italia che pensano che Kiev debba arrendersi. È un modo di ragionare interessante, perché in realtà la vittoria sul fascismo è stata ottenuta con le armi, non con i piccioni: così si è messo fine all’aggressione nazista e all’uccisione di milioni di esseri umani.
Su Telegram c’è un gruppo che si chiama «Berlinesi per gli ucraini», frequentato da migliaia di persone. Lei sta prendendo parte alla rete di solidarietà che è nata fin dall’inizio della guerra: si parla molto dell’invio di armi ma poco di quanto persone come lei stanno facendo ogni giorno concretamente.
Non dimenticherò mai l’inizio della guerra e con quanta spontaneità e generosità la gente a Berlino ha reagito. Forse era una sorta di «sostituzione»: il governo tedesco esitava ma la gente raccoglieva denaro, accoglieva i profughi – faccio ancora fatica a pronunciare questa parola -, organizzava eventi di solidarietà. Centinaia di persone arrivavano alla stazione di Berlino ogni ora e c’era chi accorreva ad accoglierli e aiutarli, persino chi non sapeva una sola parola in ucraino o russo. È uno delle cose che mi ha impressionato di più in tutta la mia vita. E ricordo che ho pensato che accompagnare un vecchio alla toilette della stazione valesse di più di tutti gli eventi culturali organizzati contro la guerra. Conosco molte persone che hanno abbandonato il lavoro per dare una mano, solo per fare qualcosa contro questo dolore infinito. Agire non è solo un aiuto per gli altri, è la via per rimanere umani. Un giorno queste storie dovranno essere raccontate. La resistenza all’aggressione ha creato una sorta di società parallela, ovunque, una specie di «Maidan europeo». Anch’io sto aiutando qualcuno e cerco di non impazzire davanti alla morte di persone che conosco. Tutti hanno già perso. Viviamo contemporaneamente nella guerra e nella pace, mantenendo l’umanità della vita quotidiana e sostenendo le persone che ci difendono.
Lei ha una rubrica sulla fotografia – «Bild der Woche» (foto della settimana) – sul domenicale della «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: quale l’immagine che ha espresso il significato di quanto sta avvenendo in Ucraina?
Non c’è un’immagine sola che può descrivere quanto sta avvenendo. La guerra ha molte facce e produce montagne di dolore. La fotografia testimonia. E la testimonianza esiste accanto a un’altra testimonianza. Ci sono centinaia di giornalisti ora in Ucraina, e ogni soldato ha un telefono in mano, ora abbiamo persino il fenomeno della morte online. Dal 24 febbraio dell’anno scorso scrivo solo sulla guerra, ma non uso mai immagini violente, racconto la storia. È il mio modo di mantenere la guerra «a fuoco» e forse anche un tentativo personale di prendere parte alla resistenza, se posso dirlo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento



