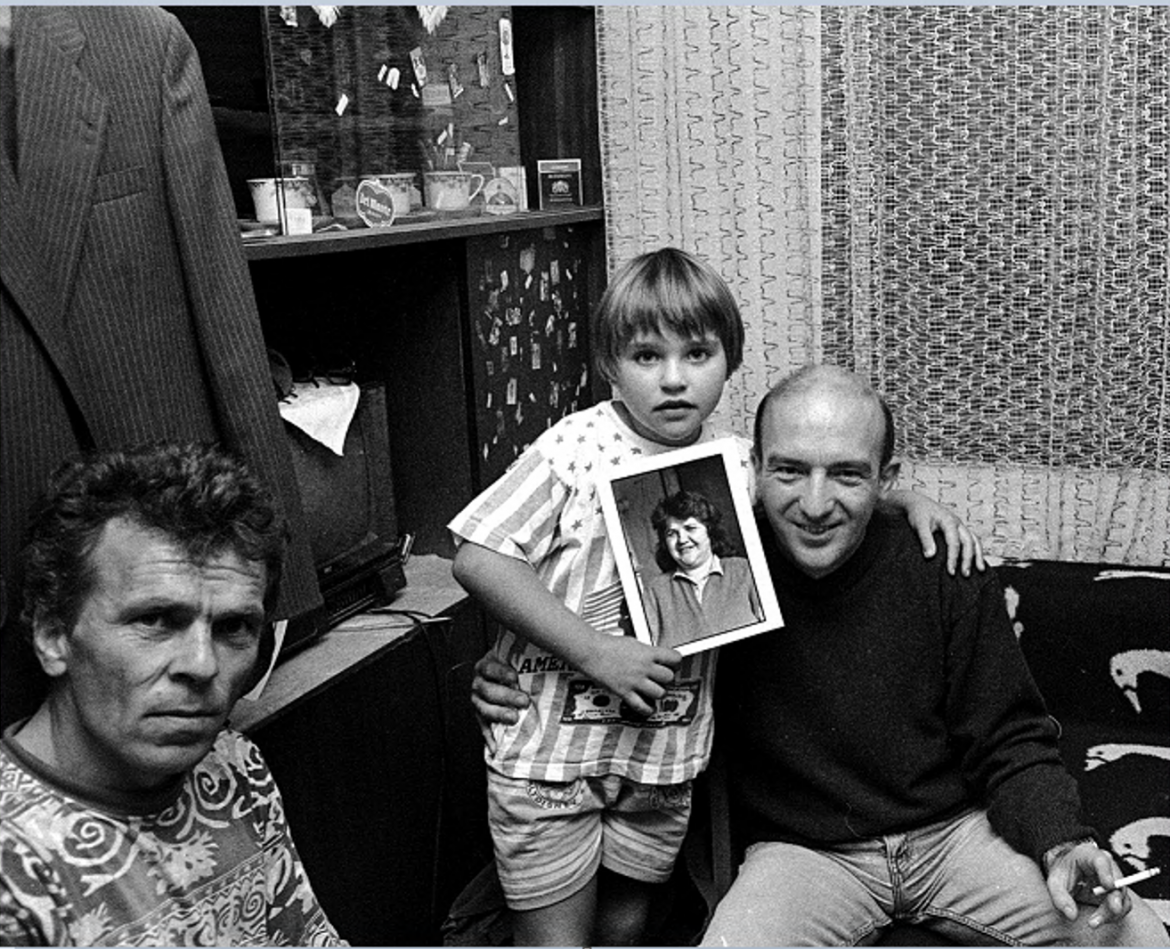Ismail Kadare, l’inverno sui Balcani
Scrittori albanesi Animato da una vena comica, «Il dossier O.» mette in scena due studiosi irlandesi, che nell’Albania più remota registrano e confrontano i canti degli ultimi rapsodi: da La nave di Teseo
 Edi Hila, «Banlieue - l’autre quartier», 2005
Edi Hila, «Banlieue - l’autre quartier», 2005Scrittori albanesi Animato da una vena comica, «Il dossier O.» mette in scena due studiosi irlandesi, che nell’Albania più remota registrano e confrontano i canti degli ultimi rapsodi: da La nave di Teseo
Sebbene arrivi necessariamente dopo il ricordo, un racconto non è il prodotto immediato della memoria. Di un fatto, di una vita, come anche di un romanzo, ciò che davvero resta impresso non è mai la concatenazione degli eventi, ma singoli momenti sparsi, non sempre cruciali e a volte affatto marginali. Immagini di mero contorno se non proprio insignificanti si cristallizzano nella mente come istantanee per motivi non sempre evidenti, condensando il senso di una storia o almeno l’aria che vi si respira, il clima che la definisce.
È evidente che i momenti destinati a imprimersi non sono gli stessi per tutti. Variano da testimone a testimone, da lettore a lettore, in base alla cultura e sensibilità di ognuno, alla fase che il testimone o il lettore sta attraversando e perfino all’umore. Ciò che è comunque secondario. Conta il processo, non l’accidentalità dell’esito, sebbene sia proprio la natura accidentale dell’esito a rivelare la portata di un processo non molto diverso da quello che deve aver segnato il cammino dal racconto orale a quello scritto: Il dossier O. di Ismail Kadare (traduzione di Francesco Buono, La nave di Teseo, pp. 212, € 19,00) lo dimostra in maniera esemplare, affrontando proprio quest’ultima questione.
Il meccanismo dell’oblìo
Malgrado racconti una storia dai contorni molto definiti e abbia un andamento lineare, il romanzo offre parecchi momenti che sembrano sgomitare per imporsi come immagini nella memoria del lettore, a scapito della trama e dell’argomento trattato. Si può avere perfino l’impressione che la storia sia stata concepita quale semplice contenitore per quelli che potremmo definire quadretti, vista la vena comica che anima la narrazione.
Il primo episodio a prendersi con forza la scena arriva dopo appena un paio di pagine, ma con le coordinate della storia già ben tracciate. Due studiosi irlandesi residenti a New York si apprestano a recarsi tra i monti di una sperduta provincia dell’Albania per scovare i rapsodi che ancora tengono viva l’epopea orale. Le autorità del Regno – siamo negli anni Trenta del secolo scorso e il paese è ancora governato dal dispotico Re Zog – esaminano la loro richiesta di visto definendoli prima studiosi di folclore, poi sedicenti studiosi di folclore e infine probabili spie. Che i due viaggino con al seguito uno strano marchingegno di recentissima invenzione per registrare i canti dei rapsodi – il magnetofono o forse magnatafàno – non aiuta certo a fugare i sospetti. Si decide comunque di accoglierli e lasciarli girovagare per un po’, ovviamente sorvegliandoli di nascosto per prenderli con le mani nel sacco.
Non appena la notizia dell’insolita visita arriva nella sperduta provincia tra i monti che interessa ai due, il viceprefetto del posto telefona alla moglie per metterla al corrente. La reazione è di gioia incontenibile, avendo la donna trascorso una mattinata noiosissima: «Come il giorno prima, i vetri erano inondati di pioggia: visti attraverso quelli, i comignoli dei tetti sull’altro lato della strada parevano disegnare delle linee spezzate. ‘Mio Dio, un’altra giornata uguale a ieri,’ aveva detto lei in un sospiro sdraiata sul letto.» Il momento è questo. All’apparenza niente di particolarmente memorabile: un anonimo scorcio invernale chiosato da parole altrettanto banali.
Eppure, nell’immagine della moglie che osserva sconfortata la pioggia e i tetti fuori dalla finestra si colgono già la promessa e i tratti di un personaggio, quelli di una Madame Bovary dei Balcani oppressa dal tedio e matura per una storia sentimentale con uno straniero. Il lettore informato può in effetti riconoscervi anche altro. Allusioni satiriche tanto all’Albania del tempo in cui si svolge la storia quanto a quella comunista di Enver Hoxha, attorno al 1981, l’anno in cui il romanzo è apparso. Oppure l’importanza simbolica che riveste l’inverno per Kadare, tanto che spesso lo si trova già negli incipit dei suoi romanzi, incluso Il dossier O., quasi che questa stagione sia una precondizione obbligata, una metafora imprescindibile dei Balcani e forse della sua condizione di «romanziere normale in un paese anormale», come egli si è definito. Ma il punto vero è un altro. Se la persistenza di dettagli accidentali è la premessa indispensabile per l’esistenza di una storia, nel caso di un romanzo come questo rappresenta molto più. Ciò che preme ai due studiosi di folclore è infatti il «meccanismo dell’oblio».
Si interessano ai rapsodi albanesi perché vedono in loro gli ultimi eredi di una narrazione orale che affonda le radici nell’antica Grecia. Vogliono registrare e confrontare i loro canti, analizzare le differenze tra una versione e l’altra, capire cosa resta immutato e cosa cambia, il tutto nella speranza di risolvere l’enigma di Omero. È una storia quasi vera: i due irlandesi del romanzo sono chiaramente ispirati a Milman Parry e Albert Lord, gli etnografi che nel 1933 si imbarcarono in un’impresa simile andando però in Bosnia. Kadare ebbe la possibilità di parlare con Lord nel 1979 ad Ankara durante un convegno. La conversazione durò soltanto pochi minuti perché all’epoca era pericoloso per un albanese all’estero intrattenersi con uno straniero del blocco occidentale, ma il breve incontrò bastò comunque a porre le basi per il romanzo, uscito a puntate su una rivista l’anno dopo, per poi essere sottoposto a tagli e revisioni fino alla versione definitiva pubblicata in Francia nel 1996, quando lo scrittore viveva ormai da tempo in esilio a Parigi.
Nel passaggio da una stesura all’altra nonché dalla lingua albanese al francese, il testo ha conosciuto variazioni e omissioni esattamente come le conoscono le ballate dei rapsodi. Quanto a Omero, era presente già nel Generale dell’armata morta, se non come problema, almeno come suggestione. In quel romanzo del 1963, dove un militare italiano tornava in Albania vent’anni dopo la guerra per disseppellire e riportare in patria le salme dei caduti credendo di cogliere in quel suo compito una somiglianza con la solennità dei riti funebri descritti nell’Iliade, Kadare ricorreva a una strategia analoga: raccontare il suo paese attraverso gli occhi di uno straniero in cerca di qualcosa tra le fredde e grigie alture dei Balcani, senza realmente capire la realtà che ha intorno.
Una maledizione secolare
È pur vero che gli albanesi non sono da meno, considerando che scambiano gli studiosi per spie. Del resto, in quel crogiolo di popoli e culture diverse, incomprensioni e diffidenze sono una maledizione secolare e anche chi vi è nato può essere visto come un intruso dal vicino: «Per oltre un millennio, albanesi e slavi si erano affrontati senza posa in quei luoghi. Si erano scontrati per le ragioni più diverse, per questioni di terre, confine, pascoli, cascate, e non ci si sarebbe stupiti nello scoprire che perfino gli arcobaleni erano stati oggetti di disputa.» Anche questa strana commedia degli equivoci prende una piega seria, sfociando nella violenza e nel sangue non appena i serbi vengono a sapere che gli studiosi si sono concentrati soltanto sull’epica albanese. La questione omerica resterà ovviamente irrisolta ma è giusto così: in fin dei conti serviva più che altro a raccontare quella balcanica, a sua volta riflesso della questione umana, irrisolvibile per definizione.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento