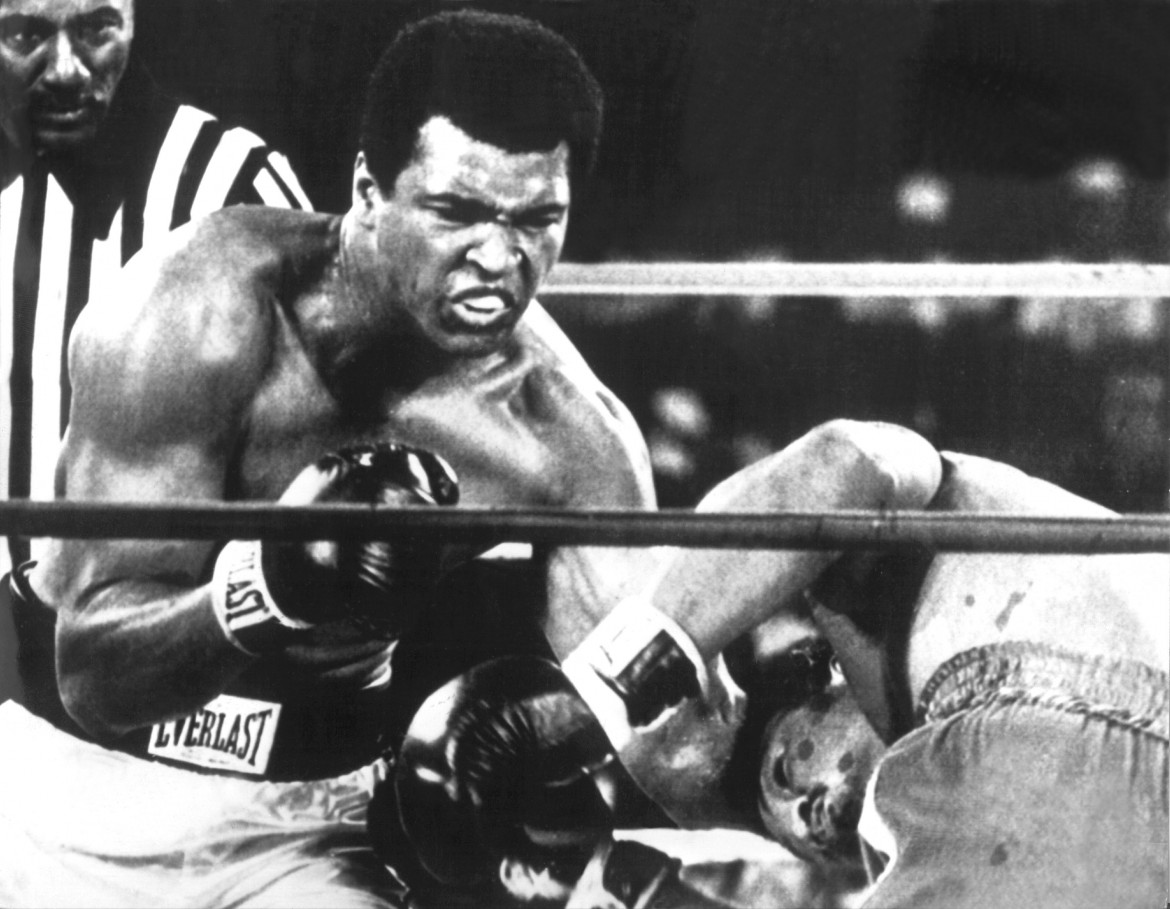Il massacro nero dei partigiani etiopi
Etiopia Viaggio nell’Amazegha Washa, la grotta dei ribelli: a 150 km da Addis Abeba, conserva i resti di migliaia di uomini, donne e bambini gasati dall’occupazione fascista nel 1939. Una storia di resistenza che rischia l’oblio
 Resti umani nell’Amazegna Washa, la «grotta dei ribelli» a Caia Zeret – Franco Zambon
Resti umani nell’Amazegna Washa, la «grotta dei ribelli» a Caia Zeret – Franco ZambonEtiopia Viaggio nell’Amazegha Washa, la grotta dei ribelli: a 150 km da Addis Abeba, conserva i resti di migliaia di uomini, donne e bambini gasati dall’occupazione fascista nel 1939. Una storia di resistenza che rischia l’oblio
Il plateau etiope regala paesaggi mozzafiato. Immensi altipiani che arrivano a 3mila metri di altezza sono incisi da profondi canyon formati da maestosi faraglioni di roccia basaltica. Sferzati dal vento, contadini arano terre sterminate utilizzando ancora aratri di legno, donne amara coperte da candidi sciamma preparano balle di fieno e bambini spronano docili asini carichi di legna.
Nel nord della regione dello Scioa, a 150 km da Addis Abeba, esiste una zona denominata Caia Zeret. Poco distante dal centro abitato di Zemerò, un piccolo agglomerato di tucul chiamato Kampo si affaccia su un dirupo alto circa 180 metri. A metà della parete si apre un gigantesco antro basaltico con un’imboccatura di ottanta metri per cinque. Una ferita orizzontale sull’enorme muro di roccia. È l’Amazegna Washa, la «grotta dei ribelli», teatro di una delle pagine più cupe della storia italiana.
LASCIATA L’AMPIA entrata, l’umidità aumenta e i soffitti si abbassano. Al livello più basso della galleria di destra si incontra un piccolo lago. Zigzagando tra rocce, pipistrelli e insetti, sul terreno ci si imbatte in pietre annerite da quella che pare fuliggine, strani massi con fori apparentemente artificiali e ceste per il trasporto dei cereali. Appaiono bossoli e, infine, ossa umane. Di colpo l’ambiente diviene spettrale.
Le torce illuminano scheletri e vesti corrose. Diversi resti sembrano appartenere a bambini. Su alcuni è presente ancora la pelle, conservata grazie al clima della grotta. Si contano tra i 18 e i 20 corpi, ma è difficile esserne certi.
Nel 1939 la guerra di Etiopia si era ufficialmente conclusa da tre anni. L’incarico di viceré era già passato da Rodolfo Graziani, noto per i suoi metodi brutali, ad Amedeo duca d’Aosta. La resistenza etiope degli Arbegnuoc, supportata dal popolo e guidata da Abebe Aregai, continuava a mettere a dura prova le milizie occupanti, specialmente nello Scioa, zona strategicamente importante. Per questo nel febbraio ’39 scattò «l’operazione grande pulizia» in cui venne usata artiglieria, aviazione e un ingente numero di truppe formate per lo più da ascari eritrei con a capo ufficiali italiani.

Nei primi giorni di aprile gli Arbegnouc sono quasi accerchiati dalle truppe italiane nella zona di Caia Zeret. Mentre le maglie fasciste si stringono inesorabili, il leader partigiano riesce a sfuggire, ma una colonna più vulnerabile guidata da uno dei suoi luogotenenti, Teshome Shancut, viene individuata da un ricognitore dell’aeronautica italiana mentre si dirige verso l’Amazegna Washa. Il gruppo è formato da qualche centinaio di guerriglieri e un gran numero di feriti, anziani, donne e bambini.
IL 3 APRILE inizia l’assedio alla grotta. Gli arbegnuoc oppongono una strenua resistenza che inizialmente ha successo. Le truppe italiane si trovano in difficoltà: le ripide pareti ai lati della caverna sono esposte al fuoco nemico.
Gli ascari usano mitragliatrici, artiglieria, granate e proiettili lacrimogeni, ma non riescono a snidare i partigiani. La situazione è in stallo nonostante l’uso dei lanciafiamme. Dopo sette giorni di assedio il comando decide di chiamare il plotone chimico dal porto di Massawa in Eritrea che giunge con un centinaio di proiettili di artiglieria carichi di arsina e una bomba aeronautica contenente circa 212 chili di iprite. Il 9 aprile il plotone chimico, dopo aver travasato l’iprite all’interno di 12 bidoncini collegati a dei detonatori elettrici, li cala di fronte all’entrata della grotta e li fa esplodere. Così ha inizio l’inferno di Amazegna Washa.
Il contatto iniziale con l’iprite è indolore, ma penetra nella pelle in profondità passando anche attraverso vestiti impermeabili e causa il blocco proliferativo dei tessuti cutanei. Dopo qualche ora la pelle si gonfia in enormi vesciche che poi si trasformano in piaghe che espongono all’aria la carne viva. Il gas provoca gravi emorragie interne. attacca l’apparato respiratorio e causa cecità.
MOLTI DEGLI ARBEGNUOC che si trovano vicino all’entrata della grotta soccombono velocemente, mentre chi si nasconde all’interno subirà gli effetti dell’esposizione successivamente. I rifugiati e i partigiani nell’antro sono allo stremo delle forze. Il gas ha intaccato il lago. Così l’11 aprile la colonna composta da partigiani, donne e bambini comincia a uscire.
Gli uomini, circa 800, vengono immediatamente fucilati a gruppi di cinquanta sull’orlo del burrone, come da ordine supremo del duce, mentre donne e bambini sono trattenuti per breve tempo nei pressi del campo militare italiano e poi liberati ormai moribondi.
È questa la ricostruzione più plausibile del massacro condotto dai reparti fascisti che violò per intero la convenzione di Ginevra. A quasi 80 anni di distanza la dimensione di questo sterminio è ancora avvolta in una nube di mistero. Contrariamente agli alti ranghi fascisti è difficile dire se i soldati italiani sapessero che all’interno della grotta c’erano anche donne, vecchi e bambini. È però verosimile affermare che i morti dentro e fuori la caverna furono tra 800 e 1.500.

Il caso è riemerso nel 2006 grazie agli studi del giovane ricercatore dell’Università di Torino Matteo Dominioni che ha ritrovato una serie di documenti nell’ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito.
In quel faldone rinviene un telegramma del colonnello Lorenzini del 14 aprile 1939 che descrive le difficoltà di esplorare la grotta dopo l’azione. Dominioni pubblica la sua ricerca e poi scrive il libro Lo sfascio dell’impero nel 2008, portando alla luce i dettagli di un’altra vergognosa vicenda italiana dei tempi coloniali dopo che nel 1996 il governo Dini desecretò i documenti dell’epoca.
IN UNA PICCOLA CAPANNA di Kampo vive una dei pochissimi testimoni di ciò che avvenne in quei giorni. Tekabe Kershe ha 98 anni, è cieca e molto debole. La figlia Eifimesh Tegname parla per lei. «Era incinta, molto giovane e ha vissuto per almeno 15 giorni nella caverna. Mio padre Femtik era un patriota e combatté nella grotta. Qualche giorno prima dello scontro mia madre partorì, così mio padre la inviò nella zona della chiesa copta che si trovava vicino al fiume Wenchit. Per questo si salvò».
Posa una mano sulla spalla della madre e poi prosegue: «Mio padre era valoroso. Tutti ci rispettano ancora adesso. Riuscì a fuggire prima che gli italiani fucilassero gli uomini che in gran parte sono stati anche legati assieme e buttati giù dalla rupe».
Con il passar del tempo i resoconti e le interpretazioni sono ormai difficili da accertare. Su una cosa tutti gli etiopi sembrano però concordi. Le vittime sarebbero state almeno 5mila dentro e fuori l’Amazegna Washa. «Anche se sono vecchio e dimentico molte cose, quello che vidi in quei luoghi non potrò mai dimenticarlo», afferma Shewantasew Yimraw, seduto su una sedia all’esterno del circolo dei patrioti etiopi di Addis Abeba, un altro degli ormai rari testimoni diretti dei fatti.
È vestito in alta uniforme e mette bene in mostra le medaglie delle battaglie combattute durante il regime del Derg. «Ero un bambino quando con mio padre andammo a recuperare migliaia di corpi dentro e attorno alla grotta per seppellirli».

Si mostra più cauto lo scrittore Dawitt Kidane Afework, autore di diversi libri sulla storia etiope tra cui Netzannet, l’infinita tela del ragno in uscita a novembre. Ritiene che senza un’adeguata documentazione dei fatti sia azzardato affermare che ci fossero 5mila persone nella grotta: «Stando alle carte a disposizione non avranno superato qualche centinaio. Di sicuro è stato usato del gas su donne e bambini, ma sui numeri mi sento di dissentire».
Una storia rimasta celata anche per motivi politici. Quando l’imperatore Hailé Selassié tornò al potere nel 1941, non c’era molto interesse a raccogliere informazioni sull’occupazione. Il sovrano era fuggito nel Regno Unito nel 1936 e molti lo criticavano ancora per questo: si evitava di scavare nelle tragedie degli anni dell’occupazione fascista, per non parlare del periodo della dittatura del Derg.
«Contemporaneamente c’è il ruolo di noi inglesi – aggiunge lo storico Ian Campbell, uno dei massimi esperti del periodo e autore del libro The Addis Ababa Massacre. Italy’s National Shame del 2017 – Non gli interessava rendere pubblici i crimini di guerra commessi dagli italiani. In primis perché ne avevano riconosciuto l’occupazione nel 1936 e poi perché ora l’Italia faceva parte degli alleati. Non era conveniente parlare di quello che avevano fatto».
«SONO STATI DEI DIAVOLI», afferma il vecchio patriota Yimraw, mentre si alza per allontanarsi sorreggendosi su un vecchio bastone. Mette in ordine le medaglie appese al petto, poi si volta: «I fascisti ci hanno fatto del male. Ma solo loro…non il popolo italiano. Ditelo ai giovani del vostro paese. Non siate come loro».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento