I creditori di Kiev hanno detto no
Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari
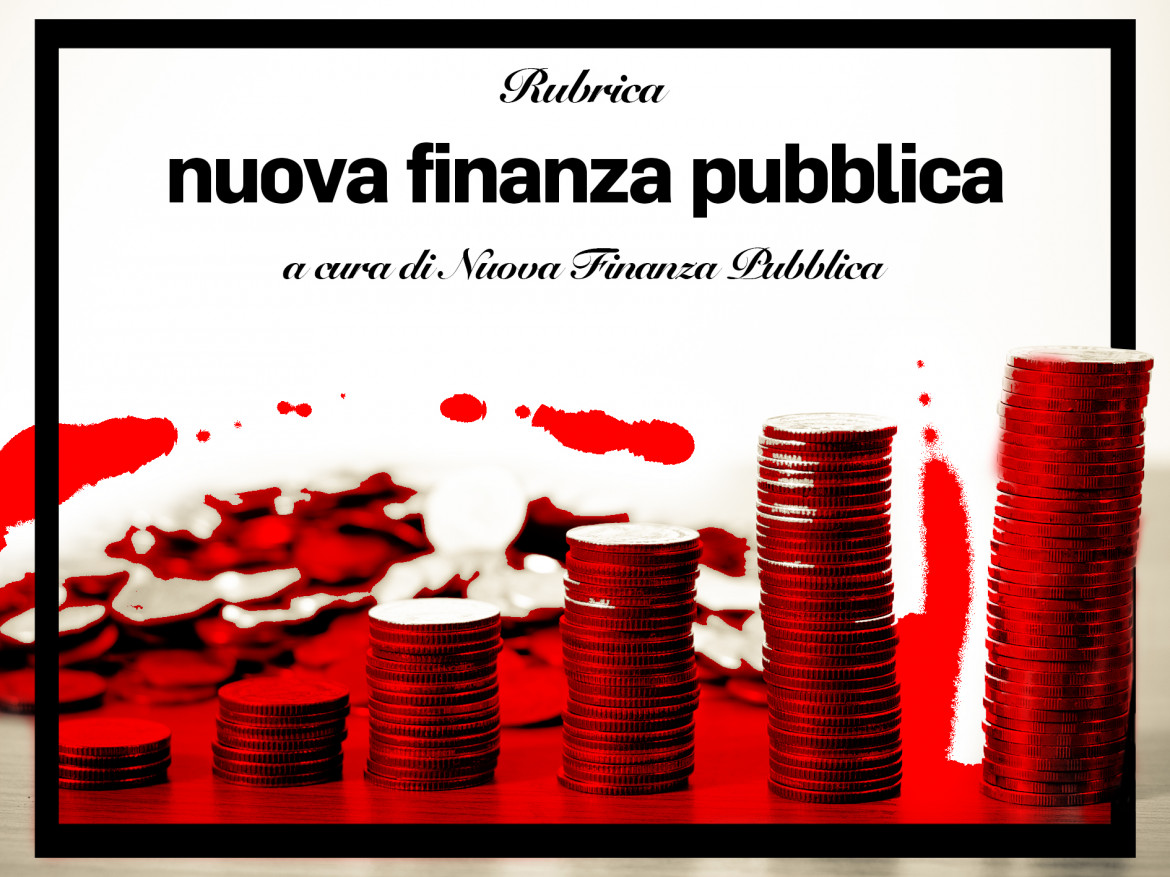
Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari
Il 10 giugno scorso, all’indomani delle elezioni europee, l’opinione pubblica stava digerendo il risultato e la farraginosa macchina Ue già pensava alle complesse negoziazioni per la nomina della nuova Commissione. Nessuno immaginava seriamente che sarebbe mutata la politica filo- Nato degli attuali vertici, ed infatti due eventi lo marcavano in maniera significativa, anche se il faro mediatico puntato sulle elezioni li ha messi in ombra: la Conferenza per la Ricostruzione a Berlino (11-12 giugno) e il G7 in Italia (Comunicato del 14 giugno). Ma il testo che – assai più sul piano sostanziale – forse marca un certo cambiamento del vento non l’ha letto nessuno. È una comunicazione della Borsa di Londra datata 17 giugno. In questa si dà notizia che le negoziazioni fra Kiev e i creditori per raggiungere un accordo su uno sconto sul debito ucraino sono fallite. E sarebbe urgente raggiungere un risultato entro il 1 agosto. Non c’è molto tempo. Ma perché tale scadenza? E quali conseguenze comporta?
Facciamo alcuni passi indietro. Dopo essere entrata nell’orbita occidentale (o meglio, Usa, viste le profonde connessioni osservate, ultimamente, dallo stesso New York Times fra Kiev e Washington) in Ucraina sono state pompate cifre ragguardevoli, di pari passo con una spinta significativa verso l’imposizione di un rigido neoliberismo nel paese. Dallo scoppio della guerra nel 2022 ciò si è intensificato: a marzo scorso una stima quantificava in 156 mld di dollari gli aiuti, civili e militari, della sola Ue, mentre riguardo agli Usa la cifra più citata corrisponde a 175 mld di dollari (inclusi gli aiuti bellici, di cui gli Usa sono i maggiori protagonisti). Ed i creditori internazionali hanno congelato il rientro dei debiti, accettando di non venire pagati entro i termini stabiliti. Anche fondi e banche private hanno accettato di posticipare la restituzione di 20 miliardi euro per due anni. Il Fondo monetario è uno dei finanziatori fondamentali. Come suo solito, sta concedendo gli stanziamenti in piccoli pacchetti, nel quadro di un programma di 122 miliardi. Ma ci sono delle condizioni da soddisfare, un insieme di riforme e parametri macroeconomici.
Ad agosto scade la moratoria dei creditori privati, e a quanto riposta il comunicato pubblicato dalla Borsa di Londra, l’Ucraina doveva cercare una forma di sconto del prestito che fosse conforme agli obiettivi stabiliti dal Fondo, i cui funzionari hanno partecipato alla discussione. Considerano necessario un taglio del debito estero ucraino per renderlo sostenibile. Tale sostenibilità è un concetto controverso, ma si tratta di un presupposto indispensabile per il Fmi: per regola non si può finanziare un debito considerabile come insostenibile. Nel caso dell’Ucraina, il Fondo ha prodotto un rapporto molto lungo e dettagliato datato dicembre 2023 in cui analizza la esausta economia del paese tracciando un possibile percorso di crescita, che nonostante l’imponente sforzo analitico resta largamente ipotetica sia per l’incertezza della durata della guerra e delle sue vicende, sia perché gravata da una pesante sovrastima del potere benefico della concorrenza, del mercato, delle regole, dell’apertura al commercio estero – fattori che si sono dimostrati più idonei ad aprire gli Stati oggetto della “terapia” ai processi capitalistici più acutizzati che a conseguire crescita e sviluppo, in numerosi esempi nel mondo.
In ogni caso, quindi, il verdetto dei tecnocrati non si discute: si deve ristrutturale. Per ottemperare a tale condizione, gli ucraini hanno proposto ai creditori privati una modalità che comportava un taglio fino al 60% delle cifre da restituire. La controparte ha risposto picche, facendo a sua volta delle controproposte che sono state scartate in quanto non sarebbero conformi alle pretese del Fondo, limitandosi al 20% circa.
C’è tempo solo fino al 1 agosto per trovare una quadra che consenta di continuare gli stanziamenti del Fondo monetario internazionale, ma i creditori privati non ci vogliono rimettere così tanto. Il tempo è poco e la guerra incombe su Kiev, soprattutto nella eventualità che una nuova amministrazione repubblicana possa chiudere il flusso di fondi Usa.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento



