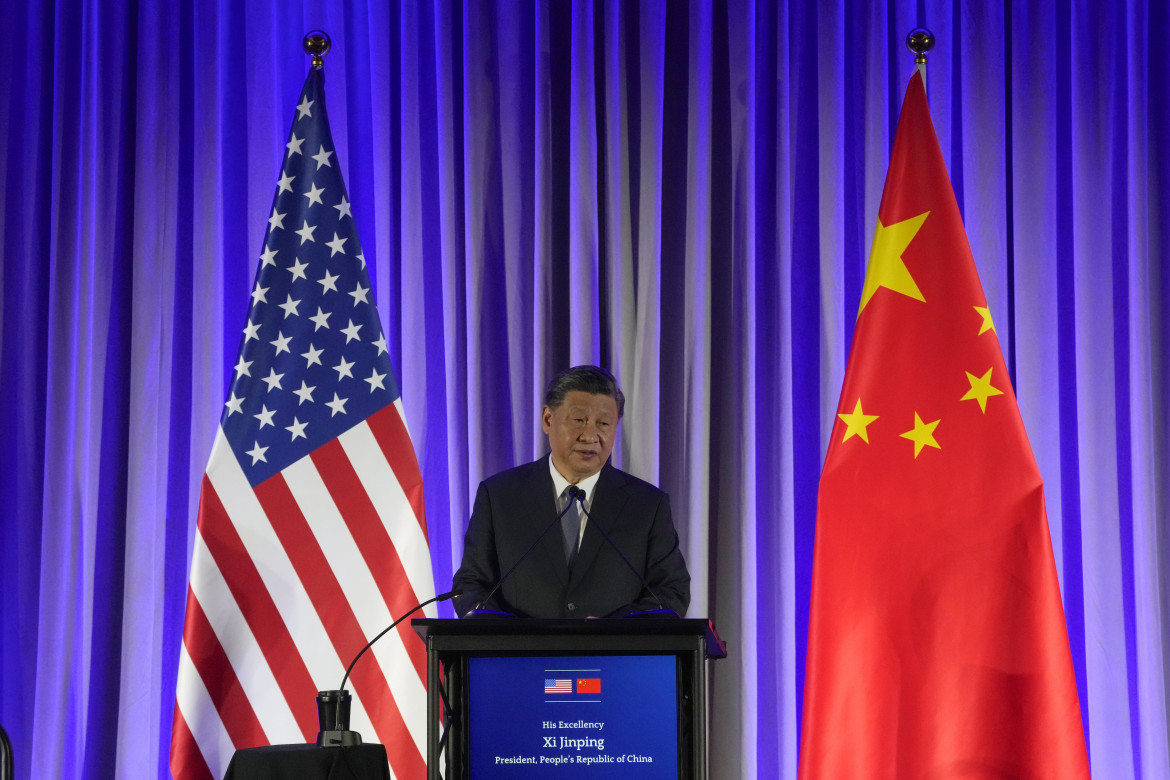Hong Kong deve prendere congedo dal suo passato
CIna/Hong Kong Per 156 anni la popolazione di Hong Kong ha ignorato la Cina, pur essendone una costola. Il suo sguardo era volto verso l’Occidente, mai verso Nord, la Cina continentale. È venuto il tempo di prendere congedo dal passato, di lavorare a un’integrazione mutuamente vantaggiosa, levigando gli aspetti critici

CIna/Hong Kong Per 156 anni la popolazione di Hong Kong ha ignorato la Cina, pur essendone una costola. Il suo sguardo era volto verso l’Occidente, mai verso Nord, la Cina continentale. È venuto il tempo di prendere congedo dal passato, di lavorare a un’integrazione mutuamente vantaggiosa, levigando gli aspetti critici
Le proteste attuali sono state innescate dal caso di un cittadino di Hong Kong ricercato per uno stupro commesso a Taiwan. La legge proposta dalla Chief Executive, Carrie Lam, avrebbe però consentito anche l’estradizione di soggetti ricercati da Pechino per ragioni politiche. Il 4 settembre scorso Carrie Lam, con una decisione tardiva, ha ritirato definitivamente la proposta. Nonostante la retromarcia, i manifestanti non si arrendono.
Se l’inchiesta sulle violenze della polizia e il rilascio degli arrestati sono temi negoziabili, non è così per le dimissioni di Lam e ancor meno il suffragio universale: Pechino teme infatti che la libera espressione del voto porterebbe al potere figure a lei ostili, innescando aspirazioni secessionistiche su cui farebbero leva i nemici esterni (americani) che sognano l’implosione della Cina. Il delicato tema dell’estradizione andava gestito con una sensibilità che manca alla dirigenza di Hong Kong, abituata a eseguire ordini (in passato di Londra, ora di Pechino), invece di elaborare risposte autonome sulla base di una migliore conoscenza del territorio.
Le apprensioni sul futuro – quando nel 2047 la Regione Amministrativa Speciale, salvo possibili proroghe, verrà equiparata alle altre province cinesi – si sommano ora a quelle sociali, meno visibili eppure di sostanza, alla luce della forte polarizzazione della ricchezza e dei milioni di lavoratori con salari di sopravvivenza. Geniale era stata la formula escogitata a suo tempo da Deng Xiaoping: un paese, due sistemi. Solo una nazione che si concepisce come civiltà poteva immaginarla. Un classico stato-nazione europeo mai avrebbe potuto concepire una soluzione impregnata di tale pragmatismo e così intellettualmente e istituzionalmente avanzata.
Nella scommessa di Deng l’eccezionalismo di Hong Kong avrebbe dovuto far da modello per la crescita qualitativa della Cina, indicando un percorso insieme plausibile per la ribelle Taiwan. Il riscontro di Taipei era stato però impietoso: ci terremo la nostra indipendenza e le nostre istituzioni fintantoché le condizioni storiche e la forza militare (con il sostegno americano) ce lo consentiranno, sottintendendo soprattutto finché la Cina non sarà diventata una democrazia.
Se Hong Kong è la memoria plastica di un’epoca da cancellare, quella coloniale, figlia del secolo dell’umiliazione da parte delle grandi potenze, Taiwan costituisce l’alternativa politico-istituzionale alla Cina comunista. Sun Yatsen, primo presidente della Repubblica dopo la caduta dell’impero Qing, sognava una democrazia suffragio universale e capace di tutelare le libertà dell’individuo. Taiwan rappresenta tuttora, per la Cina, una sfida ideologica.
Quanto a Hong Kong, durante i 156 anni di dominio, gli inglesi mai si sono sognati di introdurre la democrazia. Il Governatore veniva nominato da Londra, il Consiglio Legislativo era un mero organo consultivo e la partecipazione della popolazione era minima. Di colpo, nel 1997, portare la democrazia ad Hong Kong diviene per Londra fondamentale!
È infine diffusa la convinzione che il suo successo, anche prima del 1997, sia dipeso dal dinamismo e dall’ingegnosità del suo popolo. Si tratta di una lettura semplicistica. In realtà il successo di Hong Kong è da attribuirsi solo alla fortuna. Per 130 anni, fino al 1978, la sua economia era stagnante. D’improvviso, nel 1978, Deng apre la Cina al mondo, cambiando la storia cinese e quella di Hong Kong, che diventa la porta d‘ingresso del business occidentale in Cina. Una rendita di posizione che dura fino al 2001, quando la Cina entra nell’Organizzazione Mondiale del Commercio e HK perde lentamente questo privilegio perché le imprese straniere possono ora recarsi direttamente in Cina. La fortuna di Hong Kong non è dunque dovuta alla Gran Bretagna, ma esclusivamente alla Cina. L’economia della città è tuttora di stampo oligopolistico, tipicamente coloniale, basata sulla ricchezza fondiaria, la proprietà della terra, una struttura che nemmeno il ritorno alla Cina ha modificato.
Nella visione di Deng, Shenzhen avrebbe dovuto avere Hong Kong come benchmark. Egli rimarrebbe oggi sbalordito dei cambiamenti occorsi a quell’oscuro villaggio. Shenzhen è diventato il centro tecnologico più importante della Cina, seconda nel mondo solo alla Silicon Valley per capacità d’innovazione, mentre Hong Kong ha mantenuto lo stesso modello di allora, generando sempre e solo ricchezza fondiaria. Taluni affermano che Hong Kong non può più rinunciare alla democrazia e allo stato di diritto, per essere governato dal Pcc.
Tuttavia, la storia non fa retromarce. Hong Kong farebbe bene a investire sull’avvenire, su nuove intese di differenziazione e sull’evoluzione delle istituzioni cinesi. E ciò sarà più facile se si convincerà di essere parte della storia della Cina. Per 156 anni la popolazione di Hong Kong ha ignorato la Cina, pur essendone una costola. Il suo sguardo era volto verso l’Occidente, mai verso Nord, la Cina continentale. È venuto il tempo di prendere congedo dal passato, di lavorare a un’integrazione mutuamente vantaggiosa, levigando gli aspetti critici. Invece di concepirsi quale soggetto esterno, come fosse ancora una colonia, o addirittura un luogo separato (o separabile) dalla Cina, Hong Kong deve accettarsi quale parte sostanziale e necessaria della Cina, della sua cultura e della sua storia.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento