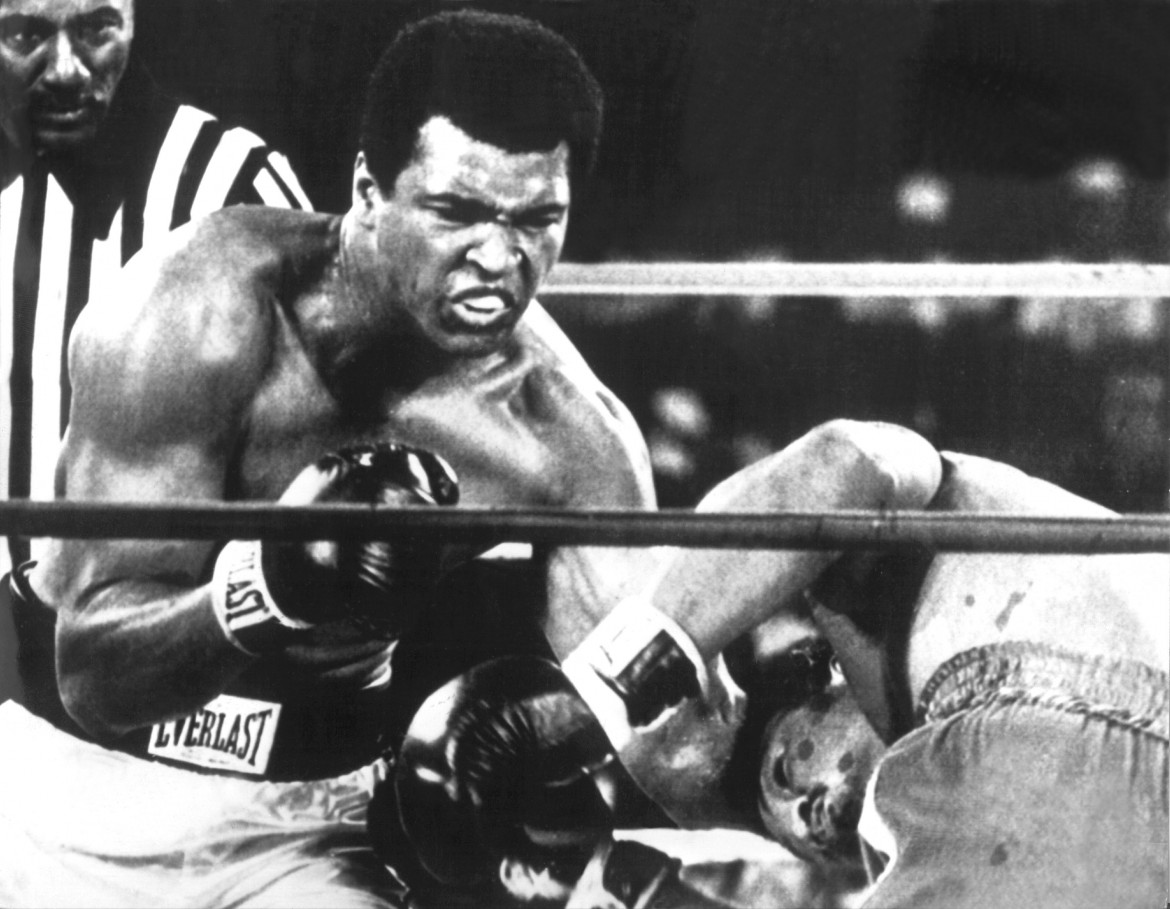Damon Galgut, scricchiolii minacciosi dalla cantina della Storia
Scrittori sudafricani Un bianco di mezza età, che ha perso tutto a causa dell’«africanizzazione», si isola in campagna, dove viene ossessionato da strane presenze: «L’impostore», riedito da e/o
 Roger Ballen, «Revealed», 2020
Roger Ballen, «Revealed», 2020Scrittori sudafricani Un bianco di mezza età, che ha perso tutto a causa dell’«africanizzazione», si isola in campagna, dove viene ossessionato da strane presenze: «L’impostore», riedito da e/o
Nel suo saggio del 1993, Spettri di Marx, Jacques Derrida conia un neologismo, hantologie (da hanter, «ossessionare», e ontologie, «ontologia») riferendosi a quelle opere, o situazioni, costruite a partire da tracce del passato che arrivano a ossessionare il presente. Allo «spettro del comunismo» che – secondo il celebre incipit del Manifesto di Marx e Engels – si aggira (e continua ad aggirarsi, suggerisce Derrida) per l’Europa, corrispondono, in letteratura, opere in cui si manifesta la persistenza o il ritorno del passato sotto forma spettrale: un esempio classico è l’Amleto di Shakespeare, con l’inquietante presenza del fantasma del padre, spettro sul crinale tra presenza e assenza, in grado, con la sua apparizione, di determinare quella che Derrida definisce una «disgiuntura temporale».
Nell’ambito contemporaneo, la narrativa sudafricana post-apartheid sembra proporsi come paradigma emblematico di una hantologie – storica e politica, pubblica e privata – che si riflette tanto sul singolo quanto sulla collettività. Ne è un esempio la notevole produzione romanzesca di Damon Galgut, che in seguito al successo della Promessa, le edizioni e/o stanno interamente ripubblicando. Passati inosservati alla loro prima apparizione nella nostra lingua all’inizio degli anni Duemila, lavori come Il buon dottore (ripubblicato lo scorso anno) o L’impostore (appena uscito per la traduzione di Silvia Piraccini, pp. 250, € 18,50), confermano Galgut come uno dei maggiori autori contemporanei di lingua inglese, in grado di rappresentare tramite metafore e preziosi tocchi di colore il fascino conturbante di un tempo «sregolato e folle» in cui il passato invade il presente, facendo vacillare ogni certezza.
Adam Napier, un bianco di mezza età, che ha perso casa e impiego a causa dell’africanizzazione – ovvero della immissione sul mercato del lavoro di giovani di colore in sostituzione di persone bianche più anziane – si vede costretto ad accettare la proposta del fratello, agiato imprenditore senza troppi scrupoli, che lo invita a sistemarsi per qualche tempo in una sua casa di campagna nel Karoo, a otto ore di distanza da Città del Capo.
Memore della sua lontana dedizione alla poesia, Adam si illude di trovare nel remoto paesaggio bucolico la condizione ideale per riprendere a scrivere versi. Ma l’estremo degrado della casa, e una sopravvenuta apatia, gli inibiscono la scrittura; strane presenze sembrano inoltre ossessionarlo, sotto forma di rumori e voci inquietanti, mentre ombre e fruscii si manifestano tra le erbacce che invadono il giardino. Un incontro casuale con un vecchio compagno di scuola, lo scialbo Canning, che lo invita a trascorrere qualche giorno nella stupenda riserva di caccia ereditata dal padre, interrompe la sua solitudine in maniera imprevista. Adam diventa dunque un frequentatore abituale della lussuosa dimora dell’amico, dove non solo intreccia una relazione con la sua bellissima e avida moglie di colore, ma finisce anche invischiato, per indolenza e ingenuità, in un losco affare finalizzato alla distruzione del magnifico parco naturale di Canning per costruire un esclusivo campo da golf con resort di gran lusso.
Più ancora della componente thriller, ancorché di ottima fattura, ciò che rende L’impostore interessante è proprio l’insistenza sulla persecuzione che il passato (ovvero, il lungo periodo dell’apartheid) esercita sul presente, attraverso il continuo emergere di presenze che fratturano la temporalità convenzionale, permettendo a quanto è trascorso di calarsi in nuove forme. Da una zona oscura dell’infanzia riappare Canning, del quale, non per caso, Adam non conserva memoria; dalle ombre più cupe dell’apartheid riemergono sia Blom, il servizievole e solitario vicino di casa di Adam, sia l’odioso padre di Canning, figure che confermano la persistenza di un passato tragico, non ancora metabolizzato. Anche le case e la stessa natura sono infestate da spettri: poco dopo il suo arrivo nel Karoo, ossessionato da strani rumori, e da ombre informi nelle camere sporche – «un accumulo di piccolissimi segni» – Adam arriva a percepire fisicamente la «disgiunzione temporale» di cui parla Derrida nel suo saggio: «Il tempo cambiò forma … Aveva preso la forma delle stanze, ripiegandosi su di sé, ammucchiandosi in strati compatti, tanto densi e pesanti da essere quasi solidi. Non gli sembrava impossibile che persone o gesti del passato potessero essere lì, vicinissimi a lui. Qualche volta gli pareva quasi di vederlo, il passato… era come se qualcuno lo osservasse».
Anche quando gli eventi precipitano e la narrazione si fa convulsa e coinvolgente come quella di un romanzo nero, il senso di minaccia che atterrisce il protagonista ha ben poco da spartire con le avvisaglie di pericolo tipiche del noir. E ha invece molto a che vedere con le insidie del passato, con la paura di qualcosa che non si sa se esista, di un presente non presente o di un passato non passato. Galgut è eccezionale nel rendere vivida l’inquietudine che ne deriva, il suo montare fino a un punto di non ritorno, quando l’unica possibilità di sopravvivere implica letteralmente l’uccisione del passato, l’abiura di ogni idealismo, l’abbandono della poesia che «non paga l’affitto», come dice il pragmatico fratello di Adam: per accettare il mondo reale, «un edificio sgangherato di compromessi e mezze verità».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento