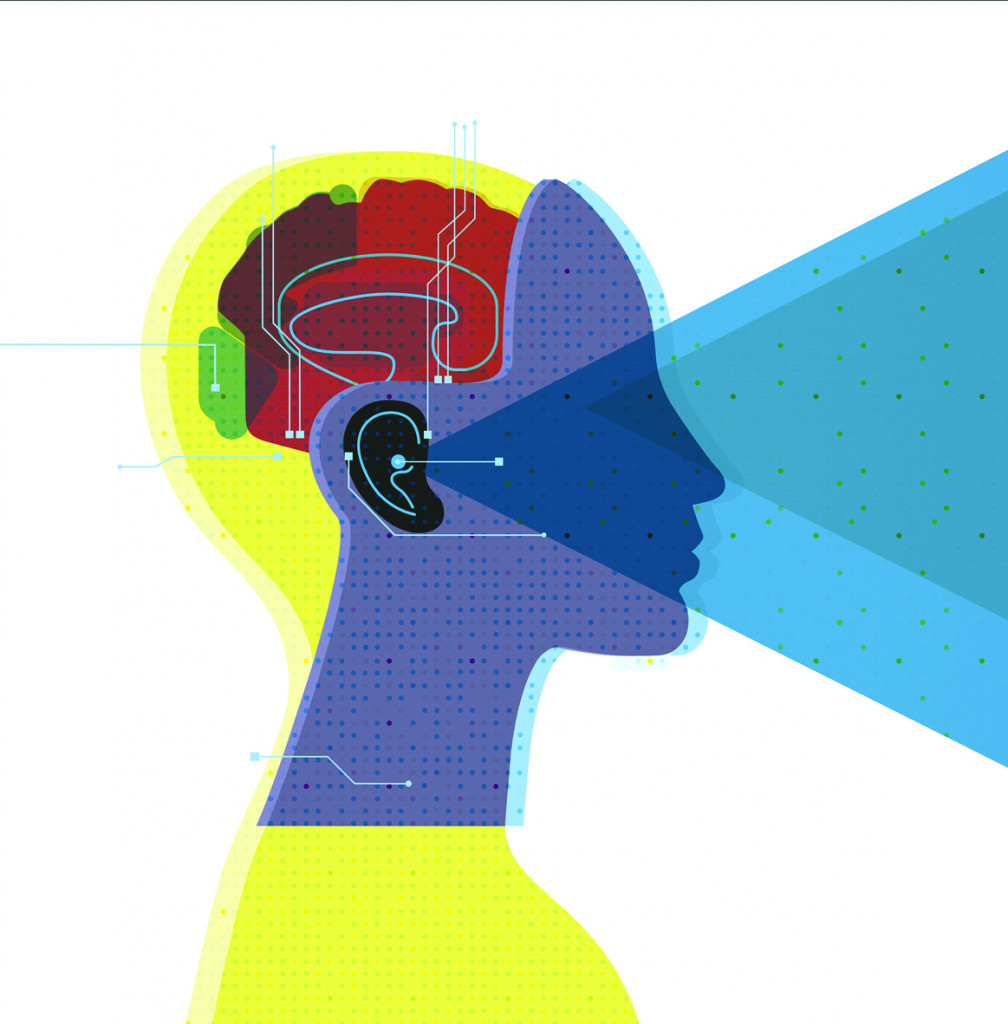Cristina Rivera Garza, testi rammendati con il filo degli affetti
Interviste letterarie La scrittrice messicana Cristina Rivera Garza racconta il suo lavoro per rendere parlanti le voci sepolte negli archivi delle istituzioni: oggi sarà al Festivaletteratura di Mantova
 Cristina Rivera Garza nel 2020 (courtesy MacArthur Foundation)
Cristina Rivera Garza nel 2020 (courtesy MacArthur Foundation)Interviste letterarie La scrittrice messicana Cristina Rivera Garza racconta il suo lavoro per rendere parlanti le voci sepolte negli archivi delle istituzioni: oggi sarà al Festivaletteratura di Mantova
Nel 2003 a Siviglia si riunirono, insieme a Roberto Bolaño, undici giovani promesse della letteratura latinoamericana, per parlare di un futuro che si annunciava promettente per tutti loro. Nella foto di gruppo che li ritrae c’è una sola donna, a testimonianza del fatto che all’inizio del nuovo millennio le lettere del continente non si erano ancora liberate di quella preponderanza maschile, che la portoricana Rosario Ferré aveva descritto in modo magistrale nel suo saggio El coloquio de las perras (1990).
A distanza di vent’anni da quell’incontro, il percorso intellettuale più coerente e solido appartiene, di fatto, all’unica donna presente, la messicana Cristina Rivera Garza: nel 2003 aveva al suo attivo un’interessante raccolta di racconti e un primo folgorante romanzo d’esordio, Nessuno mi vedrà piangere (Voland, 2008); ma da allora si sono aggiunti altri sette romanzi, tra i quali risaltano gli ultimi due – Autobiografía del algodón, 2020 e L’invincibile estate di Liliana (Sur, 2023) – dedicati a una indagine sul passato della propria famiglia.
Di anno in anno e di titolo in titolo, Cristina Rivera Garza ha saputo rinnovare più volte la propria scrittura, con un notevole lavoro sulla lingua, confermato anche dai suoi versi, appena riuniti in un volume unico.
Nelle sue pagine ha convocato personaggi letterari e non, fra i quali la sorella Liliana, vittima di un omicidio, nel 1990, quando aveva solo vent’anni, e la scrittrice argentina Alejandra Pizarnik. Dopo avere studiato in Messico e negli Stati Uniti, ha insegnato letteratura e scrittura creativa per molti anni in diverse università statunitensi, costruendo un’attività critica tra le più lucide del nuovo secolo, attenta sia alle relazioni tra la letteratura e la società messicana contemporanea che all’analisi di importanti scrittori del ventesimo secolo, fra i quali Juan Rulfo.
Al Festivaletteratura di Mantova parlerà oggi del suo ultimo romanzo, L’invincibile estate di Liliana (Sur, 2023) e del rapporto tra letteratura e memoria.
Nella sua traiettoria letteraria è sempre stato presente un rapporto speciale con gli archivi: quali contributi portano questi depositi di memorie al suo lavoro di scrittrice e di critica letteraria?
Il mio rapporto con gli archivi è un regalo che mi viene dalla mia formazione come storica. Ho fatto ricerca negli archivi istituzionali, attraverso i quali il potere si afferma e conserva memoria di sé, e ho imparato come sia possibile trovarvi anche pratiche linguistiche che hanno criticato quello stesso potere. Quando ho studiato gli archivi del manicomio della Castañeda, il primo ospedale psichiatrico messicano, accanto alla prospettiva dei medici che tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento si avviavano a diventare psichiatri, trovai le voci di coloro che non erano nemmeno considerati pazienti bensì «internati». Scoprii così una visione alternativa della medicina, del corpo, e in generale di Città del Messico. Col passare del tempo, mi sono dedicata a quelli che ho chiamato «archivi degli affetti», situati in luoghi estranei agli ambiti ufficiali, il cui sistema organizzativo rispetta le esigenze di famiglie o comunità specifiche.
In generale l’archivio rimanda a una idea di istituzione fredda, retta da regole rigide; ma da essi emergono nei suoi libri storie di dolore, che sembra aspettassero solo di essere riportate in vita. Come ha calibrato la sua scrittura in questi casi?
È opinione diffusa che gli archivi esprimano la prospettiva dei vincitori; ma chiunque li abbia consultati sa che giacciono nei loro molteplici strati voci alternative, esperienze cancellate, messe a tacere, nascoste, che sono ancora lì, perché è l’archivio stesso ad averne bisogno. E’ un circolo perverso: perché il potere si enunci come tale ha bisogno di includere coloro che ha sconfitto. Attraverso queste esperienze di dolore, di sofferenza del corpo, sono riuscita a accedere a un linguaggio malleabile, potente e condiviso da tante discipline: dalla religione al diritto, alla medicina. La sfida risiede nella capacità di riattivare queste voci tacitate e portarle nel presente, non come una forma di nostalgia per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, ma come segnali di qualcosa che è ancora latente, e può sempre saltare fuori. La studiosa statunitense Saidya Hartman, mentre cercava di indagare sulla propria genealogia tra gli schiavi portati a forza dall’Africa, in assenza di un archivio e di fronte alla perdita di tante esperienze coniò un termine, «fabulazione critica», che indica la possibilità di colmare le lacune tra i documenti, di superare la porosità dell’archivio per attivare relazioni dinamiche con il passato: tutto questo è per me molto utile, e ha a che fare anche con la tensione tra ciò che è finzione e ciò che non lo è. Mi piace pensare a questo fenomeno come a un «genere ospite», che nei miei libri più recenti accoglie altri campi letterari per realizzare quella affabulazione critica di cui parla Hartman. Non solo questa pratica serve a riempire i vuoti degli archivi storici, ma permette anche di far incrociare i diversi generi per rendere possibile la riattivazione di una energia politica nel presente.
In questa ricerca ha un ruolo fondamentale il suo progetto di scrittura corale, che incrocia le molte voci venute dal passato: come riesce a dialogare con tutte le voci evocate nei suoi libri, e negli ultimi anni con quelle dei suoi antenati e di sua sorella, vittima di un omicidio?
Un’idea convenzionale di letteratura, ripetuta in molte scuole di scrittura, vuole che il testo non mostri le sue cuciture, bensì sembri emergere da se stesso, già completo. È un’idea che non condivido: la scrittura è fin dall’inizio una pratica plurale. Usiamo una lingua che non ci appartiene, che ci mette in relazione con altre comunità di parlanti: i nostri testi dovrebbero allora mostrare i loro punti di giuntura, le fonti plurali a cui attingono, in modo che chi scrive arrivi a un processo di disappropriazione, proprio il contrario di quanto avviene quando facciamo nostre quelle voci e le sfruttiamo, usando il concetto di autore. In Nessuno mi vedrà piangere ho inserito le cartelle delle malate che avevo consultato, e nel libro dedicato a mia sorella Liliana ho incluso l’archivio degli affetti che lei stessa ha costruito, in modo che ne venisse fuori un testo non su di lei ma insieme a lei. Non un libro sulla sua morte, ma soprattutto sulla sua vita. Ho incorporato nel testo le lettere di Liliana, le interviste ai suoi amici, le voci dei nostri genitori, facendone un libro corale che introietta linguaggi letterari e non.
La materialità del dolore si fa molto evidente nei suoi ultimi libri, legati strettamente alla storia del Messico: c’è un nesso evidente fra ciò che succede ai migranti in «Autobiografía del algodón», o ciò che accade a Liliana, e la società in cui vivono. Sono due libri che propongono un’idea di memoria radicata in qualcosa di molto concreto. Cosa significa per lei, oggi, ricordare quel passato?
Nella realtà storica si attivano forze, progetti, visioni che entrano in conflitto con il potere, e che continuano a esistere in modo sotterraneo, come il fossile di cui parla Walter Benjamin. Il processo che porta alla costruzione della memoria è profondamente personale, ma a me non interessano le testimonianze individuali quando si pretendono già complete. Mi attrae di più la serie di connessioni che si stabilisce quando qualcuno «dà conto di sé» implicando un «tu», come fa Judith Butler in Critica della violenza etica. In realtà mi appassiona ancora di più «dare conto del noi», in quella relazione, sempre dinamica e conflittuale, tra la nostra intimità personale e le comunità all’interno delle quali viviamo. In questo senso condivido l’idea di memoria come pratica collettiva: non tanto uno sguardo verso il passato, quanto il processo comunitario che porta a evocare una presenza per riviverla nel presente. Lo scrittore messicano José Revueltas, in un suo breve saggio scrive della domanda a cui tutti gli esseri umani dovrebbero rispondere, dal momento che occupano uno spazio sulla superficie della terra: perché siamo qui, cosa c’era prima di noi e che fine ha fatto quello che non c’è più. Qui la domanda diventa politica: ciò che non c’è più è stato raso al suolo, è stato espulso, ha deciso di andarsene? Revueltas non parla solo degli esseri umani, ma anche delle piante, del territorio, e dice che tutto lascia un’impronta, e che alla fin fine noi mettiamo sempre i piedi su quelle impronte, che sono l’equivalente della memoria corporea, attiva, dinamica, capace di rivivificare le altre presenze intorno a noi, rendendole visibili e coinvolgenti.
Il suo ultimo libro di critica si intitola non a caso «Scritture geologiche»: cosa intende con questa espressione?
La geologia ci offre l’idea di un tempo profondo, di un passato e un presente che si stratificano nella terra, e possono essere paragonati a livelli diversi dell’esperienza, che vanno però de-sedimentati, fatti riemergere da stratificazioni anche molto profonde. In questo libro, il concetto di disappropriazione, che era legato alla scrittura, ai libri, ai modi in cui condividiamo l’esperienza, si è radicalizzato, per includere il territorio e lo spazio che abitiamo. Vorrei pensare alla terra come al nostro grande archivio comune, in cui il processo di sedimentazione provoca fra l’altro domande relative all’accumulazione dei beni della terra e alla giustizia nella loro suddivisione: in questo senso mi ritengo una materialista classica.
Il viaggio in Europa appartiene a una tradizione latinoamericana di lunga data. Lei da un anno circa vive a Barcellona: cosa significa per una scrittrice messicana del XXI secolo viaggiare e vivere in Europa in questo momento storico?
Avevo sempre preferito il viaggio verticale, dal Messico agli Stati Uniti, dove ho trascorso più della metà della mia vita, scrivendo in spagnolo e in inglese. Ho resistito a lungo al viaggio orizzontale verso l’Europa, perché in passato era la norma: la migrazione letteraria si dirigeva fondamentalmente verso Barcellona e Madrid; in anni più recenti è invece arrivato negli Stati Uniti un gran numero di scrittori e scrittrici giovani che si sono affermati e integrati in diversi centri accademici. Nel mio caso, la scelta di emigrare è dovuta alla asfissia e all’ostilità abbastanza evidente che si avverte nella vita quotidiana degli Stati Uniti, al razzismo esacerbato, al nazionalismo brutale. A Barcellona ho scoperto una comunità latinoamericana molto numerosa, attiva, accogliente, con progetti generosi e visionari, e la stessa cosa mi è successa a Berlino. Trovare queste molteplici esperienze in tutte le varietà linguistiche dello spagnolo, è stato molto incoraggiante. Mi sembra dia la possibilità di creare comunità «sporadiche», che si spostano da un luogo all’altro, collegandosi in modo strategico con il contesto che le accoglie.
Qualche settimana fa lei è entrata nel Colegio Nacional de México, prima scrittrice a venire ammessa, cosa abbastanza sorprendente dal momento che in Messico ci sono state tante autrici eccellenti e alle origini della sua letteratura c’è una grandissima poetessa, Sor Juana Inés de la Cruz, cui è dedicato un premio letterario che lei ha vinto due volte. A distanza di quattro secoli, è una autrice che rivela ancora, secondo lei, energie nascoste e in grado di dialogare con giovani lettori attuali?
Nella storia della letteratura ci sono autori e autrici che invecchiano male perché i temi che affrontano e il loro linguaggio ci diventano estranei; ma Sor Juana non è certo fra questi. Chiunque si interessi alle questioni di genere, troverà in lei una buona interlocutrice: il suo romance sul rapporto tra donne e uomini può essere letto oggi con la stessa passione e lo stesso interesse del tempo in cui venne scritto. Ma Sor Juana, secondo la quale Aristotele avrebbe avuto pensieri molto diversi se fosse entrato in una cucina, puntava non solo alle verità astratte, che comunque aveva studiato in profondità, ma anche all’espressione dei saperi quotidiani, a ciò che Perec chiamava l’infra-ordinario. È un’autrice dotata di un pensiero critico che continua a comunicare in modo del tutto pertinente al nostro presente.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento