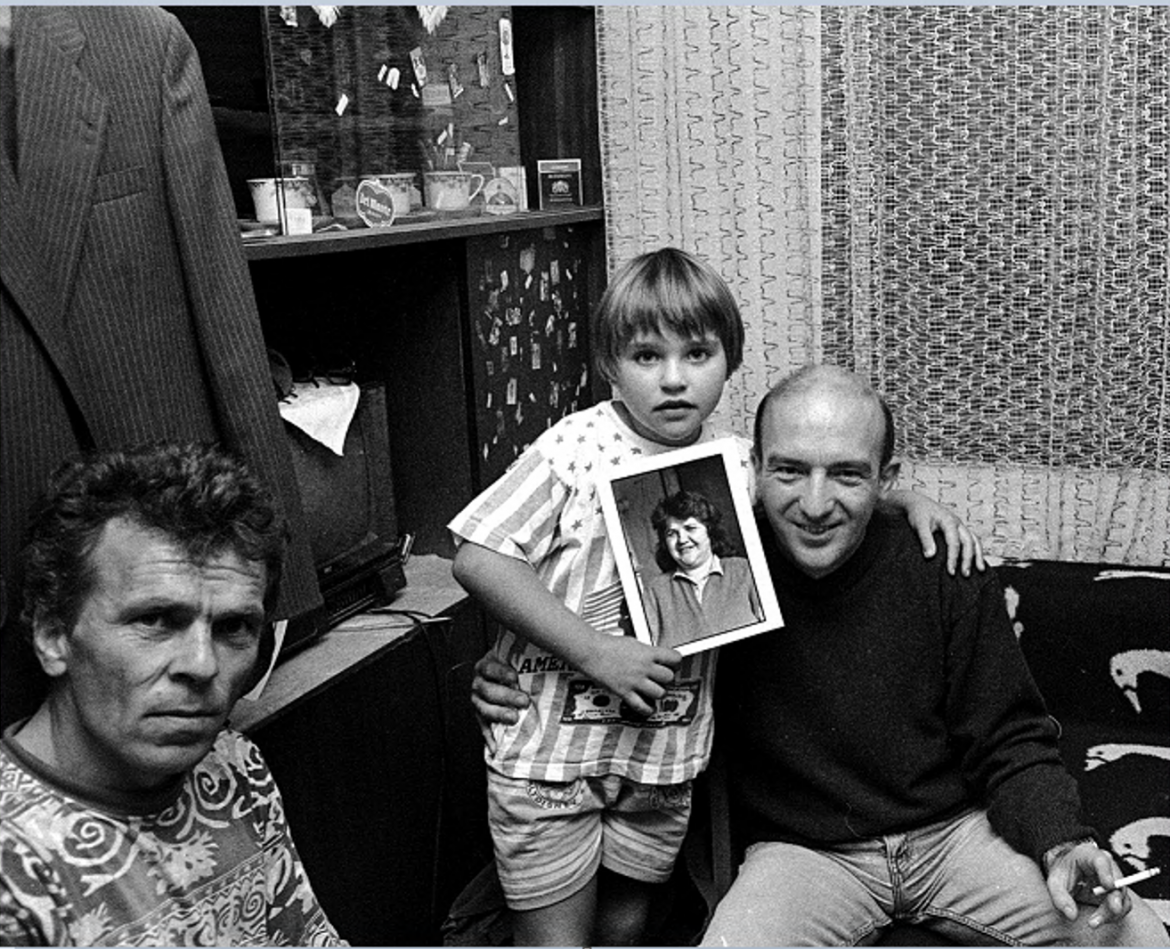Aleksandar Hemon, molto oltre i confini dell’Io
Interviste letterarie Incontro con Aleksandar Hemon, di cui Crocetti ha tradotto «Il mondo e tutto ciò che contiene», viaggio di due soldati gay verso la natìa Sarajevo, durante la prima guerra mondiale
 Nika Autor, film still da «Sunny railways», 2023
Nika Autor, film still da «Sunny railways», 2023Interviste letterarie Incontro con Aleksandar Hemon, di cui Crocetti ha tradotto «Il mondo e tutto ciò che contiene», viaggio di due soldati gay verso la natìa Sarajevo, durante la prima guerra mondiale
In quella autobiografia volutamente frammentaria che è Il libro delle mie vite Aleksandar Hemon include nell’elenco incompleto dei motivi per cui non lascerebbe per nulla al mondo Chicago l’esperienza di guidare verso ovest al tramonto, in estate: «Accecato dal sole, non riesci a vedere le macchine davanti a te. Il cielo e la città sembrano infiniti. Ovest è ovunque tu volga lo sguardo». Un impulso altrettanto cieco, orientato tuttavia nella direzione opposta, spinge Pinto e Osman, i commilitoni-amanti protagonisti del nuovo libro di Hemon Il mondo e tutto ciò che contiene (traduzione di Maurizia Balmelli, Crocetti, pp. 364, € 20,00) a cercare di tornare nella natia Sarajevo dal fronte orientale della prima guerra mondiale dirigendosi paradossalmente in senso contrario, e cioè sempre più a est. Il colpo di pistola sparato da Gavril Princip contro l’arciduca d’Austria non ha soltanto disintegrato l’universo delle certezze positivistiche, ma anche rimescolato i punti cardinali; di conseguenza il semiperiplo del globo, dalla Galizia a Taškent e poi da Shanghai a Città del Capo passando per Manila, diventa l’unico itinerario praticabile per tentare di fare ritorno a una patria che ormai non esiste più, se non nella dimensione immateriale del ricordo. Fondendo liberamente storia e finzione, lo scrittore bosniaco rielabora i temi-chiave della sua opera – da sempre centrata su storie «di sradicamento e oblio» – nell’intento di dare vita a un’ «epica di profughi».
Rispetto ai suoi racconti semi-autobiografici, «Il mondo e tutto ciò che contiene» interroga la storia del Novecento in modo ancora più esplicito; qual è stato il punto di partenza?
Il progetto di scrivere una sorta di romanzo picaresco ambientato sullo sfondo della Grande Guerra, e poi della guerra civile in Russia, risale al 2010, quando mi sono imbattuto nelle memorie del colonnello Frederick Bailey, un agente del controspionaggio inglese inviato nel 1920 dall’India a Taskent per riferire sulle operazioni militari dei bolscevichi in Asia centrale. A un certo punto la sua vera identità viene scoperta da Osman Karišik, un ex prigioniero di guerra bosniaco, collaboratore della Ceka, che rinuncia a denunciarlo, a patto che lui lo aiuti a tornare a Sarajevo. Nella storia «vera» i due riescono a riparare prima a Buchara e poi in Persia, mentre nel mio romanzo i protagonisti – insieme a Bailey – sono sospinti dagli eventi bellici sempre più a est. Mi affascinava l’idea di una deriva illogica, «anti-geografica», nella direzione diametralmente opposta rispetto alla meta agognata.
In effetti, il suo testo sembra riattivare una serie di stilemi antichi, dalle peripezie di Odisseo all’amore omosessuale fra i «commilitoni» Achille e Patroclo. L’attrazione erotica tra persone dello stesso sesso è un motivo inedito nella sua opera, ma si innesta su un espediente narrativo che torna in quasi tutti i suoi romanzi, dal «Progetto Lazarus» a «Nowhere Man», vale a dire l’incontro fortuito tra connazionali all’estero. Come si è venuto a creare questo corto circuito?
In realtà, nel progetto iniziale Pinto e Osman erano semplicemente amici. Poi a un certo punto mi sono accorto che, se li avessi resi amanti, la nostalgia che Pinto prova per Sarajevo avrebbe assunto connotazioni completamente diverse: avrebbe investito anche quel futuro ampiamente ipotetico in cui il protagonista avrebbe potuto finalmente passeggiare per i vicoli della città vecchia con il suo amato, mostrargli i luoghi della sua infanzia, presentarlo a sua madre. Man mano che questa prospettiva si fa sempre più improbabile, anche la figura di Osman sfuma, diventa irraggiungibile. Nella mente di Pinto obnubilata dall’oppio, a Shanghai il compagno di un tempo si trasforma in quella sorta di benevola presenza immaginaria che, secondo i neurologi, l’individuo tende a percepire accanto a sé nelle situazioni di particolare stress, per alleviarne l’insostenibilità. Questo motivo ricorre anche in The Waste Land, quando Eliot rievoca la spedizione antartica di Ernest Shackleton: i due esploratori sopravvissuti credono di trovarsi al cospetto di una terza persona che, in realtà, non c’è. Per Pinto è lo stesso: la presenza di Osman che egli avverte al suo fianco diventa l’unico punto fermo della sua esistenza, in mezzo a tanto caos. Per questo era importante per me che i due fossero amanti, perché Pinto ad esempio potesse sentire l’odore del corpo di Osman, come se fosse lì con lui.
Uno degli elementi immediatamente visibili in «Il mondo e tutto ciò che contiene» è la presenza di un’infinità di parole non inglesi volutamente lasciate senza traduzione. Per comprendere appieno il suo testo, il lettore dovrebbe conoscere il tedesco, il bosniaco, il russo, il ladino. Come mai per lei è stato importante mettere chi legge nell’impossibilità di capire per intero quanto lei scrive?
A parte qualche frase in bosniaco, tutte le parole di questo libro sono «straniere» per me, anche quelle inglesi. Neppure io sono il lettore ideale del mio romanzo. Rinunciando alla traduzione in nota o nel testo, volevo ricreare quella situazione di straniamento e plurilinguismo che è alla base dell’esperienza del migrante. Chiunque si muova nello spazio apprende termini nuovi che diventano essenziali per descrivere la propria condizione. Anche il lettore «viaggia» insieme a Pinto e finisce per intuire il significato delle parole di cui il protagonista si serve, a forza di vederle ripetute sulla pagina. D’altronde, credo che le varianti linguistiche parlate dai soggetti dotati di una coscienza multilingue siano tutte lingue maccheroniche, e che un romanzo centrato su vicende di displacement non possa fare a meno del sincretismo verbale. Mi interessa come dall’impasto di due idiomi, magari all’interno di una coppia o di una famiglia, nascano lingue del tutto intime, che sono il risultato specifico dell’interazione tra parlanti. L’idea di una lingua pura, specchio dell’essenza di una determinata nazione, non è solo una chimera, ma anche una costruzione intellettuale profondamente fascista.
In questo senso, Raquela, la figlia di Osman che Pinto alleva come se fosse sua, è un caso limite: essendo nata già profuga, la bambina non ha una lingua madre, e si esprime in un miscuglio di bosniaco, ladino e tedesco, inframmezzato da termini tagiki, kirghisi e uiguri, nonché da parole attinte da altri idiomi sconosciuti e assimilate lungo il cammino. Lei scrive che Raquela e Pinto «parlavano una lingua che a parte loro due nessun altro al mondo parlava, perché nessuno aveva attraversato quello che aveva attraversato loro». La lingua diventa riflesso di uno sradicamento estremo. C’è dell’ironia nel fatto che a Shanghai Raquela finisca per innamorarsi – con conseguenze fatali – proprio del suo insegnante di inglese, Jack?
Non mi ero reso conto di questo aspetto. In effetti, nell’economia del romanzo l’americano Jack funziona da elemento di rottura che provoca la catastrofe: il suo atteggiamento prepotente ed egemonico non può che spezzare la simbiosi esclusiva che ha consentito a Raquela e a Pinto di passare indenni attraverso tutti gli orrori di cui sono stati testimoni durante la loro fuga. Al contempo però Jack è anche colui che, trasmettendo a Raquela una sorta di koine, di lingua franca, le permette di uscire dall’isolamento che si porta dietro fin dalla nascita, e di diventare la donna che, a distanza di decenni, consegnerà la vicenda inverosimile dei suoi due padri al narratore. Paradossalmente, c’era bisogno proprio di Jack e del suo inglese perché Osman e Pinto potessero essere raccontati.
A un certo punto del suo romanzo del 2008 Il progetto Lazarus lei mette a confronto la via bosniaca al racconto con quella americana: in Bosnia nessuno sembra preoccuparsi se una narrazione ha o meno attinenza con la realtà, perché quel che prevale è piuttosto il piacere empatico di immedesimarsi nei protagonisti. Gli statunitensi, invece, ossessionati da ciò che lei chiama «la proliferazione di bugie», vogliono la verità, e soltanto la verità. Avendo lei scelto, ormai da quindici anni, l’inglese come sua lingua letteraria, come si destreggia fra queste diverse attitudini?
Credo che l’aspetto più interessante della letteratura sia proprio questo patto di fiducia tra autore e lettore riguardo la «verità» della narrazione, che va ri-negoziato ogni volta. Nel mio romanzo sono intervenuto ripetutamente sulla realtà storica: nel capitolo ambientato nel 1922 a Korla ad esempio spunta fuori un personaggio apocalittico, Teutenberg, ispirato alla figura effettivamente esistita del «barone sanguinario» von Ungern-Sternberg, che tuttavia non si era mai spinto fin lì. A un certo punto, scrivendo, non si può fare a meno di avventurarsi nel campo dell’immaginazione individuale: cosa succederebbe se una persona simile a me fosse messa in una situazione che non ho mai sperimentato? Per me il fine della letteratura è estendere i confini dell’io al di là dell’esperienza personale, e questo credo valga tanto per l’autore quando per il lettore. Da una certa età in avanti, troverei terribilmente noioso scrivere di noi stessi, fermandoci alle nostre esperienze fattuali.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento