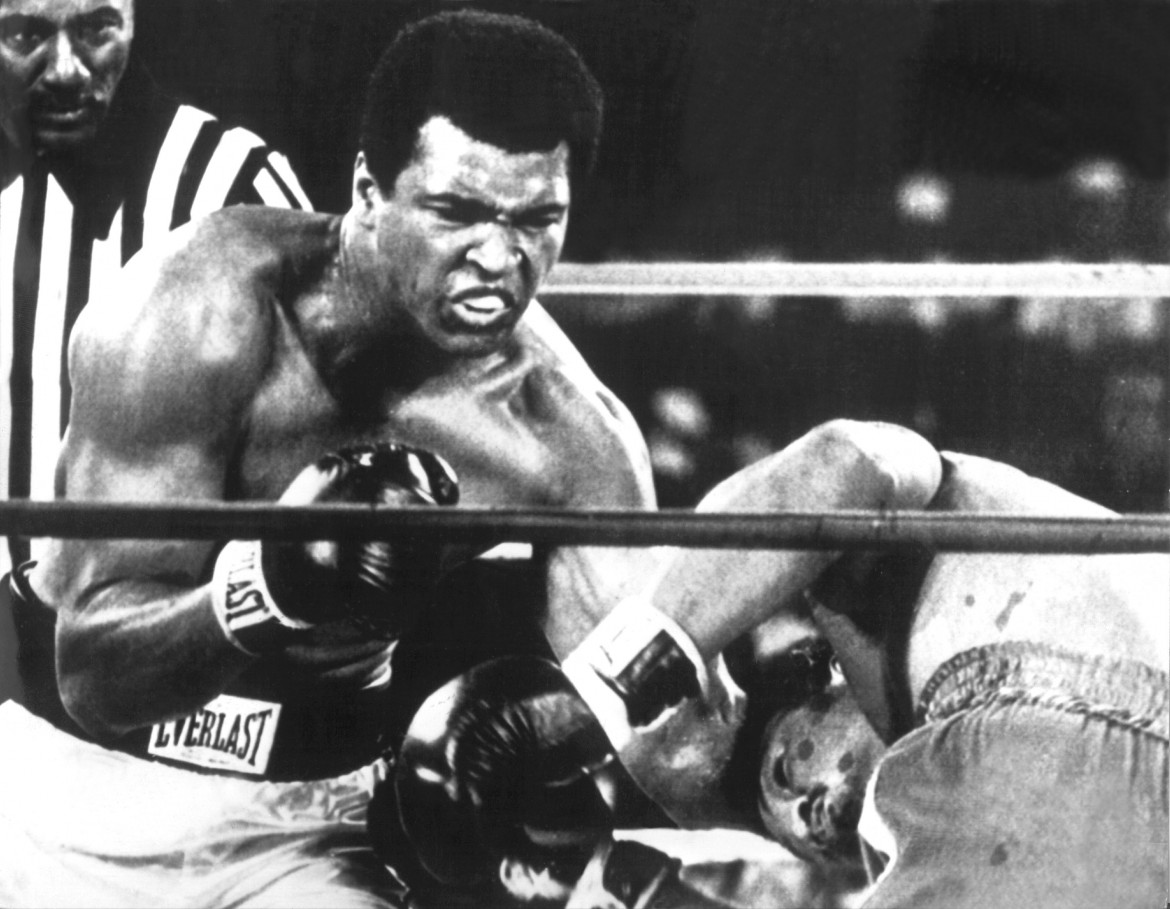Africa fashion, tessuti colore, ibridazioni post-coloniali
«Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata», canta Miriam Makeba nella canzone che dà il titolo all’album del 1967: «Pata Pata è il nome di un ballo che facciamo in strada a Johannesburg. E tutti iniziano a muoversi non appena Pata Pata inizia a suonare – whoo. Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata».
Se la cantante e attivista sudafricana era stata soprannominata «Mama Africa», il rivoluzionario musicista nigeriano Fela Kuti (anche lui attivista politico: finì in carcere più volte nel suo paese per aver denunciato la corruzione), fondatore dell’«afrobeat», era «The Black President».
In Africa la musica è strettamente connessa con la politica (Hugh Masekela, Sonny Okosun, King Sunny Adè & his African Beats, Manu Dibango solo per citare alcuni musicisti) nonché con la moda. Basti pensare a Prince Nico Mbarga che con i suoi outfit (pantaloni a zampa d’elefante e stivali con la zeppa) influenzò tantissimi giovani, incluso il fotografo in tableaux vivants Samuel Fosso.
Tornando a «Mama Africa», è lei che nel ’94 acquistò dal couturier Pathé’O (a cui è dedicato il libro Pathé’O, pubblicato da Edition Patrick Frey nel 2023) quattro camicie che donò a Nelson Mandela, il quale ne indossò una dal design «vibrante» durante un viaggio ufficiale a Parigi.
Il volto del leader, come prima di lui quello del ghanese Kwame Nkrumah e, altra faccia della medaglia, del dispotico Mobutu campeggia sui tessuti celebrativi e propagandistici creati dall’industria tessile all’insegna dello slogan «freedom and justice».
Indossare un abito cucito con un tessuto dal determinato pattern ha un significato che va oltre l’apparenza: sottolinea l’identità e l’appartenenza a uno status sociale, religioso, politico.
La mostra Africa Fashion, ideata dal V&A Museum di Londra e organizzata da Ernestine White-Mifetu, Annissa Malvoisin, Catherine Futter, Matthew Yokobosky e Rhea Starkm al Brooklyn Museum di New York (fino al 22 ottobre), parte proprio da questa considerazione, analizzando il legame tra la moda e i paradigmi postcoloniali in relazione alle arti visive, soprattutto al linguaggio fotografico non solo come pura documentazione, con le opere di Seydou Keïta, Malick Sidibé, Hamidou Maiga, studio Z.J.S. Ndimande & Son, Lazhar Mansouri, J.D. Okhai Ojeikere, James Barnor, Kwame Brathwaite, Hassan Hajjaj e dei più giovani Zanele Muholi, Victor Omar Diop, Athi-Patra Ruga, Lakin Ogunbanwo, Daniel Obasi, Sarah Waiswa, Trevor Stuurman, Victoire Douniama.
Uno sguardo che intercetta musica e letteratura (da The Promised Land di Grace Ogot all’Opera poetica di Léopold Sédar Senghor) raccontando l’«africanità» sin dalle quattro edizioni del Festival mondial des arts nègres (FESMAN) organizzato tra gli anni sessanta e settanta a Dakar, Algeri, Kinshasa e Lagos.
All’appuntamento inaugurale, nell’aprile ’66, nelle tre settimane in cui si svolsero ininterrottamente performance musicali, teatrali, mostre d’arte e simposi accademici, giunsero nella capitale del Senegal oltre 25mila ospiti internazionali, tra cui il drammaturgo nigeriano Wole Soyinka, il pittore sudanese Ibrahim El-Salahi, il poeta e politico martinicano Aimé Césaire e poi Alain Locke, Duke Ellington, Miriam Makeba e Joséphine Baker. Per il presidente Senghor che lo tenne a battesimo (con il sostegno dell’UNESCO) focalizzare l’attenzione sul significato di «arte nera» fu l’occasione per promuovere non solo un senso di solidarietà globale tra gli artisti neri, ma il riconoscimento di una cultura che si emancipava dal colonialismo.
Furono organizzate anche sfilate di moda di stilisti africani e afroamericani che fecero dello «stile africano» un trend per l’industria internazionale. Il bellissimo grand boubou di organza verde con fiori ricamati d’argento appartenuto a Lalage Bown ne è un esempio: l’educatrice femminista inglese, autrice di Two Centuries of African English (1973), lo commissionò proprio nel ’66 a un sarto di Dakar e lo sfoggiò in diverse cerimonie. Un abito femminile e maschile di uso quotidiano, quindi, che veniva trasformato in indumento da grandi occasioni fuori dai confini locali.
Il processo di trasformazione della moda africana vede spesso l’impiego di tessuti come il coloratissimo wax print, frutto di ibridazioni storico-culturali, utilizzato anche dall’artista anglo-nigeriano Yinka Shonibare: in mostra è esposta Skipping Girl, parte dell’installazione Mother and Father Worked So Hard So I Can Play, 2009).
«Il contesto della creazione del wax, la sua popolarità da più di un secolo e la sua internazionalizzazione ne fanno un ricco crogiolo d’incontri fra culture – non privo di rapporti di dominazione. È forse per questo che sempre più artisti ricorrono al wax come mezzo di espressione. Servendosi di questa stoffa colorata attraverso una messa in scena poetica di apparente leggerezza cercano di rivelare le sfide politiche ed economiche che governano il suo destino», scrive Anne Grosfilly in Wax & Co. Antologia dei tessuti stampati d’Africa (L’Ippocampo, 2018).
Tra i tessuti più tradizionali vanno annoverati il kente, realizzato in Ghana dalle genti di etnia Akan unendo strisce di stoffe intrecciate e l’adire dal caratteristico color indaco che nella lingua degli Yoruba vuol dire «legare» e «tingere»: le tre tecniche principali con cui viene realizzato (oniko, alabere e eleko) impiegano elementi naturali come chicchi di mais, rafia, pasta di manioca, piume di pollo, calabash.
Tra «afrotopia» (prendendo in prestito il titolo del saggio di Felwine Sarr) e «global Africa», in uno scenario dell’immaginazione che offre stimolanti declinazioni per l’attivazione di nuove visioni legate al superamento dei limiti di genere con un approccio più sostenibile, arriviamo alla moda contemporanea.
Accanto alle sofisticate creazioni delle egiziane Aya e Mounaz Raouf, ad esempio, ecco gli abiti del nigeriano Bubu Ogisi (fondatore del brand IAMSIGO), il sudafricano Rich Mnisi con la sua collezione PRIDE o Ibrahim Kamara che ha sfidato le nozioni convenzionali della mascolinità black.
È fondamentale, però, ricordare il lavoro pionieristico di Kofi Ansah (1951-2014), enfant terrible della moda ghanese, del maliano Chris Seydou (1949-’94) e della nigeriana Folashade ‘Shade’ Thomas-Fahm (1933), che è stata la prima donna ad aprire una boutique a Lagos dopo aver studiato moda al Saint Martin’s School of Art di Londra.
Fin dagli anni sessanta ‘Shade’ ha impiegato tessuti della tradizione Yoruba per realizzare i suoi modelli originali in cui mette «uno stile contro l’altro», magari una gonna di taglio occidentale con l’iro, «stili che hanno entrambi qualcosa da imparare l’uno dall’altro».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento