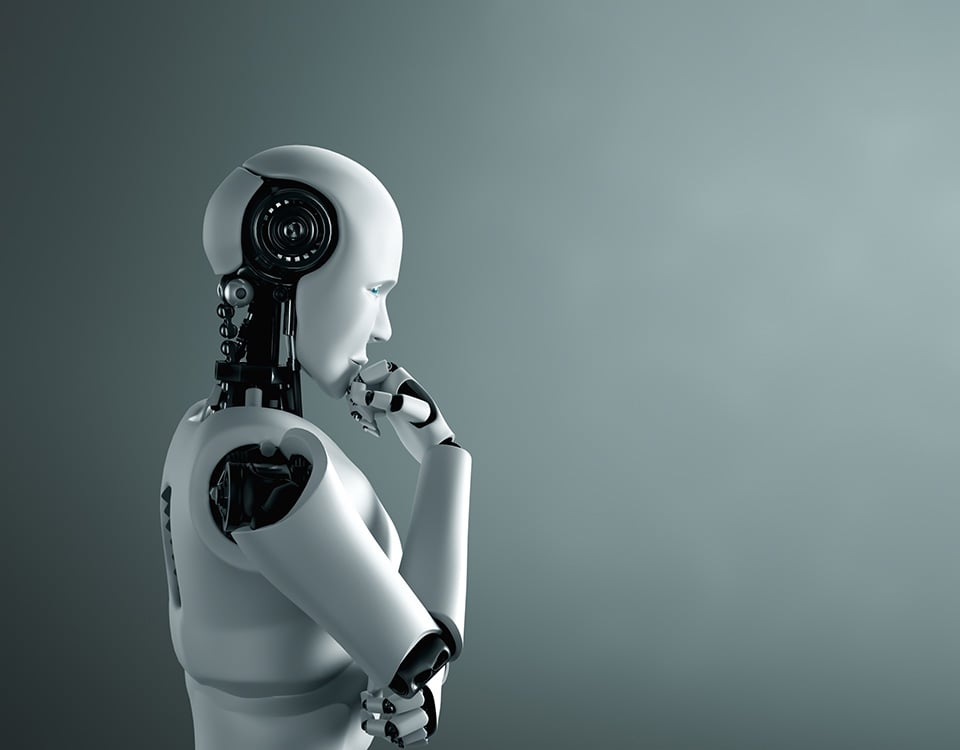Una sentenza in Ecuador scagiona l’hacker amico di Assange
Ola Bini Nel 2019 fu rinchiuso due mesi e mezzo in una cella di Quito, senza che gli fosse neanche comunicato il reato contestato

Ola Bini Nel 2019 fu rinchiuso due mesi e mezzo in una cella di Quito, senza che gli fosse neanche comunicato il reato contestato
Libero. Libero perché “non colpevole”, perché non ha commesso alcun reato. Dopo quattro anni di persecuzione giudiziaria, dopo settanta giorni di carcere. Persecuzione che comunque potrebbe ancora andare avanti, visto che il pubblico ministero ha già presentato ricorso.
Ma tutto ciò oggi passa in secondo piano, perché Ola Bini ora è libero. Libero di continuare la sua vita di hacktivist, di militante per i diritti digitali, di continuare le sue battaglie per i diritti umani.
La sentenza del tribunale di Quito, la capitale dell’Ecuador – che ha sorpreso positivamente tutti gli osservatori – è arrivata con un po’ di suspense, dopo sei ore di camera di consiglio. All’uscita, al momento della lettura del verdetto, c’erano le telecamere di quasi tutto il mondo.
Sì, perché Ola Bini, quarant’anni, nato in Svezia, è un nome famoso. Amico, molto amico di Julian Assange, arrivò nel paese sudamericano, dove il fondatore di Wikileaks aveva trovato rifugio nell’ambasciata inglese. Lì, in Ecuador, Ola Bini diede una mano a creare il Center for Digital Autonomy, un’organizzazione che si occupa della difesa della privacy contro le ingerenze dei governi autoritari. Tema – com’è facile capire – assai sentito in tutto il Sud America.
La redazione consiglia:
Il caso Assange: una democrazia senza giustiziaMa come per il suo amico, anche per Ola Bini tutto cambiò la mattina dell’11 aprile del 2019. Il governo, il nuovo governo di Moreno aveva deciso di subire le pressioni “occidentali”: ad Assange fu negato l’asilo e fu trascinato in manette fuori dall’ambasciata inglese (come sanno tutti, finì in carcere a Belmarsh, dove è ancora detenuto, con lo spettro di essere trasferito negli States), lui fu arrestato all’aeroporto. Non stava scappando, era diretto a Tokio, per una gara di karate, sport che praticava.
Contro di lui, il governo ecuadoregno – a cominciare dalla ministra degli interni, Paula Romo – imbastì una gigantesca montatura giudiziaria. Nel 2019 fu rinchiuso due mesi e mezzo in una cella di Quito, senza che gli fosse neanche comunicato il reato contestato. Poi, i giudici fedeli al governo lo accusarono di “cospirazione contro lo Stato” ma durò poco. Ben presto, si cambiò di nuovo capo d’imputazione: divenne “ingresso non autorizzato in sistemi digitali protetti”.
Si è andati avanti così, per quattro anni, con queste giravolte. Anche con clamorose gaffe da parte dei giudici, come quella volta che chi lo doveva giudicare, in aula, tranquillamente spiegò di aver avuto un colloquio col governo a proposito dell’imputato. Quest’assurdo iter giudiziario è stato anche accompagnato però da una mobilitazione vastissima, in prima fila Eff, AccessNow e tante altre associazioni. Che hanno permesso a Ola Bini di disporre di un buon gruppo di avvocati. Che alla fine l’hanno spuntata.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento