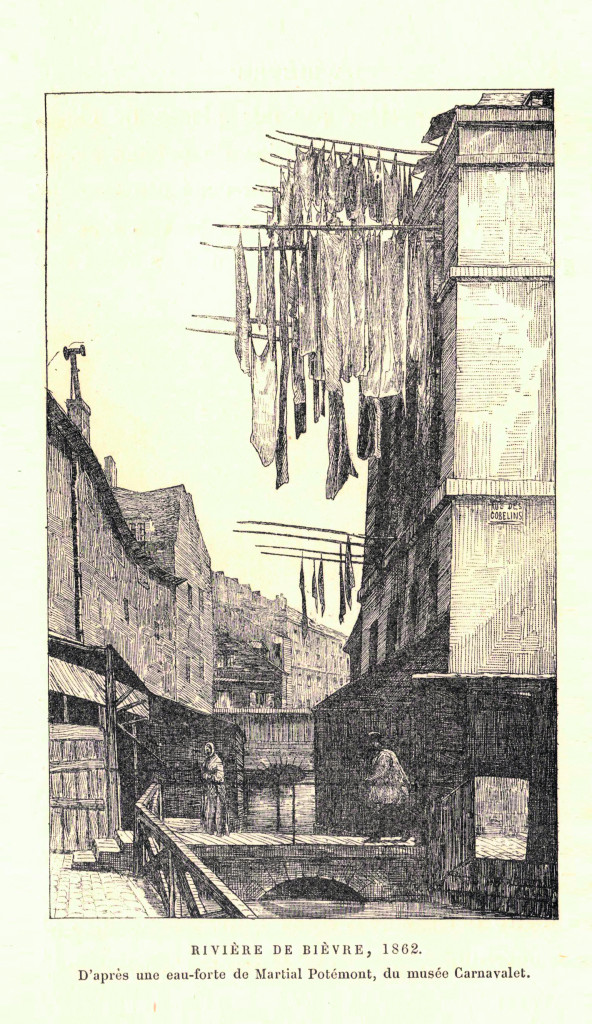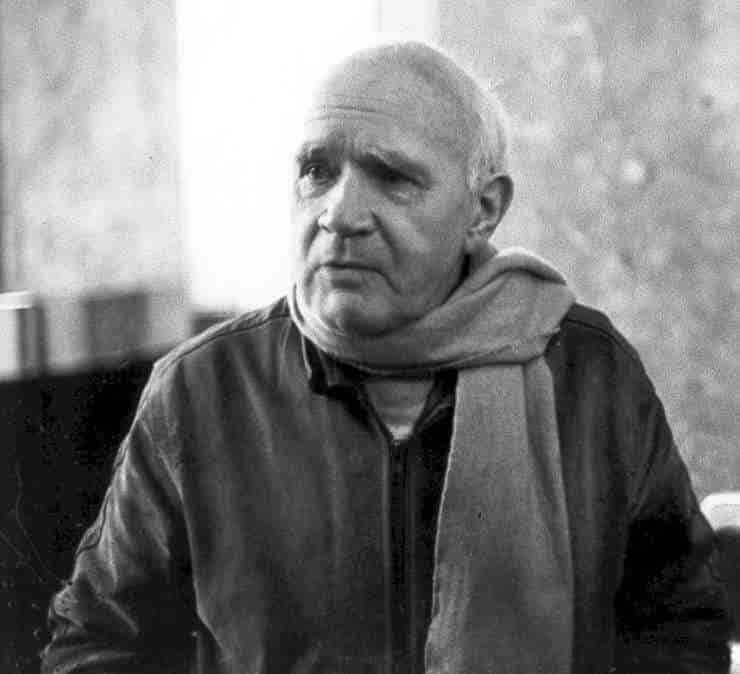Tra utopia e ateismo: Sade, un filosofo
L’epigrafe che Pier Paolo Pasolini appone al suo film estremo, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), riassume la bibliografia secolare che concerne l’opera del marchese Donatien-Alphonse-François de Sade (1740-1814) tratta dall’Enfer della Biblioteca Nazionale di Francia in cui l’avevano reclusa e negata alla pubblica memoria i contemporanei e i posteri immediati. Perché se a lungo Sade è stato ritenuto un autore scandaloso e infame per antonomasia, il secolo delle avanguardie ne ha riscattata la memoria nel segno di un estremismo rivoluzionario dove la trasgressione o anzi l’eversione di ogni regola del vivere civile culminava in un perfetto nichilismo: non per caso in quella stessa bibliografia (dove pure era assente un Georges Bataille) sfilavano i nomi di Roland Barthes, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, Philippe Sollers e di Simone de Beauvoir, autrice nel ’55 del libello a suo modo apologetico Faut-il bruler Sade? Nel senso comune, a lungo ribadito, rimaneva comunque l’immagine di un utopista pornografico, di uno scrittore grafomane e noioso o insomma quella di un délirant philosophe: una immagine, appunto, che neanche l’edizione dell’opera intera e finalmente uscita dalla clandestinità (prima da Pauvert fra il ’54 e il ’58, poi in tre volumi nella «Pléiade» fra il ’90 e il ’98 a cura di Michel Delon e Jean Deprun) aveva potuto smentire e qui basti ad esempio rammentare che ancora di recente un grande libro sull’epoca dei Lumi, Una rivoluzione della mente (Einaudi 2011) di Jonathan Israel, non fa menzione alcuna di Sade.
Che le cose, quanto a ciò, stiano oggi cambiando è riprova l’uscita del notevole studio di Marco Menin, ll sole nero dei Lumi Sade filosofo (Carocci editore «Frecce», pp. 326, euro 29,00), che propone una biografia intellettuale e insieme il profilo teorico di un autore da sempre ritenuto estraneo o liminare rispetto alla storia della filosofia. Operando con precisione filologica e chiarezza espositiva (cui non guasta un certo piglio didascalico), Menin muove dalla consapevolezza che il pensiero di Sade si dà «attraverso la finzione letteraria e grazie a essa» e che dunque la sua filosofia ha non soltanto le caratteristiche della non sistematicità e per lo più della clandestinità ma soprattutto essa prende corpo nei modi della fiction. Non basta, perché Menin lavora nella intersezione e nei raccordi fra i due piani dell’opera sadiana, in cui da un lato c’è la notissima produzione proibita (le cui vette romanzesche sono Justine, in tre differenti edizioni fra il 1787 e il ’97, e la corrispettiva Juliette, 1801, con l’antefatto grandioso e inconcluso de Le centoventi giornate, 1785) mentre dall’altro sopravvive, seppure malnota e sottovalutata, la serie emersa degli «scritti onesti», fra racconti, romanzi e pièces molto convenzionali, come fossero scritti da un Sade senza il sadismo (testi talora addirittura rugiadosi, da emulo di un Bernardin de Saint-Pierre) tra cui Les crimes de l’amour. I Lumi di Sade, va da sé, hanno una luce rovesciata che dilaga svelando l’unica «naturalezza» accessibile all’uomo: quella del vizio, del crimine, della distruzione dove via via trionfa un edonismo di segno invertito. Ne sono emblemi le eroine della virtù perseguitata e/o del vizio virtuoso quali Justine, vittima di un sistema di umiliazioni che non può avere né requie né fine, e la sua consorella Juliette che viceversa metabolizza il male alla stregua di una sistematica vittoria del bene.
La monografia di Menin è scandita dalle parole-chiave della rubrica filosofica a partire dal termine «materialismo» che lo studioso legge sia nel profondo interesse di Sade per la medicina sia nella ricezione dell’ardito ateismo di un La Mettrie, di Helvétius e specialmente del barone d’Holbach (anche se nella pur accurata appendice bibliografica non si rammenta l’uscita italiana de Il buon senso – Garzanti 1985 – per la versione e curatela, nientemeno, di Sebastiano Timpanaro) senza escludere il rapporto costante e sempre controverso con Rousseau di cui Sade si sente un discepolo eretico accettando l’esistenza del «sentimento» ma a patto di mantenerlo sotto il dominio dell’esprit. Perché Sade sarà pure un libertino sentimentale (le sue eroine erotiche, le Justine e le Juliette, non sono altro che le Pamele e Clarisse di Samuel Richardson rovesciate), ma resta libertino tout court la cui ricerca della felicità è caratterizzata, per usare le parole dello studioso, da «isolismo» (egoismo costitutivo, assenza di legami affettivi e sociali), «intensivismo» (ricerca imperiosa della propria soddisfazione), «antifisismo» (pratica elettiva della sodomia, dagli evidenti tratti misogini): «Nella centralità e nell’ineludibilità della dimensione passionale si ritrova il principio fondamentale dell’immoralismo dei libertini sadiani. (…) In una simile prospettiva, ogni individuo segue esclusivamente il proprio interesse e, al di là di tutte le ipocrite giustificazioni a posteriori che può fornire a sé stesso o agli altri, non sarà mai in grado di rompere l’originaria alleanza tra egoismo e soddisfacimento delle passioni».
Al riguardo, è di particolare interesse il capitolo che Menin dedica al rapporto fra Sade e la Grande Révolution, un rapporto tutt’altro che pacifico nonostante lo scrittore, rampollo della più esclusiva aristocrazia, sia stato perseguitato dall’Antico Regime (con decenni di reclusione alla Bastiglia) e messo al bando dalla società in quanto corruttore recidivo e firmatario di scritti mostruosi. Ciò nonostante un Sade sanculotto non è mai esistito così come non è mai sentito un «trasgressore» (nel senso in cui lo hanno letto le avanguardie del Novecento) ma semmai un utopista lettore di Rousseau come di Hobbes, da cui ha dedotto la convinzione che l’uomo è parte di una società ferina e pertanto è necessario alla sua sopravvivenza un patto sociale.
Ma il patto sociale di Sade non può essere che un patto sociale libertino (per cui «il desiderio prende il posto della legge positiva») che non fonda alcuna democrazia ma istaura e garantisce, al contrario, una gerarchia desiderante e una vera e propria tirannide lussuriosa il cui progetto, già nelle Centoventi giornate, è chiaramente delineato. Sade smise di essere un codino nella prima giovinezza, accolse con qualche ambiguità la Rivoluzione fino ad accettarla ma fu nemico di Robespierre e inviso ai giacobini, nonostante si sentisse in cuor suo un buon repubblicano e avesse firmato degli opuscoli politici pari al proclama solennemente intitolato Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani e incluso nel quinto dialogo della Philosophie dans le boudoir. È che per lui l’immoralismo è appena uno stoicismo alla rovescia che scatena la passione, il vizio, attraverso la raison e nel suo caso, alla lettera, la déraison.
Qui si evidenzia il nesso sadiano fra utopia e ateismo nei modi, ancora una volta, di una teologia rovesciata e blasfema per cui negli esseri umani il vero peccato originale è l’idea di Dio, quasi che, in una società fondata sul crimine, risorga di continuo la necessità di un Dio da bestemmiare. Un Dio del tutto immaginario, beninteso, e però non meno necessario se il vecchio marchese internato nel manicomio di Charenton alle porte di Parigi, come lo si vede nel dramma di Peter Weiss che Pasolini esclude dalla sua bibliografia (La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentato dalla compagnia filodrammatica dell’ospizio di Charenton sotto la guida del marchese de Sade, traduzione italiana di Ippolito Pizzetti, Einaudi 1967), può pronunciare in pubblico parole tanto sconsolate e, paradossalmente, così rassicuranti: «Per me, l’unica realtà è l’immaginazione, il mondo dentro di me».
***
Tableaux vivants sessuali con Eugénie, un caso di pedagogia illuminista
Non è certo infondato lo stereotipo che bolla Sade come scrittore prolisso e sommamente noioso ma esistono delle eccezioni e fra queste senz’altro La filosofia nel boudoir (prefazione di Michele Mari, Einaudi «Gli struzzi N.s.», pp. XIX-250, euro 16,00) che ora torna nella strepitosa versione di una delle voci poetiche del nostro tempo, Patrizia Valduga, ricca di una autentica panoplia verbale (specie nel linguaggio scurrile che qui attinge vette rabelaisiane) e del dono ritmico e metrico che peraltro è proprio della sua poesia.
Concepita nel vivo della produzione sadiana (l’opera risale al 1795, scritta in pieno Termidoro, fra la seconda e la terza stesura di Justine) la Philosophie utilizza una struttura multipla. Si tratta innanzitutto di un romanzo di formazione, naturalmente a schema rovesciato, ed è diviso in sette dialoghi, dove si tratta di una innocente e bellissima fanciulla di famiglia aristocratica (Eugénie, nome antifrastico) che viene in poche ore depravata e trionfalmente avviata alla dissolutezza dalla bellissima (e già corrotta) Madame de Sainte-Ange, altro nome antifrastico, e dall’ineffabile Dolmancé, filosofo immoralista e diretto portavoce di Sade medesimo, un autentico filosofo della sodomia.
Deducendo, ma soltanto per sconciarlo, il classico schema della giovane perseguitata, lo scrittore parodizza i pur amati Bernardin de Saint-Pierre (Paul et Virginie) e Samuel Richardson (Clarissa, Pamela) ma dà vita nel frattempo a un apprendistato di impronta teatrale, una specie di marivaudage in cui gli attori a partire da Eugénie, nella sequenza potenzialmente infinita degli incastri sessuali, si prestano a tableaux vivants di taglio didattico. Ma vi si notano un tocco leggero, un brio e persino una sventata leggerezza che è raro trovare nell’opera di Sade nonostante, come al solito, vi abbondino diffusi elogi della perversione e del crimine nonché una interminabile tirata di natura politica che occupa il quinto dialogo (una apologia rivoluzionaria e insieme antigiacobina che comincia con un enfatico: «Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani»). Eugénie è dunque un caso speciale di pedagogia illuminista dove (scrive Marco Menin ne Il sole nero dei Lumi, Carocci) «proprio la fiducia nella malleabilità dell’essere umano e l’esaltazione di una corretta pratica educativa rappresentano significativi punti di contatto tra l’immoralismo di Sade e il pensiero canonico dei Lumi».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento