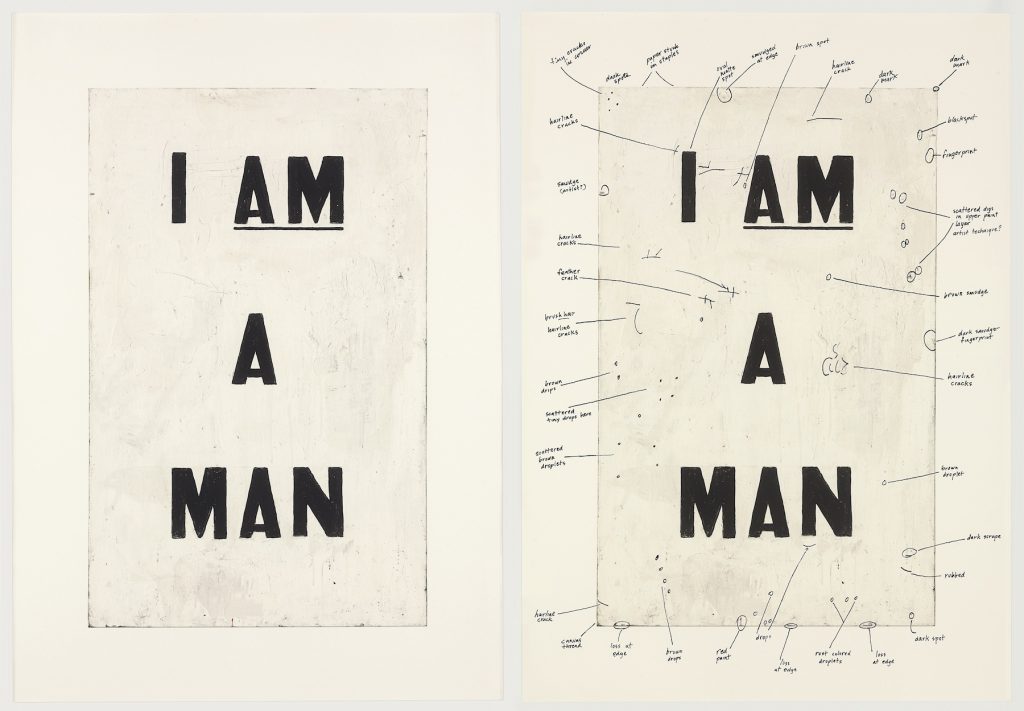Theodor Däubler, cosmogonia messianica espressionista
Scrittori mitteleuropei «L’aurora boreale» di Theodor Däubler (1910), poema visionario in oltre trentamila versi: arriva in italiano, con testo tedesco a fronte, da Marsilio
 Wassily Kandinsky, «Mit Sonne», 1911
Wassily Kandinsky, «Mit Sonne», 1911Scrittori mitteleuropei «L’aurora boreale» di Theodor Däubler (1910), poema visionario in oltre trentamila versi: arriva in italiano, con testo tedesco a fronte, da Marsilio
«Viviamo noi nel sole! Persino l’anima è in noi solare!». Suona così un verso dell’Intermezzo Orfico posto da Theodor Däubler fra le due sezioni del monumentale poema Nordlicht (Aurora boreale), quale pausa meditativa che dischiuderà le porte di quella finale, Sahara – cioè della «solitudine del deserto dalla quale l’Io può irradiarsi puramente» – al lettore giunto all’ultima strofe di Das Mittelmeer, la parte iniziale, dedicata allo splendore delle città italiane, Venezia, Roma, Firenze, Napoli, cioè «al mondo della cultura che possediamo, nel quale l’Io può afferrarsi». Per le cure di Luigi Garofalo e nei versi di Paolo Ruffilli, basati sulla versione letterale di Marcello Montalto, L’aurora boreale Prima parte. Mediterraneo (testo tedesco a fronte, Marsilio, pp. 1013, euro 55,00) presenta oggi al pubblico italiano quella prima sezione e, appunto, l’Intermezzo.
È questo in realtà il secondo volume di un’edizione integrale inaugurata nel 2022 con la traduzione, sempre curata e introdotta da Garofalo, arricchita dai saggi del traduttore Andrea Sandri e di Fulvio Cortese, della Selbstdeutung, la prosa autoesplicativa che Däubler ha affiancato alla sua opera nel 1920 (L’aurora boreale. Autointerpretazione, Marsilio, pp. 207, euro 30,00): e l’impresa, concepita nella collana «Firmamenti» che Garofalo dirige per l’editore veneziano insieme a Maurizio Bettini e Massimo Cacciari, è certo sotto ogni riguardo straordinaria, sia per la qualità e la mole del lavoro, sia per il tenore nel contempo di sfida alla logica del mercato culturale e di dovuta restituzione. A vent’anni dall’edizione critica tedesca (curata da Stefan Nienhaus, Dieter Werner, Paolo Chiarini e Walter Schmitz per Thelmen) viene infatti presentato per la prima volta nella nostra lingua un poema fra i più estesi (trentamila versi) e indubbiamente più misconosciuti del Novecento, che ha impresso la sua traccia singolarissima, visibile a pochi ma eccezionali lettori, nella temperie culturale che Ladislao Mittner definiva sotto l’insegna dell’«anno-limite 1914».
Iniziato dal ventiduenne triestino nel 1898, «ai piedi del Vesuvio, in lingua tedesca», stampato nel 1910 nella prima edizione «fiorentina» e poi dieci anni dopo in quella «ginevrina» (completa dell’autointerpretazione), il poema sul mito dell’aurora boreale è una complessa e affascinante anche se a tratti macchinosa cosmogonia messianica, incentrata sull’idea di un ricongiungimento della luce interiore dell’anima con quella del sole annunciato dal segno permanente della luminosità polare irradiata dal nostro pianeta. È dunque una cosmogonia impregnata del pathos per cui l’autore stesso usò il nome fatidico di espressionismo, senza peraltro (quasi come in certe lettere in cui si lamentava dell’editore Insel, che avrebbe puntato su Rilke lasciandolo in secondo piano) peccare di modestia; il giudizio secondo cui gli espressionisti «veri» e «puri» furono «figure di terzo e quart’ordine, figure spesso imposte dalla reclame, proprio perché soltanto rappresentanti paradigmatici dell’espressionismo “vero” e “puro”» (Mittner) appare anzi magnanimo di fronte al bilancio stilato da Däubler: «in definitiva ci sono stati soltanto due poeti espressionisti: Rimbaud, io. Bencher e Herzfelde sono troppo piccoli. (…) Rimbaud ce l’ha fatta. Le mie grandi opere superano quelle del giovinetto». Egli è dunque espressionista, e capace di spingere in primo piano la funzione ritmica della lingua facendo vibrare e insieme strutturando l’immane costruzione di Nordlicht nel battere serrato di una rima che altri, veri, puri e piccoli, lasciavano invece sommergere dal flusso immaginifico. E per il giovane bilingue, nato a Trieste da padre svevo e madre slesiana, vissuto a Vienna, dove si era trasferita la famiglia nel 1898, e poi, in una vita da bohémien, tra Parigi, Berlino, Dresda, Monaco, Firenze e Roma, Ginevra e Atene, per questo sodale di Trakl, Lasker-Schüler, Blei, Marc, Kandisnky, Dix, Grosz, Marinetti, Papini e Carl Schmitt, il ritmo era quello della parola materna. Era, meglio, la misura di un tedesco del tutto proprio e generato con «drammatica rapidità», al quale però, nel «conflitto decisivo» fra le opposte influenze dei genitori, radicali illuminati, e dei domestici cattolici, fra la mancanza di fede e l’inclinazione mistica, fra i primi rudimenti scientifici e l’immaginazione mitizzante, venne in risolutivo aiuto l’italiano.
La nozione laicissima che la vita viene dal sole (die Sonne è femminile) confluì allora in una «fanciullesca mitologia privata» che era innanzitutto una «collocazione italiana dei sessi nel firmamento». La luce solare poteva apparire così «paterna, la terra materna, la luna indecisa, ma con un forte tratto femminile». E insieme doveva divenire gradualmente chiaro che all’inizio tutto era nel sole, che la luna e il sole erano all’inizio lo stesso, e che il sole è il dio e il signore delle stelle separatesi drasticamente da lui ma destinate al ritorno. Dunque «noi siamo sole e terra. Con i sensi esterni vediamo il suolo sotto di noi, il sole sopra di noi. Con il senso interno siamo una sola unità». Sicché anche la terra ha il sole in sé, e proprio ai poli, dove la notte è più profonda e potente, «un luminoso amplesso tra il sole liberato dalla terra e il sole celeste apporta la luce solare alle notti lunghe mesi». Con le parole del Prologo di Mediterraneo: «Per amore del sole la notte viene irradiata»; e se i pianeti custodiscono ed emanano la luce d’amore, questo baluginare viene còlto, come poi più compiutamente in molte strofe di Sahara, nella tenebra dell’epoca, o, con il topos espressionista estenuato, sotto la «luna insanguinata».
Däubler non si soddisfa però di questa opposizione: la sua opera non è assimilabile al dualismo di spirito (Geist) e anima (Seele), conoscenza come possesso e vita nel mondo inafferrabile delle immagini, che Ludwig Klages aveva imposto alla scena culturale tedesca. No, in lui tutto è anima (anche se si chiama spirito), come ha rilevato il suo interprete per eccellenza, Carl Schmitt: e proprio «l’orribile notte», cioè l’immagine della modernità meccanicistica còlta obiettivamente nella sua miseria, è necessaria per spingere la pur tenue luce interiore e il sole terreno verso le altezze del vero sole e della luce spiritualmente pura.
Esistenzialmente fedele a tale tensione, Däubler aveva d’altro canto partecipato, a ridosso della Grande Guerra, all’incredibile, fallimentare esperimento di vita e «rivoluzione basata sulla pura forza dello spirito» del Forte-Kreis, che riunì intellettuali come Buber, Florens Christan Rang, Gustav Landauer e Walter Rathenau: una «comunità pneumatica perfetta» i cui sodali, solo convivendo per un certo tempo e coltivando lo scambio creativo e senza remore dei pensieri, avrebbero dovuto, con le parole di Gershom Scholem, «scardinare il mondo e modificare alle radici la cultura europea».
Se Däubler condivise il bizzarro tentativo con Rathenau, va però ricordato che questi era allora, con Thomas Mann e l’odiatissimo Karl Kraus, un bersaglio della più dura e insolente polemica da parte di Schmitt. Legato da parte sua al poeta da un’amicizia ammirata e dalla frequentazione degli anni di Schwabing, ad Aurora Boreale il giurista aveva dedicato un saggio nel 1910 (pubblicato postumo), uno molto più organico e conosciuto del 1916, nonché diverse annotazioni del Glossarium e le pagine, fra tutte le più note, di Ex Captivitate Salus (1950). Qui non solo Schmitt riconosceva la possibile fonte d’ispirazione dell’Aurora boreale in una nota di Proudhon sul destino della Terra (per cui l’umanità dovrà morire col suo pianeta se non saprà sublimarsi in spirito) e individuava nella stupefacente conoscenza intuitiva dei Misteri, nelle conoscenze tratte anche da conversazioni come nell’«influenza incalcolabile di Bachofen» i nutrimenti del grande poema panteista, ma ne coglieva soprattutto la straordinaria capacità di assorbire ogni parola e ogni concetto facendoli risplendere e risuonare in una «simultaneità illimitata». La formula è illuminante, e a ben riflettere non solo rende finalmente intelligibile la tonalità genuinamente espressionista del poema «così pieno di vita» e di immagini unite in un unico tempo rimico, ma fa anche trasparire un esito perlomeno anfibiloco, che non sarà però Schmitt a rilevare. Non in una rozza opposizione dualistica, ma in simultaneità si danno infatti anche l’anima luminosa e la notte orribile, la salvezza e la «più profonda sicurezza» o lo «scintillio dolce» della morte. Perciò un aforisma famoso non cita i versi di Rimbaud, ma di Trakl, con quelli di Däubler, spiegando che «l’unità dell’espressionismo risiede nella presa di coscienza e nell’enunciazione del fatto che gli uomini, interamente estraniati gli uni dagli altri (…) sono diventati, per ciò stesso dei morti». Adorno scripsit.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento