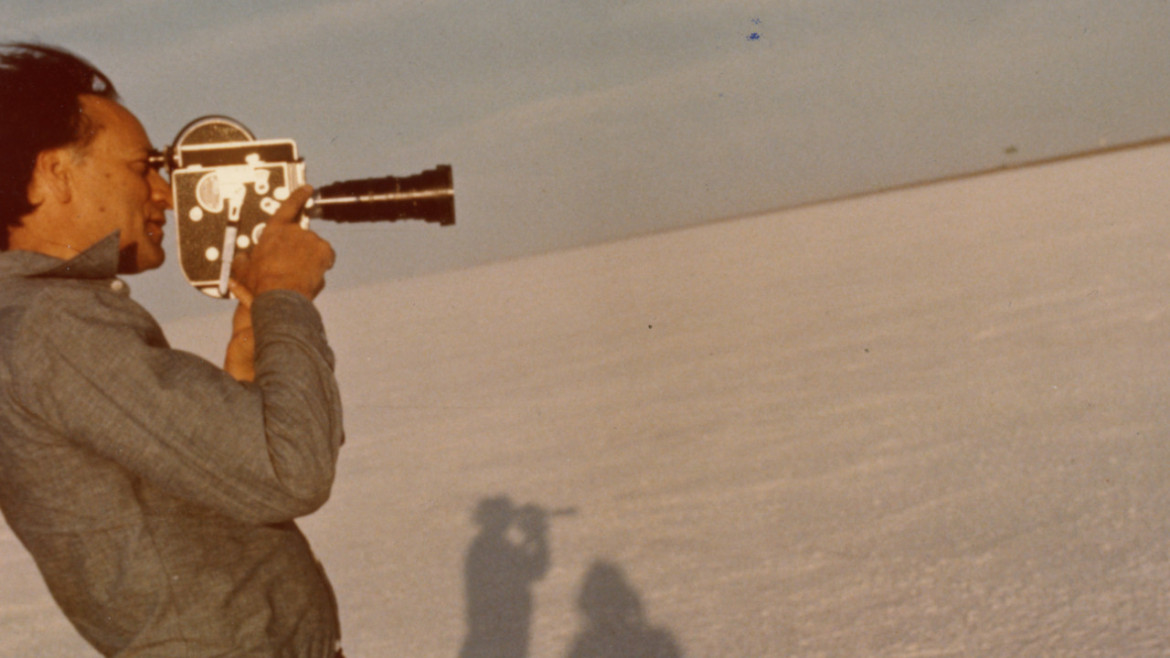Theo Montoya: «La mia Medellìn, inferno di giorno e città dell’amore di notte»
«Ho messo in scena la mia morte, un atto simbolico per cercare un contatto con i miei amici». Così Theo Montoya, regista colombiano nato nel 1992, parla del suo Anhell69 presentato in concorso alla Settimana della critica. Un film oscuro, dove la città di Medellìn sembra un buco nero che in qualsiasi momento può inghiottire nelle sue viscere un amico, un’amica, un genitore. I padri non ci sono più, al loro posto c’è la figura «mitica» di Pablo Escobar, considerato un esempio. Sono in tanti a morire in Anhell69, per droga, violenza dei narcos o brutalità della polizia, eppure in queste atmosfere da fine del mondo c’è una comunità di giovani che trova la forza di esprimersi, di liberarsi, e di essere gioiosi al di là di ogni stereotipo. Montoya fa parte del gruppo, ne condivide le sofferenze così come gli atteggiamenti di sfida, e realizza un film che racconta il suo stesso modificarsi, una «película trans».
Eri partito dall’idea di realizzare un lavoro di finzione, ma poi è come se la realtà fosse stata troppo forte per essere contenuta. Quando hai capito che il film si stava trasformando in un anomalo documentario?
Bisogna essere aperti nei confronti della vita per capire quali messaggi ti sta mandando. Ho capito di avere un altro film nella mia mente dopo la morte di alcuni miei amici, ma anche guardando al contesto politico del Paese. C’è il pregiudizio per cui si è un vero cineasta solo quando si realizzano film di fiction, ma a me sembra che nel documentario si può esplorare di più, con un approccio meno rigido anche nella produzione. L’idea era comunque quella di mescolare la fiction e la realtà, cosa che trovavo più interessante, e si è trasformato poi in un processo anche terapeutico per me.
Molti dei tuoi amici intervistati dicono di non riuscire a immaginarsi nel futuro.
Penso che il film sia molto filosofico perché il futuro, non essendo reale, implica sempre l’immaginazione di qualcosa, ma è molto difficile immaginare a Medellìn visto il contesto politico e l’umore della città. Quindi si potrebbe dire che non c’è futuro in Anhell69, ma in un certo senso invece c’è, perché c’è un gruppo di persone che sta insieme, che crea una strana famiglia. E se il futuro è nel presente, allo stesso modo si arriva alla conclusione che la morte è essere vivi. È un’ambiguità che riguarda diversi temi, per me è molto importante il processo di decostruzione in cui è compreso anche il genere.
Com’è stato per te da un punto di vista emotivo? Come dicevi, la morte è una presenza forte.
Ne avevo molta paura, immaginarmi in una bara mi spaventava molto, ritrovarmici per girare la scena però è stato potente e ora non sono più così terrorizzato: è l’idea di psicomagia di Jodorowsky. Il punto è che vivendo così vicino ai morti, percepiamo la fine della vita in modo diverso.
Si può solo sostare nelle ferite di Medellìn o possono essere affrontate in qualche modo?
La sofferenza è connessa al piacere, nel film sono centrali gli istinti di base. Medellìn è l’inferno, ma può essere anche il paradiso. Questi contrasti sono molto forti, paradossalmente di giorno è una città violenta ma di notte diventa una città dell’amore.
Filmare è un atto che ti proietta nel futuro oppure no?
I buoni filmmaker per me sono connessi con se stessi in una maniera un po’ spirituale, e l’unico modo per riuscirci è essere presenti lì dove si è.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento