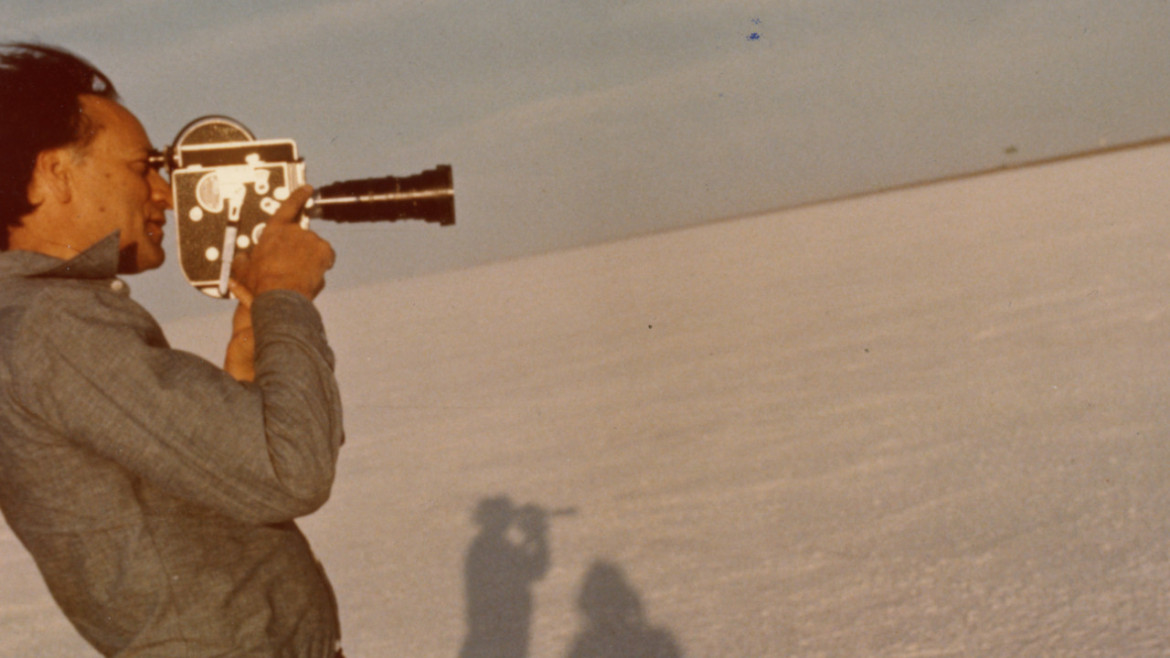Strappare il velo e nominare il dolore ne «L’immensità»
Venezia 79 Presentato in concorso il film di Emanuele Crialese con protagonista Penelope Cruz, sarà nelle sale dal 15 settembre. La famiglia come luogo archetipico del disagio, una sessualità da riconquistare
 Penelope Cruz in «L’immensità» – foto di Angelo Turetta
Penelope Cruz in «L’immensità» – foto di Angelo TurettaVenezia 79 Presentato in concorso il film di Emanuele Crialese con protagonista Penelope Cruz, sarà nelle sale dal 15 settembre. La famiglia come luogo archetipico del disagio, una sessualità da riconquistare
Le cene silenziose intorno alla tavola coi bambini e la mamma truccata e splendida – «Ma tu – le dice l’amata figlia – ti trucchi solo quando piangi o quando devi uscire» – e la leggerezza soffocata appena il padre mette piede a casa tornando dal lavoro, ci dicono già tutto sulla famiglia protagonista di L’immensità. Una ricca borghesia degli anni Settanta romani, di attici nei quartieri nuovi affacciati sul Cupolone – chissà se simbolico mantenimento di ordine o anelito alla bellezza – nei quali la realtà «esterna» non entra mai se non nel bianco e nero della tv accesa sui sogni iconici di Raffaella Carrà e Patty Pravo. I conflitti del tempo non esistono, e a proteggerli dai poveri ci sono i campi che verranno inghiottiti come le baracche dalle gru dei palazzinari.
MA QUESTA è un’altra storia. O forse no, chissà. Che racconta dunque L’immensità, la cui proiezione al Lido, terzo titolo italiano del concorso e in sala il 15 settembre, è stata preceduta dall’eco sulla biografia del regista, Emanuele Crialese – di cui il film dovrebbe essere il «resoconto» – e dal suo «coming out» di persona trans nata bambina e divenuta uomo? Un fatto del tutto marginale non solo perché (ovviamente) qualcosa di sé c’è sempre nelle storie che si raccontano, fosse pure un dettaglio di stile, e il «vero», quel «based on a true story», «tratto da una storia vera» che tanto piace sembra appiccicarsi lì solo per garantirne una «verità» che sappiamo è sempre altrove. L’immensità non è un’autofinzione, la sua materia non riguarda l’esperienza della transizione in sé (magari il suo desiderio) quanto la ricerca di più figure in questo paesaggio opulento di un proprio e diverso spazio nel mondo negato dalle regole, dal rito sociale privato e collettivo, dalla cultura, dall’educazione. Soggetto questo ricorrente nei film visti in questi giorni al Lido, quasi un segno dell’era contemporanea che riguarda molte cose, il gender, la sessualità, ma soprattutto quel contrasto sottile, a volte indefinito di ciascuno rispetto a una libertà di superficie.
E LA FAMIGLIA è il terreno che Crialese sceglie come archetipo esperienziale per la sua narrazione, un luogo di disagio e di solitudine nel quale gli elementi di disturbo, quasi speculare, divengono la madre e la figlia, le sole a «nominare» in qualche modo il proprio malessere anche se non sempre con le parole. Adriana (Luana Giuliani) aspetta ogni giorno un segnale dal cielo, un extraterrestre che la venga a prendere per portarla via da un mondo al quale non sente di appartenere. A chi non la conosce si presenta come Andrea, il suo corpo di femmina le dà fastidio, lo sente come un peso, una prigione; e non si tratta solo delle fantasie sulla bionda monaca della scuola sotto al velo o della scelta di vestirsi da maschio, c’è qualcosa di più profondo che lei sa definire: «Mi avete fatta sbagliata» ripete alla madre. Quest’ultima – Penelope Cruz – è una donna seducente, gli uomini con grande fastidio di Adriana/Andrea la guardano con insolenza: lei canta, balla, anche apparecchiare la tavola diventa un musical con lei come quelli in tv. Però è infelice, il matrimonio è finito, e lei non si sente a suo agio tra parrucchieri, rotocalchi, pasti silenti, vacanze nel lusso, la canasta con le altre mogli nel patto mai detto di accettare tutto per mantenere la facciata, pure i tradimenti continui dei mariti, le umiliazioni, nel suo caso persino la violenza. Quella sua fisicità di meraviglia è il segno visibile di un malessere a cui non sa trovare a differenza della figlia una parola ma che fa esplodere – letteralmente – nei gesti infantili, nei capricci un po’ provocatori, un po’ bizzarri, in quella giocosa voglia di stupire piena di dolore che è la sua battaglia.
IL CORPO di abiti eleganti e pigiamini d’epoca è dove tutto traspare prima delle parole: quello non riconosciuto di Adriana che non si guarda mai allo specchio, non si toglie la maglietta nemmeno al mare, col cuore che batte al primo bacio alla bambina figlia di operai per lei proibita, e con l’orrore per il vestito scozzese da ragazzina imposto dalla nonna. Ma anche quello della sorellina troppo magra perché non mangia più, o del fratello ciccione che invece mangia sempre e fa la cacca in casa, tristezza diffusa in quell’interno famigliare che va taciuta e così fugge lì, attraverso l’unico bene che può affermare una qualsiasi ribellione. Nel mettersi in gioco Crialese, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Francesca Maineri e a Vittorio Moroni, sceglie una cifra controllata, non urla e sviscera ma al contrario si muove sotto traccia: il suo melodramma risuona come una canzonetta o nella lacrima di Love Story. Forse ci sarebbe piaciuto un gesto meno «giusto», anche nel caos dei sentimenti? Forse. E però qui l’intimità non è, non vuole essere sovraesposizione personale, piuttosto prova a spostare un vissuto (il proprio) costellato di tentativi e scelte faticose, verso una dimensione comune nella quale ciascuno può riconoscersi, quell’inquietudine più vasta dell’esistere nello scontro con la violenza di ciò che lo frustra.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento