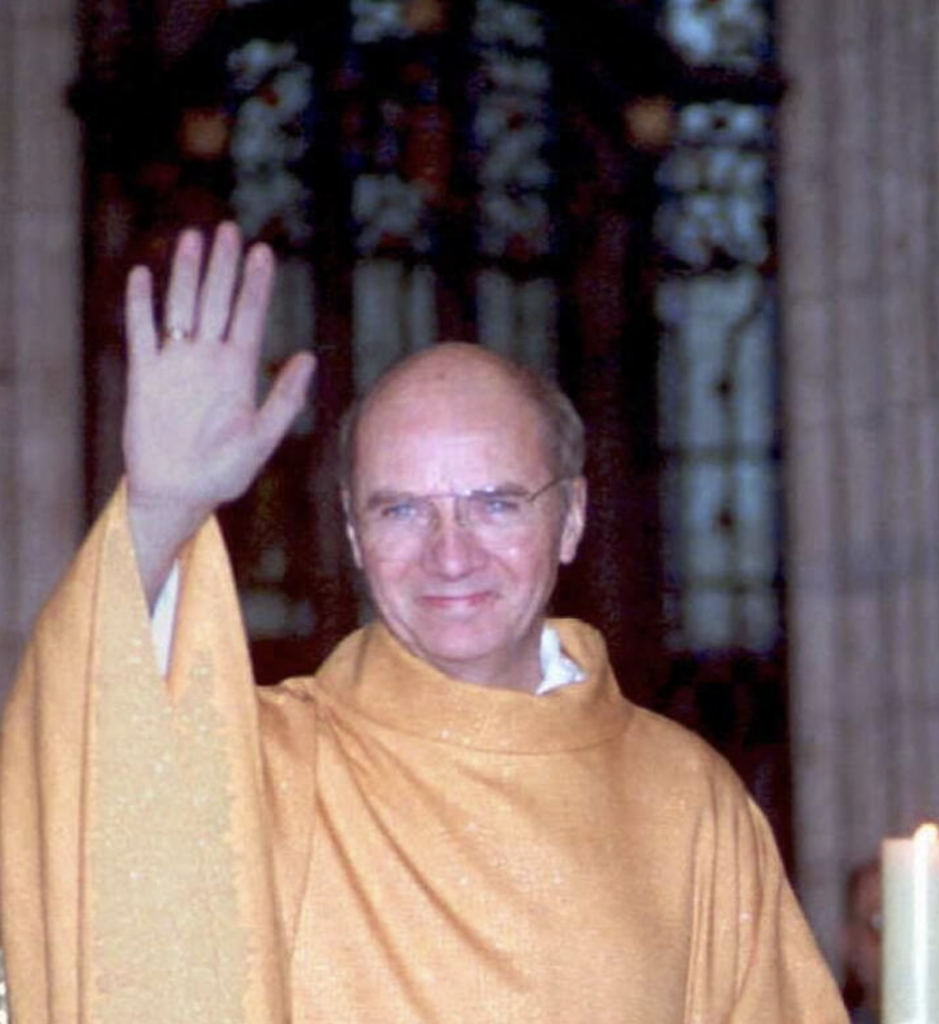Prosperi, la religiosità italiana da San Carlo al Concilio
Scriveva Adriano Prosperi nella premessa al primo dei tre volumi dal titolo generale Eresie e devozioni. La religione italiana in Età moderna (Edizioni di Storia e Letteratura, 1990) che tra i saggi raccolti in nessuna delle pagine il lettore avrebbe trovato il sostantivo ‘religione’ in simbiosi con l’aggettivo ‘italiana’ e aggiungeva: «Se da questa o quella vicenda emerga il profilo di una religione specificamente italiana, lo giudicherà il lettore, non dimenticandosi però che tutte queste ricerche riguardano una fase storica di conflitti religiosi che nacquero proprio dai contrasti e dai dubbi su quale dovesse essere la religione della popolazione della penisola». Più che esorcizzare un accoppiamento, che però occhieggiava dal titolo, era una prudente avvertenza.
Prosperi, emerito di Storia moderna alla Normale di Pisa, è autore di una quantità enorme di pubblicazioni rubricabili con l’etichetta di storia della religiosità (con fulcro cinquecentesco) ed è stato direttore, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, di un esteso Dizionario storico dell’Inquisizione che spazia in un quadrante europeo e oltre. Ha criticato duramente la dilagante applicazione del concetto di «identità» sostenendo che tra storia e identità sussiste una radicale opposizione: «storia è cambiamento, identità è immobile permanenza». Le pratiche devozionali e le sensibilità che le alimentano partecipano di un universo mentale e antropologico di modalità che non hanno confini definiti, anche se non mancano disposizioni rituali e espressioni verbali nelle quali eredità e sentimenti si contaminano, insieme a disciplinanti direttive finalizzate a imporre rigidità che riflettono le scaturigini di un rapporto con l’Assoluto caratterizzato da elementi propri di aree – o chiese – localizzate e riconoscibili. La storiografia non approda mai a punti fermi, integrazioni sono sempre all’ordine del giorno.
Così la trilogia predisposta per Quodlibet non è apparsa tale e quale a quella di oltre trent’anni fa, ma è stata modificata nel montaggio, arricchita e solo parzialmente ha riproposto taluni contributi già editi. In questo recente Paure e devozioni (pp. 560, € 32,00), comprensivo di venticinque testi, vengono ripresi temi e offerte ricerche che allargano l’orizzonte e s’intonano al clima dei nostri travagliati giorni come già in Eresie (2021) e in Inquisizioni (’23). Paura è innesto immesso non per caso: condivide la convinzione di Lucrezio nel far risalire alla paura l’insorgere della religione: «quid mirum si se temnunt mortalia saecla / atque potestates magnas mirasque relinquunt / in rebus viris divum, quae cuncta gubernent?», («qual meraviglia se le stirpi mortali spregiano se stesse e lasciano il mondo all’immaginario grande potere / e alle mirabili forze degli dèi, che governino tutte le cose?», De rerum natura, V, 1239 s., trad. L. Canali). Ma gli atti devozionali che dalla paura sono nati vanno letti tenendo presente la complessità che comunicano, poiché abbracciano una grande varietà di usanze: «Chiamiamo devozione – precisa Prosperi – le infinite pratiche inventate nei secoli dalla società preindustriale per esorcizzare il male che incombe sulle vite umane, popolando col rimorso e con la paura lo spazio che separava il cielo dalla terra, i vivi dai morti».
Se nel cristianesimo europeo l’invocazione di un Dio accessibile e misericordioso fu fissato nel Pater noster, un’altra tradizione si manifestò in una parola di origine pagana: pietas, lemma ambivalente che designava sia il rivolgersi a Dio per chiederne, appunto, pietà, sia l’atteggiamento umano generosamente protettivo dei propri cari, dei parenti, del prossimo. Ed è su questa accezione di pietà che Prosperi si sofferma particolarmente, convocando lo scrittore e studioso don Giuseppe De Luca (1898-1962), sacerdote quanto mai atipico e sfuggente, desideroso di dare al clero una formazione archivistico-filologica alta e di concepire la Chiesa quale «popolo di Dio», formula esaltata dal papato di Giovanni XXIII nel clima effervescente e innovatore del Concilio.
Luisa Mangoni dedicò alle imprese promosse da don Giuseppe un analitico saggio: In partibus infidelium (Einaudi 1989). Erudizione e studio avrebbero dovuto testimoniare «una umanità che non è umanesimo né umanitarismo, ma riconoscimento, sul volto di ciascun uomo, del Padre comune a tutti» (1943). L’umile «prete romano», come gli piaceva esser chiamato, era pervaso da un’ansia ecumenica che produsse un cenacolo frequentato da intellettuali e politici dalle ideologie più distanti e riuscì operativamente a dar vita all’«Archivio italiano per la Storia della pietà» (dal 1951) e alle fondamenta delle Edizioni di Storia e Letteratura.
Dal punto di vista storiografico la sua linea, salutata con soddisfazione da storici autorevoli quali Delio Cantimori, si sarebbe tradotta in un impulso per documentare e capire come la pietà vivesse anche «nel più meschino fedele, nel popolo più trito, nelle plebi più rustiche». Era urgente abbandonare la priorità assegnata a dinastie, pontefici, filosofie, dispute teologiche e dottrinarie. Doveva acquistar rilievo un paesaggio di casi e di condizioni vario e insondato, tenuto in ombra o affidato a un’erudizione agiografica fine a stessa. Composto da tessere di un mosaico da scoprire negli illuminanti dettagli, nelle aspre controversie tra gerarchie e fedeli, in impegnative esperienze avviate e in torbide manovre corruttive.
La sostituzione di eventi pagani si concretizza spesso in una serie di prescrizioni che li cambiano di segno e li assorbono in omaggi che escludono mascherate folleggianti. Carlo Borromeo condanna le rappresentazioni teatrali e una frenetica enfasi della fertilità. L’icona della Madonna ha un ruolo che prima era riservato solo ai santi cittadini, e al loro incontrastato dominio. La Madonna della Ghiara a Reggio Emilia, introdotta dai Servi di Maria nel 1313, conquisterà una devozione sempre più massiccia, unendo non solo nelle occasioni liturgiche città e campagna. E il culto mariano fu rafforzato pure dall’energica propensione cristocentrica propugnata dalla Riforma.
Sarebbe errato voler trarre univoche conclusioni d’insieme da ricerche che puntano ad approfondire realtà e tendenze circoscritte. Il volume non è separabile dalla trilogia e dalle narrazioni di ampio respiro che Prosperi ha infaticabilmente prodotto.
Tuttavia indugiare su trasformazioni o riluttanze interne al corpo disarticolato della Chiesa cattolica contribuisce a porre l’accento su fenomeni specifici, e quindi a comprendere successi e inanità, tenaci persistenze e ambigui exploit. Il fatto che si moltiplicassero donne visionarie e profetizzanti preoccupava non poco le gerarchie.
«L’amore delle mistiche – sottolinea l’autore – è come l’altra faccia dell’erotismo dei riti magici e stregoneschi». Quando circolavano lettere dettate da donne si avvertiva che erano state verificate e tradotte da membri del Sant’Uffizio. Era prassi invalsa in tutta Europa, e in Italia non si era dammeno, che i confortatori e i confessori dei condannati a morte fossero tenuti ad accogliere la sentenza senza protestare dal momento che a ispirare le decisioni politiche era Dio stesso. Dalla maggior parte dei casi sviscerati con cura si evince insomma un fosco affresco. La Riforma calata dall’alto s’intonò sporadicamente alla solidale pietas che si auspicava incarnasse.
Allorché gli eserciti della Grande Révolution scavalcarono le Alpi e divenne concreta la prospettiva della gramsciana «rivoluzione passiva» rilevata da Prosperi (2022), divenne evidente il dissidio, favorito dall’attuazione con varia intensità degli indirizzi ecclesiali post-tridentini, tra città e campagne e si fece facilmente percepibile la difficoltà di costituire una davvero unificante «fede nazionale».
Rispetto alla tavola del sistema europeo l’Italia era frantumata in diverse soggettività statuali, tenute fragilmente insieme dall’egemonia pontificia. Il neoguelfismo non era affatto un sogno astratto.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento