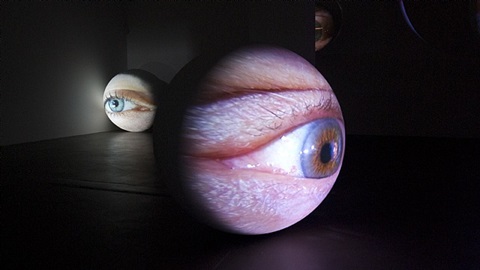Milan Kundera, sotto il segno delle infinite verità relative
Critici scrittori La letteratura è il fattore identitario per eccellenza di ogni lingua e paese, veicolo della nostra visione del mondo che si spera continuata e aggiornata: Adelphi ristampa «L’arte del romanzo»
 Jirí Kolar, «Senza titolo», dalla serie «Baudelaire»
Jirí Kolar, «Senza titolo», dalla serie «Baudelaire»Critici scrittori La letteratura è il fattore identitario per eccellenza di ogni lingua e paese, veicolo della nostra visione del mondo che si spera continuata e aggiornata: Adelphi ristampa «L’arte del romanzo»
Allo scrittore-critico si concede, d’abitudine, il privilegio di fare uso, nel suo lavoro saggistico, della medesima libertà di idee che contraddistingue la parte creativa della sua opera. Rispetto a lui, il critico che fa il suo lavoro, ha il dovere di un rigoroso dominio del pensiero. Il critico-scrittore invece – fenomeno assai più raro di quanto non si creda – pone la serietà dell’analisi al di sopra della propria libertà creativa e offre al critico un’immagine più leggera di sé stesso; ma non meno rigorosa. Milan Kundera è stato, molto probabilmente, il più grande critico-scrittore della seconda metà del XX secolo, e lo è stato perché ha sempre affrontato la questione della letteratura come una profonda necessità della cultura moderna.
La sua opera non si è limitata a tradurre in parole una visione del mondo, per quanto geniale, ma ha affrontato direttamente o indirettamente l’interrogativo intorno al senso della scrittura per la vita: la vita degli individui e la vita della stessa cultura europea. Fin dai primi romanzi di Kundera, questo filo sotterraneo collega i destini dei singoli personaggi a quelli del mondo che li circonda, e viene esplicitamente a galla nei saggi che compongono quel capolavoro assoluto che è L’arte del romanzo, opportunamente ristampato da Adelphi (traduzione di Ena Marchi, pp. 168, euro 12,00) a pochi mesi dalla scomparsa dello scrittore.
Essenziale = esistenziale
All’incirca un anno e mezzo fa, lo stesso editore aveva pubblicato anche le due conferenze riunite sotto il titolo Un occidente prigioniero, e a leggere ora, uno dopo l’altro, questi due piccoli volumi, se ne ricava un’immagine limpida della straordinaria ambizione critica e poetica di Kundera. La sua visione di fondo assume che l’arte – e il romanzo in quanto espressione eminente della letteratura d’arte (concetto a cui Kundera ha dedicato molte riflessioni) – è il tramite mediante cui una cultura, rinunciando a ogni pretesa di verità universale, consegue, un passo dopo l’altro, la sua identità. La quale, a sua volta, corrisponde alla visione del mondo che ognuno di noi vorrebbe vedere continuata, migliorata e aggiornata da coloro che abbiano motivo di condividerla.
Per questa concezione radicalmente illuministica della letteratura d’arte poco importa che a godere dei frutti del romanzo sia un singolo individuo, una nazione o un intero continente. Quando nel 1967 scrive la prima delle due conferenze di Un occidente prigioniero, destinata a venire letta davanti all’Unione degli scrittori cechi, Kundera ha già ben chiara questa funzione identificante della letteratura e la vede come il fattore che unifica la tradizione nazionale, salvandola dal proprio destino di oblio. Erano gli anni di incubazione della Primavera praghese e quel discorso – rivolto contro il ruolo dissolutore della dominazione sovietica – esprime ribellione nei confronti delle energie distruttive di un potere, che pretende l’annullamento di ogni istanza individuale e creativa.
Quando però nel 1983 Kundera è ormai in Francia, quella stessa visione si rivolge contro un altro potere dissolutore: quello dell’industria culturale che sfrutta le apparenze dell’arte per produrre una omologazione dell’insensibilità acritica, dell’intrattenimento come vacuo orizzonte vitale di tutto l’Occidente. A questa pericolosa deriva si oppongono la letteratura e il romanzo come contenitori unificanti di tutte le espressioni artistiche in cui prende forma il pensiero dell’essenziale. E essenziale coincide per Kundera con esistenziale, vale a dire la considerazione relativa al posto occupato dall’uomo nel campo di forze contrapposte che costituisce il suo mondo. Ma l’esistenza, come si legge nel primo, formidabile saggio dell’Arte del romanzo, è rappresentabile solo per approssimazioni continue, attraverso la considerazione minuziosa – e da prospettive diverse – di singoli fatti in cui si riproduce una dimensione significativa della condizione umana.
Perché ciò sia possibile, il romanzo si oppone programmaticamente all’imperio di qualunque verità religiosa, morale o scientifica e privilegia l’infinito dominio delle verità relative: è questo il segno del suo atteggiamento raziocinante e disincantato, che è poi anche il segno della sua modernità. La conseguenza è di dar forma, nel corso del suo sviluppo, a una specie di storia di sé stesso, dei suoi esperimenti successivi e sempre incompiuti: una storia molteplice, che si riapre ogni qualvolta il romanzo intraprende un nuovo corso con il solo fine di restare fedele al proprio principio di incompletezza, al dovere morale dell’approssimazione e della parzialità, rinunciando in questo modo anche alla verità della Storia e alla sua aspirazione totalizzante.
In fondo, non c’è altro orizzonte indispensabile al romanzo se non quello della vita individuale, ovvero quello delle sue infinite possibilità. Tuttavia, perché il romanzo possa continuare a vivere deve anch’esso conservare la memoria delle sue storie e – per restare fedele alla sua vocazione alla ricerca – conservare la sua pulsione sperimentale, evitare di ripercorrere i suoi passi.
Nella prima parte dell’intervista concessa a Christian Salmon, che occupa buona parte dell’Arte del romanzo, Kundera – che è, in ogni suo libro, uno psicologo degno del miglior Tolstoj – spiazza il suo interlocutore negando alla psicologia un ruolo di primo piano nei suoi romanzi. La narrativa puramente psicologica è ormai nelle disponibilità dell’industria culturale e, dunque, non offre se non un intrattenimento di conforto. La psicologia, invece, è solo un correlato inevitabile del tentativo – quello sì fondamentale – di rendere conto di una parola o di un concetto al quale sembra legarsi una dimensione rilevante dell’esistenza. Ed è su questo piano che Kundera si dimostra davvero ultimo prosecutore e vero antagonista della narrativa della prima metà del XX secolo. Se questa ha condotto una battaglia continua contro i limiti della parola-concetto, ha negato la sua capacità significante, ha sondato tutti i domini dell’epifania e ha cercato di marginalizzarla come strumento di indagine della vita, Kundera le restituisce la sua dignità allusiva, per colmare la cui insufficienza è necessario scavare dentro ai suoi molteplici usi, alle sue inappropriatezze, alla sua capacità di sfiorare la verità.
La parola è anzi un’alleata indispensabile per ogni narrativa della disillusione. È proprio il fatto di poter arrivare sempre e solo a una quasi verità, a una quasi verosimiglianza, a una quasi evidenza a renderla congeniale alla scrittura dubitante, che si avventura nella sfera inesauribile delle possibilità e non ammette la tirannia di una verità indiscussa. La parola è la porta d’accesso di ogni indagine.
La vertigine indagata
Parlando dell’Insostenibile leggerezza dell’essere, Kundera dice a Salmon che la sua aspirazione era stata, scrivendolo, quella di indagare la «vertigine» come «ottenebrante, irresistibile desiderio di cadere» come «ebbrezza della debolezza» e come desiderio di «tornare indietro», «in basso», «da dove si è venuti». La parola dischiude una varietà inesauribile di possibilità del senso, che sono altrettante possibilità dell’esistenza, ed è compiendo questa ricerca che il romanzo conserva la memoria della sua età avventurosa, e offre al contempo ai suoi lettori il diritto a un’identità sperimentale. È l’identità approssimativa e precaria di chi si concepisce alla continua ricerca di sé e del mondo, ma è un’identità indispensabile se permette di sfuggire alla presa della totalità, in nome di una libera accettazione di sé come esperimento eternamente incompiuto.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento