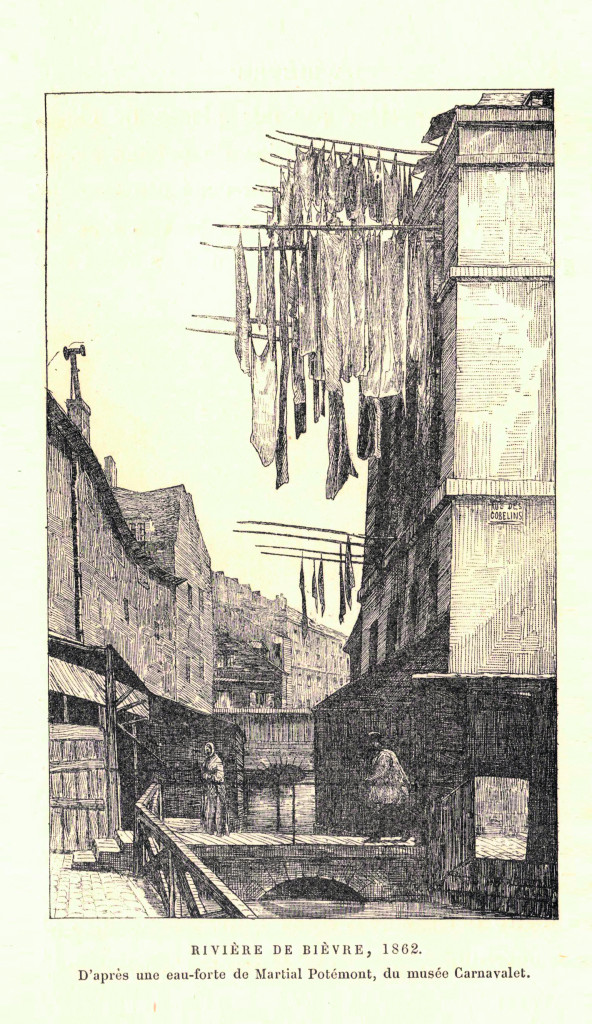Macron: meno oneri ai padroni, meno soldi alle pensioni
In Francia la protesta sociale contro la controriforma delle pensioni di Macron ha raggiunto un vertice di partecipazione, intensità e consenso nell’opinione pubblica; le otto maggiori sigle sindacali sul punto sono unite come una falange macedone, l’alleanza di sinistra radicale NUPES di J-L. Mélenchon e il partito di Marine Le Pen hanno dato battaglia parlamentare; sondaggi indicano che il 74% della popolazione sarebbe favorevole ad una mozione di sfiducia che facesse crollare il governo del primo ministro Borne.
Com’è noto i punti più importanti della riforma sono l’aumento dell’età del pensionamento (da 52 a 64 anni) e del periodo di contributi per assicurare la sostenibilità del sistema: sfila l’eterno ritornello delle risorse scarse e sulla necessità di tirare la cinghia.
Ma qualcuno l’ha tirata un po’ meno.
Il sistema previdenziale francese si appoggia in massima parte sui contributi dei lavoratori che vanno a finanziare gli assegni dei pensionati; parte di essi era a carico dei datori di lavoro, ma sono state in gran parte eliminate. Il ragionamento era che in presenza di una massiccia disoccupazione uno strumento per ridurla sarebbe stato diminuire il cosiddetto «costo del lavoro», cioè l’insieme delle spese dell’imprenditore, e così facendo rendere le imprese francesi più competitive. Così che dal 1993 per gli impieghi di bassa qualificazione si è avuta una decurtazione di tali contributi.
Gli effetti non paiono essere stati quelli sperati: secondo una nota del Consiglio di Analisi Economia (CAE), un organismo consultivo di alto livello del Primo Ministro, l’effetto è stato altalenante ed incerto; in taluni casi (la stima è stata fatta per ciascuna ondata di decontribuzioni in momenti diversi) pare che anziché creare più lavoro il sistema si sia tradotto in maggiori profitti!
Quel che è certo è che ciò ha posto maggiori oneri sulle spalle dello Stato, riportando il discorso sulla insostenibilità. Ma è una cosa reale? “Dopo più di venti anni di riforme che si sono susseguite, il problema delle pensioni non è più di natura finanziaria. La questione oggi non è più di alzare l’età pensionabile o aumentare gli anni di contribuzione”. Così si esprimeva nientemeno che il programma elettorale di Macron del 2017. Ed ha ragione (il Macron di allora, non quello del 2023): secondo il Conseil d’Orientation des Retraites, un ente statale che ogni anno valuta l’entità degli oneri futuri per la previdenza pubblica fra il 2021-27 la spesa resterà stabile; fra il 2028-32 aumenterà di 0,7-1,6% del pil; fra il 2032-70 sarà stabile e tendenzialmente in calo nonostante l’invecchiamento della popolazione per via delle già austere riforme fatte negli anni scorsi (Rapporto COR settembre 2022).
Se anche vi fosse una necessità oggettiva di spostare l’equilibro entrate-uscite, vi sarebbe una gamma di possibilità: fare redistribuzione con politiche fiscali, o alzare i prelievi per i lavoratori più ricchi (consideriamo che vanno inclusi gli stipendi dirigenziali, computati nella “quota lavoro”). O fare politiche di sviluppo: è ovvio che una parità di bilancio con le uscite destinate ai pensionati va commisurato col numero dei lavoratori attivi e coi loro salari.
Ma tale necessità non c’è: non solo non c’è alcun consenso sulla esistenza di fantomatiche soglie del debito pubblico oltre le quali arriva l’apocalisse; ma un alto debito pubblico non è necessariamente un problema: può diventarlo in determinate circostanze. E anche in tal caso vi è una pluralità di metodi per tenerlo sotto controllo. Un rapporto del Servizio Studi del Congresso Usa ne elenca cinque: austerità, inflazione, crescita, ristrutturazione (default), repressione finanziaria. Chissà perché l’ultimo non è mai stato nominato.
Comunque la si giri non esiste alcun argomento logico per ridurre i diritti dei lavoratori francesi senza includere i profitti del padronato e i patrimoni disponibili alla tassazione ma facendo pagare tutto al lavoro dipendente. Visto il contrasto furibondo alla riforma la maggior parte dei francesi l’ha capito. Chissà se accadrà mai in Italia.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento