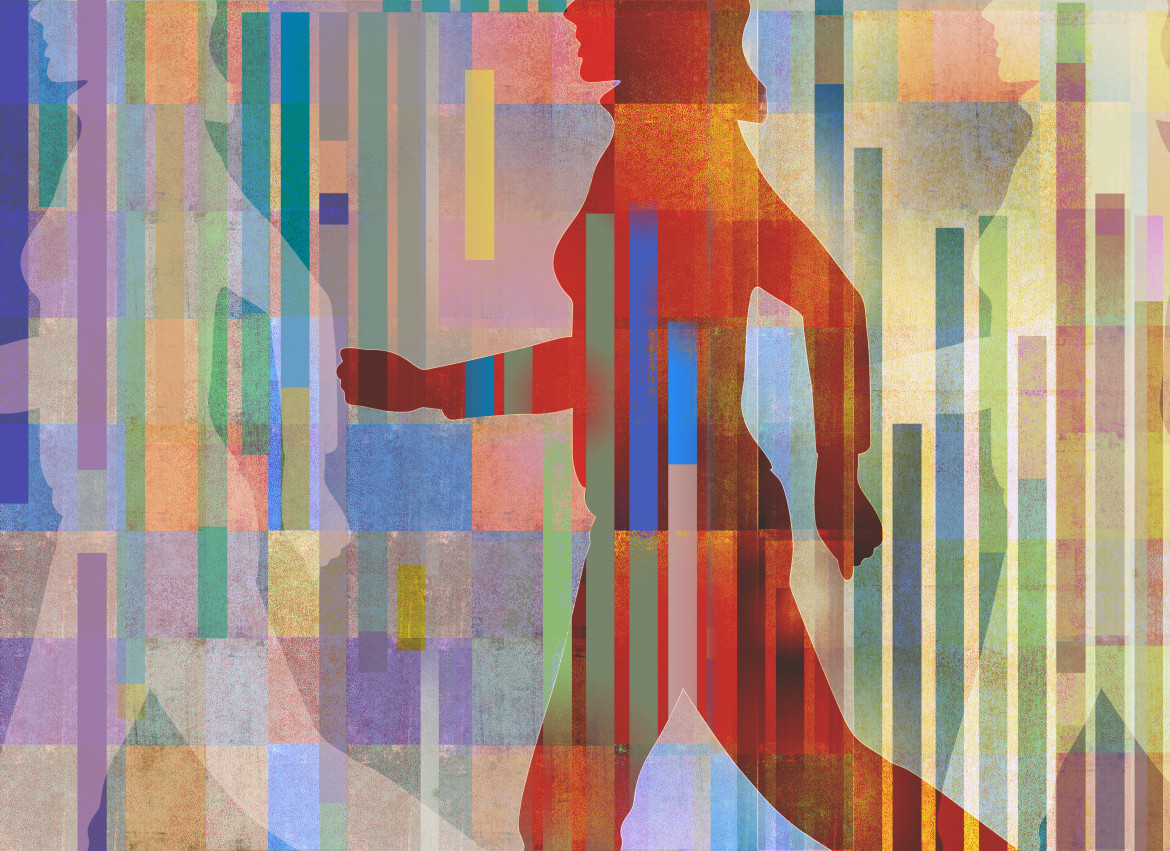Luoghi non più comuni: «riformismo»
Dizionario di fine anno Oggi il tema di fondo per le sinistre in Europa e negli Stati Uniti non è più quello sintetizzato un secolo fa dall’alternativa tra riforma e rivoluzione. La lotta contro le diseguaglianze, risultato d’un trentennio di egemonia neoliberale, e per la difesa di una democrazia e di un Welfare a rischio di estinzione, anima tanto i socialisti più avanzati quanto i liberali ugualitari

Dizionario di fine anno Oggi il tema di fondo per le sinistre in Europa e negli Stati Uniti non è più quello sintetizzato un secolo fa dall’alternativa tra riforma e rivoluzione. La lotta contro le diseguaglianze, risultato d’un trentennio di egemonia neoliberale, e per la difesa di una democrazia e di un Welfare a rischio di estinzione, anima tanto i socialisti più avanzati quanto i liberali ugualitari
Nietzsche ha scritto che ciò che ha una storia non si può definire, ma questa affermazione andrebbe presa come un ammonimento, non un divieto. La storia delle idee non può fare a meno di formule che espongono il significato dei termini che sono centrali per ricostruire una tradizione di pensiero. Tuttavia, tali formule funzionano più come punti di riferimento provvisori per orientarci nell’esplorazione di un’area dai confini inevitabilmente vaghi, che come «definizioni» nel senso proprio del termine, quello tipico di discipline come la logica o la geometria.
Nel caso della politica, bisogna sempre tener presente che le formule che adoperiamo per ricostruire il pensiero di un autore, o il dibattito all’interno di un movimento o di un partito, sono esposte al pericolo di essere dilatate o distorte nell’uso fino al punto di perdere del tutto la capacità di orientare il pensiero e l’azione. Questo fenomeno può essere esemplificato considerando il modo in cui viene impiegato oggi il termine «riformismo» in Italia. La parola ha assunto infatti un senso così vago che sarebbe meglio smettere di usarla (almeno come termine da impiegare nel dibattito politico).
PER ILLUSTRARE QUESTA TESI, credo sia opportuno partire da una lettera di Keir Hardie, il fondatore del partito Laburista, a Friedrich Engels, scritta poco prima della conferenza della seconda Internazionale, che si tenne a Parigi nel 1889. Nella missiva, il sindacalista e attivista politico scozzese informava il proprio corrispondente che, a suo giudizio, il movimento operaio britannico non era particolarmente propenso a intraprendere un’azione rivoluzionaria. Gli abitanti del Regno Unito, secondo Hardie, «sono persone solide, molto pratiche, e poco inclini a inseguire bolle di sapone». Una valutazione ribadita nel corso della conferenza – provocando il disappunto sia di William Morris sia dei marxisti – quando fece presente ai suoi interlocutori che nessuno in Inghilterra credeva in metodi che non fossero pacifici per ottenere il miglioramento delle condizioni della classe operaia.
Commentando queste affermazioni di Hardie, lo storico del comunismo Archie Brown ha affermato che per il leader politico britannico, come per altri partecipanti al congresso, il socialismo era una miscela messa insieme con ingredienti di varia provenienza. Per Brown, «prima del successo della rivoluzione bolscevica nel 1917, le linee di divisione tra socialisti e comunisti erano meno nette di quanto sarebbero diventate in seguito».
SE L’ANALISI DELLA POLITICA in termini di lotta di classe era un elemento comune a queste diverse tendenze, essa veniva interpretata in modo significativamente diverso. All’esperienza britannica si richiamava Eduard Bernstein, che nel Regno Unito aveva soggiornato a lungo, dialogando sia con Engels sia con gli esponenti del socialismo Fabiano. Della frequentazione con il movimento Laburista si avverte l’influenza nelle sue osservazioni sul metodo impiegato dai socialisti britannici: «nessun socialista che sia in grado di pensare sogna oggi in Inghilterra un’imminente vittoria del socialismo attraverso una rivoluzione violenta – nessuno sogna una veloce conquista del Parlamento da parte di un proletariato rivoluzionario. Al contrario, essi si basano sempre più sul lavoro svolto nelle municipalità e negli altri organi di auto-governo».
Dalla reazione alle tesi «revisioniste» proposte da Bernstein nel 1909, nasce la contrapposizione tra «riformisti» e «massimalisti» che anima le discussioni vivacissime cui prenderanno parte nel continente gli esponenti più importanti dei partiti socialdemocratici e socialisti, e che si cristallizzeranno, dopo la rivoluzione bolscevica, nella frattura tra comunisti e socialisti. A questo dibattito, e al modo di concettualizzarlo, il socialismo britannico rimane sostanzialmente estraneo. La scelta per il metodo parlamentare, e il conseguente rifiuto della rivoluzione, non viene più messa in discussione dai socialisti d’oltre Manica. Questo non vuol dire che non ci sia una dialettica interna al partito tra posizioni più o meno radicali, ma essa riguarda la scelta delle politiche, non il metodo di lotta, che rimane saldamente ancorato alla prospettiva costituzionale.
Nel secondo dopoguerra una scelta analoga viene fatta dai partiti socialisti e socialdemocratici del continente, che prendono progressivamente le distanze dal marxismo, e si adattano, in alcuni casi con grande successo, a una prospettiva nella quale il fine ultimo non è la realizzazione di una società socialista, ma il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Nelle circostanze favorevoli dei «trenta gloriosi» questo consente una riduzione senza precedenti delle diseguaglianze nelle società europee (un processo analogo è in corso anche negli Stati Uniti, ma promosso dal liberalismo sociale della sinistra democratica piuttosto che dai socialisti).
L’ITALIA, SOTTO QUESTO PROFILO, ha un percorso anomalo. Dovuto al peso elettorale consistente sia della Democrazia Cristiana, sia del Partito Comunista. Se da un lato, anche nel nostro Paese, i «trenta gloriosi» sono un periodo di importanti riforme promosse dalle componenti progressiste della Dc, con la partecipazione decisiva dei socialisti e di altri partiti minori, dall’altro la divisione tra riformisti e massimalisti non trova composizione. Anzi, il «riformismo» diventa il motivo dominante della lunga lotta per l’egemonia sulla sinistra tra Psi e Pci.
Questo non vuol dire che il partito comunista sia in Italia una forza «rivoluzionaria» nel tradizionale senso marxista. Ma la ricerca di un’identità che tenga insieme l’accettazione del metodo democratico e la prospettiva del superamento del capitalismo rimane un ostacolo alla composizione della scissione di Livorno. Il confronto diventa, alla fine degli anni Settanta, particolarmente acceso, in seguito all’elezione a segretario del Psi di Bettino Craxi: un esponente della corrente «autonomista» del partito, che fa del «riformismo» il tratto caratterizzante di una nuova identità dei socialisti. Pragmatica, aggressiva nella comunicazione, e orientata verso una competizione molto accentuata con il Pci.
LA CADUTA DEL MURO di Berlino, la dissoluzione dell’Unione Sovietica, e la crisi del sistema dei partiti provocata dalle inchieste della magistratura, modifica profondamente l’offerta politica a sinistra. La scomparsa dei socialisti come forza politica con un ruolo significativo, e la nascita del nuovo partito che sorge dalle ceneri del Pci, sembrano segnare, con la fine del «duello a sinistra», anche la vittoria tardiva e finale del riformismo nel nostro paese. Ciò avviene, tuttavia, in un contesto internazionale che sta cambiando profondamente, nel quale le tendenze neoliberali, emerse alla fine degli anni Settanta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, stanno diventando egemoni, e ben presto finiranno per mutare profondamente la natura e l’orientamento dei partiti socialisti.
Oggi il tema di fondo per le sinistre in Europa e negli Stati Uniti non è più quello sintetizzato un secolo fa dall’alternativa tra riforma e rivoluzione. La lotta contro le diseguaglianze che sono il risultato di un trentennio di egemonia neoliberale, e per la difesa di una democrazia e di un Welfare State che sono seriamente a rischio di estinzione, è ciò che anima le esperienze più avanzate della sinistra, tra i socialisti come tra i liberali egualitari. Se siamo tutti riformisti, è ovvio che la parola «riformista» ha perso la sua utilità come termine di distinzione.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento