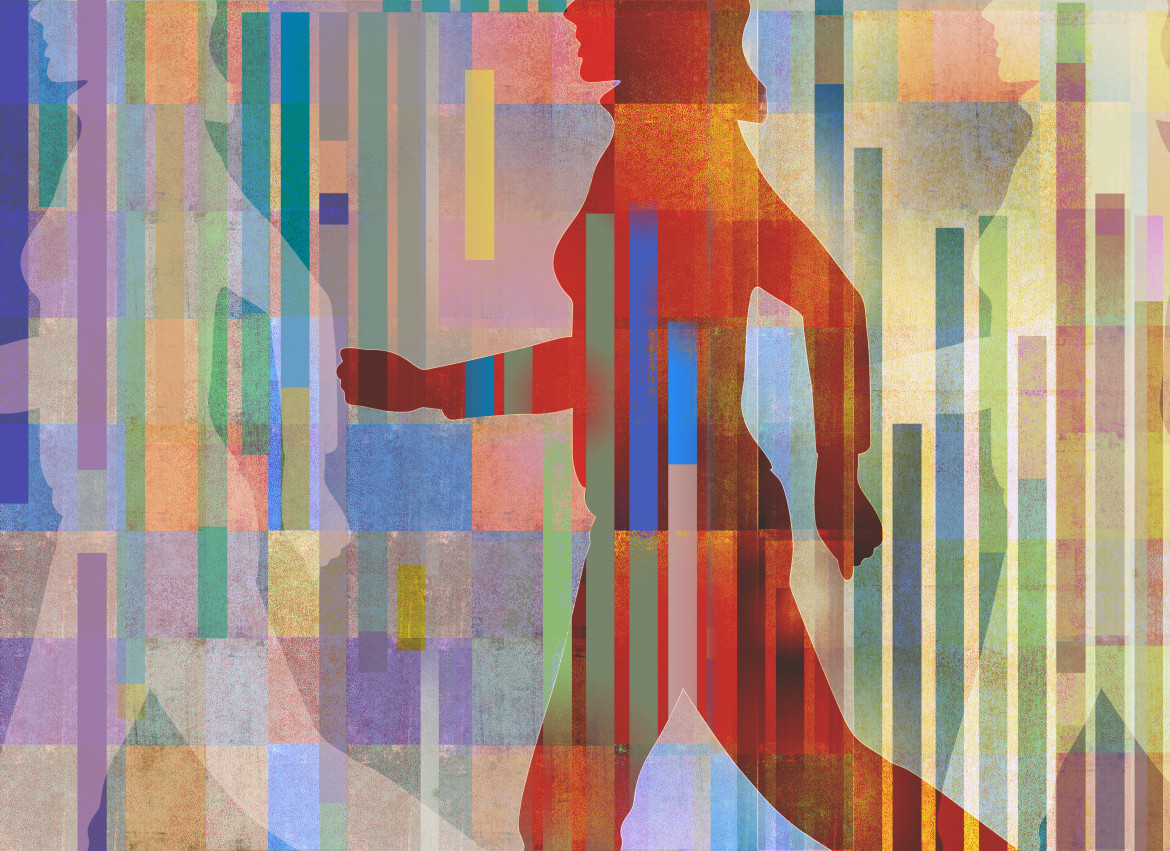Luoghi non più comuni: «rifondazione»
Dizionario di fine anno A ogni sconfitta della sinistra si ripresenta ciclicamente la richiesta di tornare alle fondamenta, di rimettere sui binari qualcosa che ha deviato. Si invocano unificazioni dei frammenti divisi come se questo fosse il vero problema e non invece l’inconsistenza di una prassi comune a quasi ogni spezzone di quella storia

Dizionario di fine anno A ogni sconfitta della sinistra si ripresenta ciclicamente la richiesta di tornare alle fondamenta, di rimettere sui binari qualcosa che ha deviato. Si invocano unificazioni dei frammenti divisi come se questo fosse il vero problema e non invece l’inconsistenza di una prassi comune a quasi ogni spezzone di quella storia
Ad ogni disfatta elettorale, a ogni baldanzoso avanzamento delle destre, a ogni sforbiciata del welfare, a ogni crescita delle diseguaglianze un mesto coro invoca la rifondazione di una sinistra in declino. A ben vedere l’idea di rifondazione è sempre incastonata in un qualche mito delle origini, una condizione di purezza nella quale i principi si conservano incorrotti e i fini si stagliano con chiarezza generalmente condivisa. Laddove regna l’«autenticità» (trappola insidiosa del repertorio heideggeriano) che imporrebbe di affrontare con identità forte, senza scuse né pretesti, senza fughe, opportunismi e distrazioni il cuore dei problemi, l’autentico esserci nel mondo. Ma di un mito, appunto, si tratta. L’età dell’oro non appartiene alla storia degli umani anche se, certamente, allieta la loro fantasia.
Dunque la volontà di tornare alle fondamenta, iuxta propria principia, intende rimettere sui binari qualcosa che ha deragliato, deviato dal suo corso, tradito le sue premesse, che si è disperso e colpevolmente sparpagliato. Già, perché la rifondazione della sinistra viene invocata, in primo luogo, come sua riunificazione, come superamento delle divisioni e dei conflitti che ne hanno segnato la storia e indebolito la forza, come se questo fosse il vero problema e non l’inconsistenza di una prassi, comune a quasi ogni spezzone di quella storia, che si è irrimediabilmente allontanata dalla vita. Va da sé che questa unità non è mai esistita, semmai il suo feroce contrario. Anche se in qualche occasione il fronte comune ha potuto raggiungere una certa ampiezza, l’unità si è sovente riproposta, in tutta la sua fragilità, più come il minimo comune denominatore di una prudente politica rappresentativa che come l’esito di un vincente percorso di lotte.
LA NOSTALGIA e l’affezione per condizioni ormai tramontate, è fortunatamente un vicolo cieco. Tanto un impossibile ritorno indietro quanto la lettura del presente con le lenti del passato, sfociano nella più completa indigenza politica. Il ruolo dello stato e quello del lavoro salariato, sui quali la sinistra ha tradizionalmente fondato il suo agire e il suo pensiero, sono stati travolti irrimediabilmente dalla metamorfosi dei modi di produzione e dai nuovi assetti del capitalismo globale, seppure continuino a sopravvivere in forme sempre più odiose e infondate. Cosicché la rifondazione del protagonismo statale è diventata un affare da rosso bruni o da bruni tout court, come quelli che oggi brandiscono, con successo prevalentemente ideologico, il vessillo dello stato nazione contro la «piovra cosmopolita».
Quanto al lavoro salariato, quello standardizzato e di massa che sottendeva l’organizzazione operaia e l’omogeneità dei suoi orientamenti politici, difficile negarne, almeno nei paesi più sviluppati, il forte ridimensionamento e la perdita di centralità. Le nuove, molteplici e sfuggenti figure messe al lavoro e che tendono a occupare il centro della scena si sottraggono insofferenti tanto all’identificazione con il proprio ruolo produttivo quanto alle forme della rappresentanza. I dati dell’astensione elettorale parlano chiaro. Inutile dire che una restaurazione dell’antica omogeneità attraverso la nenia della «piena e buona occupazione» è fuori dall’orizzonte del possibile. Laddove la produzione si intreccia indissolubilmente con la vita sociale stessa, l’occupazione è sempre piena, pienamente sfruttata e spietatamente ricattabile. Su queste basi, dunque, nulla è dato rifondare. Ma soprattutto non è affatto auspicabile tentarlo.
LA SINISTRA, attenendoci per semplicità all’Europa, ha storicamente percorso due strade: quella del socialismo e quella della socialdemocrazia. La prima ha dato il peggio di sé nell’Europa orientale sviluppandovi alcuni dei suoi più sinistri presupposti. Lì il protagonismo statale ha assunto i tratti più torvi. Rifarsi a quella storia, comunque la si voglia giudicare, è per i sani di mente cosa impensabile. La seconda si trova oggi in una profonda condizione di crisi, soprattutto là dove ha lungamente governato e disegnato in qualche modo i contorni di un originale modello sociale. In quei paesi scandinavi, Svezia, Norvegia, Finlandia e altre democrazie nordiche come i Paesi bassi che oggi sono tornati nelle mani di destre più o meno impresentabili. Come e perché questo sia accaduto è un quesito al quale non è facile rispondere.
Paura e insicurezza si sono insinuati anche in contesti con elevati livelli di vita, minando un ordine omogeneo garantito dal paternalismo dello stato che trasformazioni sociali e forme di vita sempre più articolate ed eterogenee avevano già in buona misura logorato. L’esperienza del benessere si è rovesciata in una cultura del privilegio. D’altro canto la socialdemocrazia, e in primo luogo la più storicamente solida, quella tedesca, è scesa a compromessi sempre più incresciosi con i poteri neoliberali, non tanto in ragione di cedimenti dettati dai rapporti di forza quanto per averne interiorizzato i principi, le regole e gli obiettivi, ritraducendoli poi nel linguaggio dei diritti, delle opportunità e del progresso. Anche in questo caso come e che cosa si dovrebbe rifondare di una storia giunta al crepuscolo?
Quale rapporto tra passato e presente si cela dietro la volontà di rifondare? Un puro e semplice ritorno al già noto o la pretesa di restituire fondamenta a una storia che le ha smarrite, ma che una volta sostenuta da nuovi puntelli sarebbe pronta a rimettersi in marcia lungo il percorso malauguratamente interrotto? In entrambi i casi non è contemplato quello scarto che servirebbe per seguire mappe e tracciati che ci sono ancora poco noti. E che le destre nazionaliste, pur con tutta l’ammuffita e stucchevole retorica che si portano dietro stanno tentando a modo loro di percorrere e occupare. Non si tratta, beninteso, di cancellare il passato né di demonizzarlo, ma di mettere a fuoco una soluzione di continuità, di tagliare i rami secchi dell’albero genealogico, di eleggere a propri contemporanei gli uni e prendere commiato da molti altri. Per dirla con una ruvida formula, pensare al comunismo non come il futuribile compimento del programma socialista, ma come la sua più promettente negazione.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento