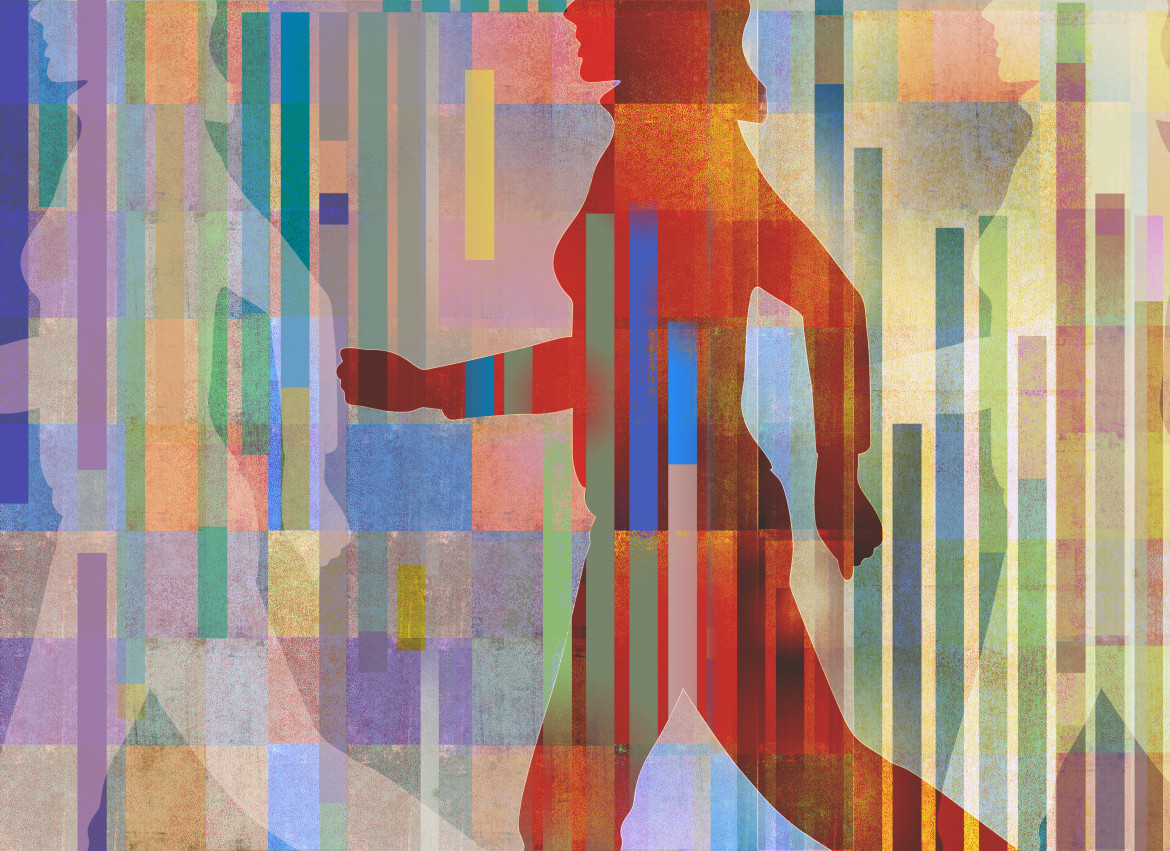Luoghi non più comuni: «liberalismo»
L’Oxford Languages Dictionary definisce il liberalismo come segue: «Atteggiamento etico-politico dell’età moderna e contemporanea, tendente a concretarsi in dottrine e prassi opposte all’assolutismo, fondate essenzialmente sul principio che il potere dello Stato debba essere limitato per favorire la libertà d’azione del singolo individuo».
Stando a questa definizione, uno Stato liberale deve auto-limitare il proprio governo, per consentire e garantire l’esercizio delle libertà individuali, fra cui la libertà di parola, di opinione, di culto, di associazione, di impresa e di consumo: si tratta dell’«arte di governare il meno possibile», secondo la celebre definizione che ne ha dato Michel Foucault nel corso Nascita della biopolitica, tenuto nel 1979. Qual è il criterio che regola tale arte? Seguendo ancora Foucault, di criteri se ne possono ricavare due, considerando il cosiddetto «liberalismo classico»: i diritti naturali (giusnaturalismo) fino al XVII secolo e l’economia politica (utilitarismo) fino al XVIII secolo.
Quest’ultima prescriveva il non intervento dello Stato nel mercato, affinché spontaneamente si potessero incontrare domanda e offerta, rendendo possibile il libero scambio, che solo poteva trasformare il perseguimento degli interessi individuali di ciascuno nell’interesse generale, producendo in questo modo una società libera e in crescita. Così intesa, l’istituzione decentralizzata del mercato doveva produrre un ordine non solo economico, ma sociale, capace di autoregolarsi.
CHE L’INTERESSE NON FOSSE generale, bensì parziale, e che l’autoregolazione fosse in realtà pianificata, lo ha magistralmente dimostrato Karl Marx, svelando come quella narrazione fosse condotta dal solo punto di vista della classe dominante: quella borghese. La discesa negli atelier della produzione conduceva infatti alla scoperta che la dinamica del libero scambio si basava sullo sfruttamento dei lavoratori. All’interesse generale liberale, in realtà unilaterale, Marx contrapponeva perciò l’emancipazione umana della classe universale.
Nel periodo fra le due guerre mondiali in Europa, il marxismo informava il conflitto sociale e, al contempo, guadagnava terreno nei Parlamenti la prospettiva socialdemocratica che, rifiutando tanto l’interesse generale del liberalismo classico – perché ne riconosceva l’effettiva parzialità – quanto l’emancipazione universale marxista – individuando nella rivoluzione l’anticamera di un nuovo dispotismo – si faceva promotrice dell’«interesse collettivo»: il mercato doveva essere esplicitamente regolato, affinché non producesse eccessiva disuguaglianza e concentrazione di ricchezza, realizzando una società effettivamente più libera, perché più egualitaria.
LA SOCIALDEMOCRAZIA era animata da varie correnti, fra cui quella «sociale» o «di sinistra» del liberalismo, che agiva in base al principio secondo cui bisognava produrre statalmente le condizioni materiali per consentire agli individui di esercitare le proprie libertà, da quelle politiche a quelle economiche. Pari opportunità, libertà politica, salario minimo e persino politiche pubbliche orientate dall’ideale regolativo dell’eliminazione delle cause della povertà erano fra le proposte della socialdemocrazia. Sono valori che rientravano in quello che Benedetto Croce chiamava «liberalismo», in contrapposizione al «liberismo», meramente economico. Per Luigi Einaudi, invece, la distinzione era inadeguata, perché non poteva esserci vera libertà senza piena libertà economica.
In quegli anni, Einaudi era vicino all’ala «destra» o «conservatrice» del liberalismo del tempo, che nel 1937 prese il nome di «neoliberalismo», secondo cui lo statalismo socialdemocratico era irrazionale, perché sarebbe degenerato in guerra civile. Consentiva, infatti, alla società di riprodurre i propri conflitti nello Stato democratico, spingendolo fino al dissolvimento – con ciò, favorendo l’assunzione di potere da parte delle forze socio-politiche-economiche in quel momento in vantaggio, che avrebbero messo a tacere gli avversari con ogni mezzo possibile.
Per i neoliberali i rischi della socialdemocrazia erano, perciò, guerra civile o dispotismo; dispersione del potere o sua concentrazione neo-assolutistica. In altri termini, ciò che dagli anni Settanta avrebbero chiamato ingovernabilità o totalitarismo. Per i neoliberali non c’era alternativa: neoliberalismo o barbarie. In nome di ciò i Parlamenti non dovevano poter deliberare sulla materia economica e, la sovranità popolare, andava su tale materia esautorata. A proposito, Walter Eucken ha inventato il concetto di «costituzione economica»; James M. Buchanan, molti anni dopo, quello di «costituzionalismo fiscale»; Friederich A. von Hayek, quello di «demarchia».
DA FILOSOFIA DELLA LIMITAZIONE dei poteri dello Stato, il liberalismo, nella sua declinazione neoliberale, si è perciò presto rovesciato in filosofia del potere economico protetto dallo Stato, posto da questo a suo fondamento: il mercato doveva venire, con ciò, messo al riparo dal conflitto democratico e pertanto incoronato. Quell’«arte di governare il meno possibile» si è perciò trasformata nell’arte di governo senza limiti del capitale, implicante l’abbandono tanto dello Stato sociale che della democrazia.
Secondo il marxismo, in realtà, il liberalismo sin dalle sue origini non era altro che la filosofia del governo del capitale. Tuttavia, è difficile negare che questa filosofia abbia assunto storicamente formazioni molto differenti fra loro: ora fondata sui diritti naturali, ora sul laissez-faire; ora sul compromesso mirante alla giustizia sociale e alla rappresentazione democratica; e, infine, basata sulla dichiarazione per cui la «giustizia sociale è un miraggio», come sostennne Friedrich August Hayek, per il quale la disuguaglianza è ineliminabile, la democrazia è accettabile se, e solo se, esautorata dalla deliberazione sulla materia economica; e la critica valida se finalizzata alla conferma di un ordine così definito, essendo i codici etico-morali validi se conformi. Codici che, infatti, sono funzionali a giustificare l’adesione degli individui alla società di mercato, la quale a questo scopo può valorizzare tanto la diversità dei «capitali umani» di ciascuno, quanto promuovere l’uniformità culturale del popolo e della famiglia. Risorse valoriali stabili, queste, che contro-bilanciano l’insicurezza sociale, e la precarietà prodotta dall’espansione del mercato.
Contemporanei di Karl Polanyi, i neoliberali riconoscevano che il capitalismo sfalda i legami societari innescando nella società contro-spinte difensive di tipo identitario. Sapevano che esse devono esser governate, così che l’identitarismo potesse simulare teatralmente la contro-spinta anti-mercato: in realtà re-integrando gli individui al suo interno.
È AMPIAMENTE CONDIVISA l’idea secondo cui dagli anni Ottanta il mondo è entrato in una fase storica «neoliberale». Se negli anni Trenta, i neoliberali potevano essere considerati la «destra» del liberalismo (crocianamente il «liberismo») dagli anni Ottanta sembra non esserci al neoliberalismo alcuna alternativa: destra e sinistra parlamentari sono ora varianti neoliberali, per le quali le crisi (economiche, ecologiche, epidemiologiche, e così via) sono un dispositivo di governo, non l’occasione che porta al superamento del sistema esistente e all’adozione di uno nuovo.
Cos’è allora, il liberalismo, oggi? Una filosofia che giustifica lo sfruttamento differenziale dei molti da parte dei pochi, innestato sulle stigmatizzazioni di razza, di genere e di classe; la neutralizzazione del disaccordo; lo svuotamento delle democrazie esistenti; il dominio indiscusso di classi capitalistiche trans-nazionali in guerra fra loro, imperniate su governi nazionali neo-autoritari; un sistema che, parafrasando Dostoevskij, lungi dal rendere gli esseri umani liberi di fare ciò che vogliono, fa loro tutto ciò che esso vuole.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento