
Liberazione e identità sulla linea del colore
Quando, nel 1961, James Baldwin pubblica la raccolta di saggi Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son, ha appena concluso la sua prima stagione europea, il debutto di quell’auto-esilio che ne avrebbe accompagnato l’intera esistenza, inaugurato nel 1948, quando a soli 24 anni aveva ottenuto una borsa di studio per Parigi anche grazie all’amicizia con lo scrittore Richard Wright. Resterà negli Stati Uniti per circa un decennio, facendo ritorno stabilmente in Francia dopo gli assassinii di Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King: tragedie che segneranno per molti versi la fine della stagione della lotta per i diritti civili, annunciando un orizzonte d’ora in poi dominato solo dalla violenza. Ma nel 1961, Baldwin non è ancora il testimone per molti versi involontario della rabbia nera, l’autore di La prossima volta il fuoco, uscito nel 1963, dove scrive: «Questo Paese innocente ti ha confinato in un ghetto, e in questo ghetto è stabilito che tu marcisca. Sarò più preciso, perché qui è il nocciolo della questione, è qui l’origine della polemica mia col mio Paese: tu sei nato dove sei nato e hai di fronte a te il futuro che hai perché sei nero, per questa e nessun’altra ragione».
IL LIBRO USCITO due anni prima – e che ora Fandango, che sta riproponendo l’intera opera dell’intellettuale afroamericano nel centenario della sua nascita, presenta nella traduzione rivista e corretta di Giancarlo Cella e Vittorio Di Giuro (pp. 256, euro 19) con il titolo di Nessuno sa il mio nome -, riflette piuttosto la misura della realtà circostante che Baldwin ha scelto di prendere proprio perché lontano dal suo Paese natale, nei viaggi che lo hanno visto attraversare l’Europa per soggiornare soprattutto in Francia, Svizzera, ma anche in Turchia. È nella distanza che è riuscito a stabilire con la società americana che trova la chiave per osservarla in modo più netto, consentendosi una determinazione forse inedita: «In America – scrive nell’introduzione -, tra me e la mia coscienza s’era sempre frapposto il colore dalla mia pelle; in Europa questa barriera era caduta».
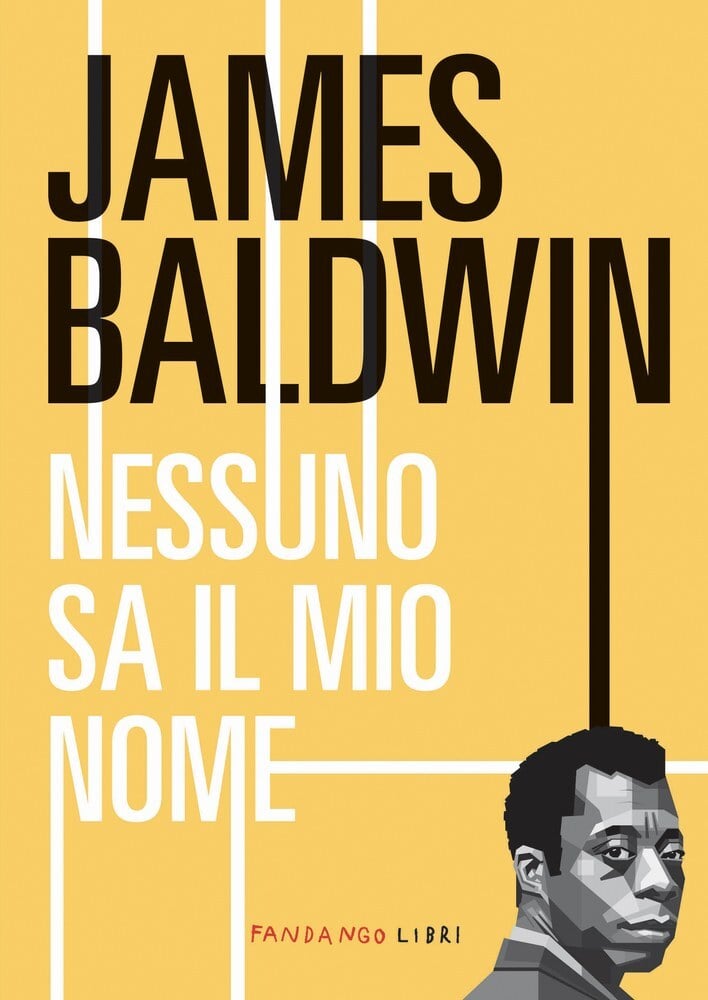
Proprio l’approccio proposto da Baldwin con questo testo può tornare utile per affrontare, attraverso alcuni recenti volumi pubblicati nel nostro Paese, il senso e il lascito di qualche traiettoria esistenziale che ha segnato in maniera indelebile l’immaginario e la memoria afroamericana. L’occasione è la ricorrenza del Black history month che si svolge per tutto il mese di febbraio, dal 1976 negli Stati Uniti e più recentemente in Gran Bretagna e Canada, per ricordare il ruolo e il peso della presenza dei neri in quelle culture nazionali. Circostanza che ogni anno produce un buon numero di polemiche, in primo luogo per l’idea che queste «radici» si possano separare, quasi non costituissero una parte fondante delle rispettive identità, culturali e non solo, ma che rappresenta pur sempre una buona occasione per riaffermare proprio il ruolo decisivo di talune figure cresciute in seno a comunità lungamente oggetto di razzismo, discriminazioni, marginalizzazione.
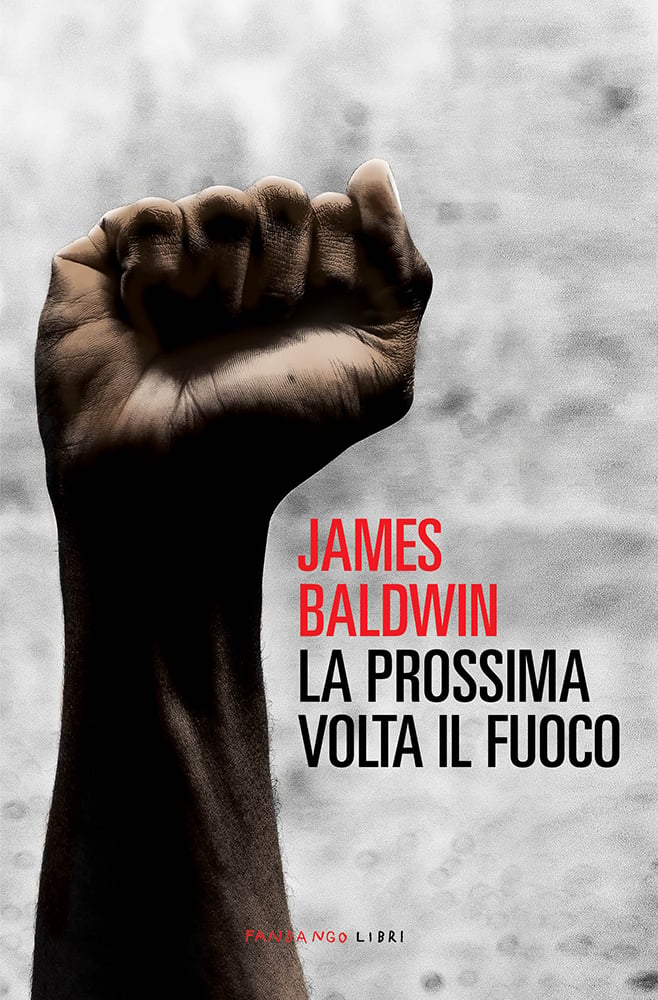
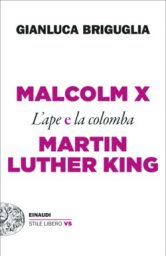
GLI ANNI SONO GLI STESSI nei quali Tommie Smith e John Carlos salirono sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del 1968 e crearono quella che può essere considerata «l’immagine più duratura e avvincente nella storia dello sport e delle proteste». È in questi termini che il redattore sportivo di The Nation Dave Zirin ricorda il gesto degli atleti afroamericani ai Giochi olimpici di Città del Messico, il pugno chiuso guantato di nero al momento della premiazione, nelle prime pagine del libro in cui John Carlos racconta la propria storia: Autobiografia di una leggenda. I pugni olimpici che hanno cambiato il mondo (DeriveApprodi, pp. 174, euro 18, a cura di Dave Zirin, prefazione di Nicola Roggero).

Il percorso di John Wesley Carlos, l’ex velocista statunitense, oggi 79enne, indica quanto e cosa ci sono stati prima e dopo quell’immagine emblematica che ha denunciato agli occhi del mondo il peso della discriminazione razziale negli Stati Uniti. Nato ad Harlem nel 1945, Carlos sfidò il razzismo fin da giovanissimo dopo aver ricevuto in virtù delle sue qualità atletiche una borsa di studio per l’East Texas State University e trovandosi così a sfidare le rigide norme segregazioniste del Sud. Nel 1967 avrebbe partecipato alla fondazione dell’Olympic Project for Human Rights che in un primo momento intendeva boicottare i Giochi del 1968 proprio per denunciare il razzismo imperante nel Paese. Dopo quelle Olimpiadi, avrebbe giocato a football con i Philadelphia Eagles, a calcio in Canada, prima di diventare allenatore in una scuola superiore della California. Il suo gesto a Città del Messico aveva fatto seguito alle mobilitazioni per i diritti civili, alle rivolte urbane di Newark e Detroit e di un altro centinaio di città americane, all’assassinio del reverendo King avvenuto solo sei mesi prima. Oggi, nelle pagine della sua autobiografia, scrive: «Sento ancora il fuoco. Non mi piaceva il modo in cui il mondo era, e credo che ci sia bisogno di cambiare il modo in cui il mondo è».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




