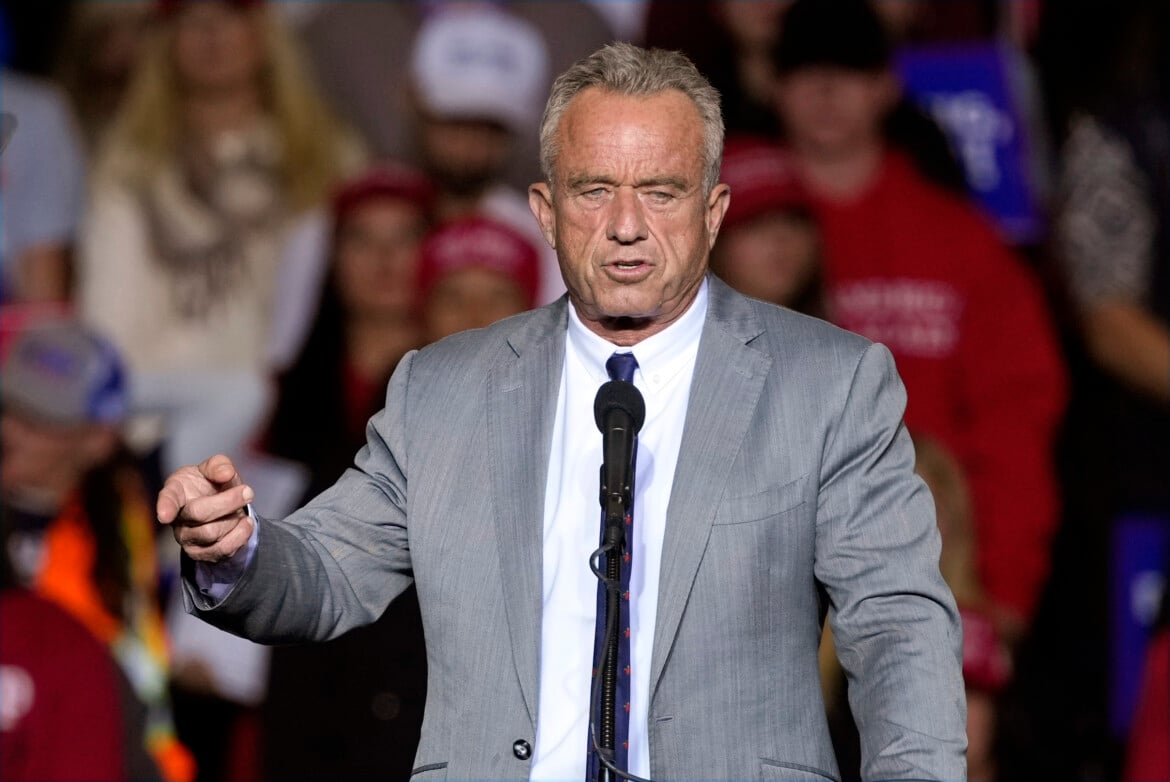L’anti-memoriale di M. John Harrison in forma di frammenti galleggianti
Scrittori statunitensi «Vorrei essere qui», da Mercurio
 Cathy Wilkes, «Senza titolo»
Cathy Wilkes, «Senza titolo»Scrittori statunitensi «Vorrei essere qui», da Mercurio
Esiste nei testi narrativi più estesi (romanzi, memoriali, biografie, autobiografie) una tensione tra una sorta di forza centripeta e una centrifuga: esempio perfetto di questa tensione l’Ulisse di Joyce, che a seconda dei punti di vista può essere letto come un romanzo destrutturato, cioè una narrazione tenuta insieme da una serie di richiami interni, ricorrenze simboliche, miti presi in prestito; oppure, ed è un’interpretazione altrettanto legittima, come una serie di racconti intimamente interconnessi, una sorta di evoluzione e potenziamento di quel che lo scrittore irlandese aveva già fatto con Gente di Dublino.
Romanzi e biografie sono infatti il frutto della lotta tra materiali eterogenei, reali e/o inventati, e del disegno cui l’autore cerca di subordinarli, la forma che li deve ordinare.
Per quel che riguarda il romanzo, questa tensione deriva dal suo essere, fin dalle origini, un assemblaggio, come già insegnava Šklovskij, un montaggio di racconti unificati dall’avere l o stesso protagonista; nel caso delle biografie, dalla complessità della miriade di episodi di una vita umana che si contraddicono e in cui il biografo si sforza di trovare il disegno che tutto salda – e lo stesso discorso vale, ovviamente, quando s’incarica di raccontare una vita la stessa persona che l’ha vissuta. Sono considerazioni che vengono in mente leggendo Vorrei essere qui (traduzione di Luca Fusari, Mercurio, pp. 223, € 20,00), libro decisamente spiazzante di M. John Harrison, essendo il suo sottotitolo Antimemorie.
La traiettoria letteraria dello scrittore britannico è, a tutti gli effetti, insolita avendo egli praticato diversi generi, dalla fantascienza al fantasy a una forma di realismo presente nel suo romanzo-memoriale Climbers (non tradotto), sempre in modo del tutto non convenzionale. La sua scrittura ibrida è stata fatta rientrare nell’ambito piuttosto sfuggente del weird (e si è anche usato l’altrettanto scivoloso termine «slipstream»).
Poiché il titolo originale è Wish I Was Here: An Anti-Memoir, sarebbe stato più corretto definirlo un «anti-memoriale» (non sfugga l’ironico accenno al titolo di un famosissimo album dei Pink Floyd): di fatto, Harrison ci offre una collezione di frammenti (altro – dunque – dalla promessa di una narrazione coerente) che ruotano in qualche modo attorno alla sua vita, e sembrano tentare il bilancio di un’esistenza, tra riflessioni sulla scrittura, ricordi d’infanzia, considerazioni sulla travolgente passione dello scrittore per l’arrampicata in falesia, meditazioni sulla geografia britannica, su luoghi della memoria, viaggi e incontri. Soprattutto, c’è una sistematica analisi della frammentarietà stessa, che non sorprende in un narratore abituato a riempire di appunti una lunga serie di taccuini.
Tra le sue considerazioni, una è particolarmente illuminante: «Mai privilegiare la fabula. Va bene l’intreccio, ma la fabula è come l’agricoltura chimica. Portare a conclusione è sbagliato. È tossico». In Vorrei essere qui Harrison lascia infatti i frammenti della sua vita galleggiare sulle pagine senza forzarli a una conclusione, senza riordinarli cronologicamente. Li lascia brillare della loro propria luce, anche nei momenti in cui, con tipica autoironia britannica, confessa di non capirli, di aver perso quel barlume di senso che allora l’aveva spinto ad annotarli.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento