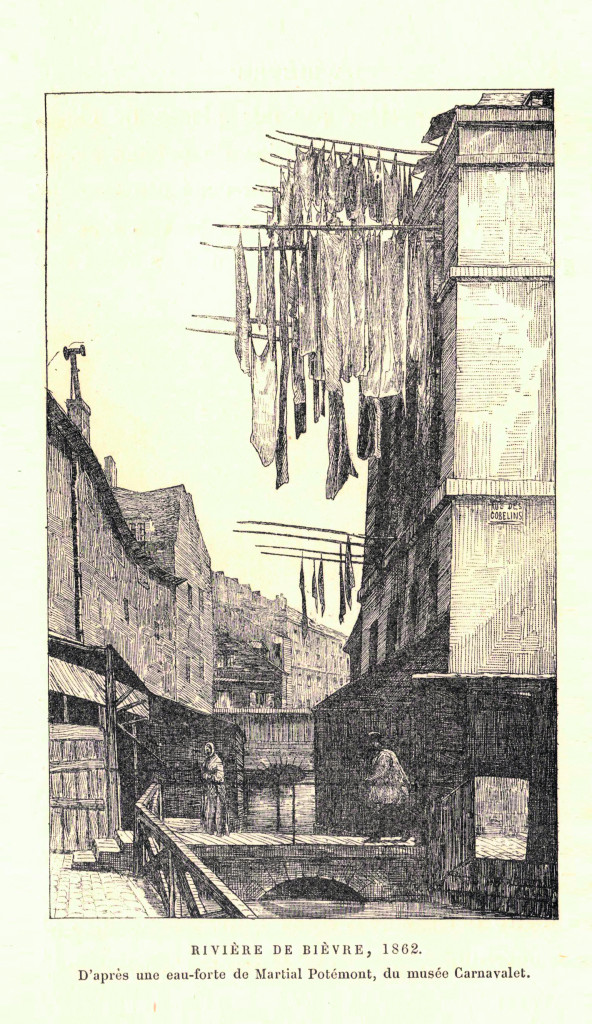Laforgue, esegesi stenografica sulle Fleurs du mal
Simbolismo francese Le notazioni «cifrate» su Baudelaire di Jules Laforgue (foglietti volanti con i versi trascritti) furono pubblicate nel 1891 da Fénéon: ora le ha tradotte Luigi Azzariti-Fumaroli per Aragno
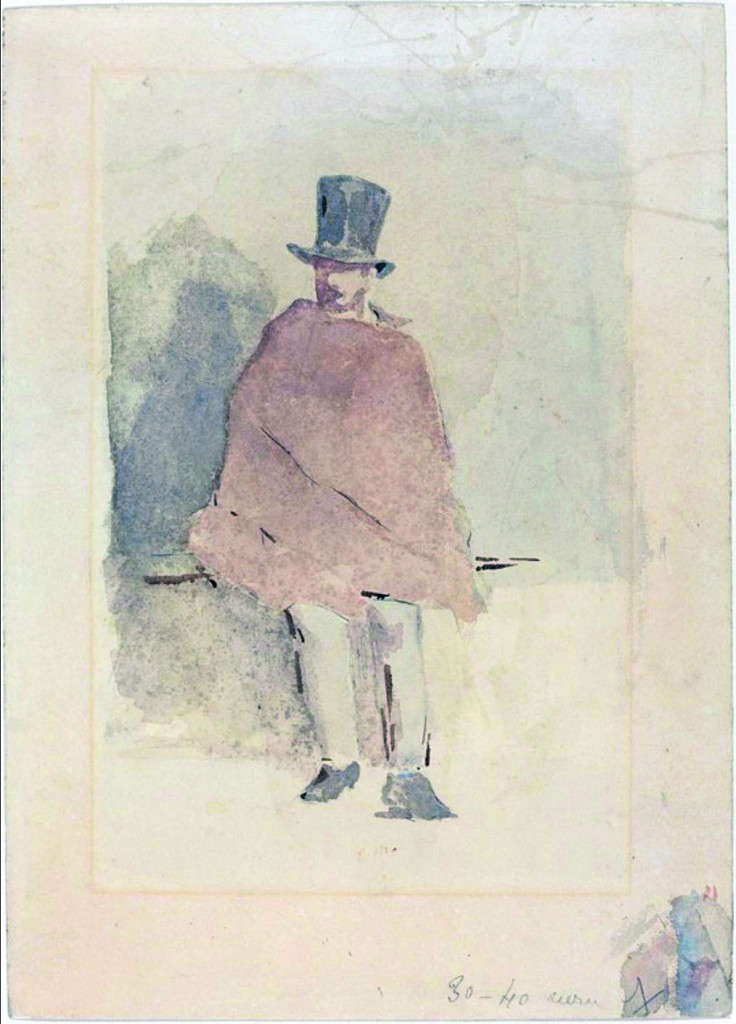 Édouard Manet, «The man in the tall hat », 1858-’59, Washington, National Gallery of Art
Édouard Manet, «The man in the tall hat », 1858-’59, Washington, National Gallery of ArtSimbolismo francese Le notazioni «cifrate» su Baudelaire di Jules Laforgue (foglietti volanti con i versi trascritti) furono pubblicate nel 1891 da Fénéon: ora le ha tradotte Luigi Azzariti-Fumaroli per Aragno
Consultando alcune vecchie edizioni di Jules Laforgue (1860-1887), tra cui l’antologia mondadoriana Poesie e prose curata da Ivos Margoni nel 1981, mi è capitato di rileggere La chanson du petit hypertrophique. Tratta dalla raccolta Le Sanglot de la terre, questa lirica si segnala per un linguaggio basso e gergale che tuttavia non rinuncia a una sua innata, sincopata musicalità: «C’est d’un’ maladie d’ cœur / Qu’est mort’, m’a dit l’ docteur, / Tir-lan-laire! / Ma pauv’ mère; / Et que j’irai là-bas, / Fair’ dodo z’avec elle. / J’entends mon cœur qui bat, / C’est maman qui m’appelle!». Il tema «del piccolo ipertrofico», pur affrontato con il sarcasmo che caratterizza tutta l’opera di Laforgue, sembra aderire a certi motivi che ritroveremo nell’impressionante sequenza fotografica Paralisi infantile: bambino che cammina su mani e piedi di Eadweard Muybridge, opportunamente rivisitata da Francis Bacon. Ma sono rintracciabili parecchie analogie con il rire jaune di Corbière, come nel distico «J’ suis jaune et triste, hélas! / Elle est ros’, gaie et belle!», ricavato dalla medesima chanson (ma si pensi anche alle due cantilene deliranti di Céline, traboccanti di termini in argot, cantate dallo stesso autore con accompagnamento di fisarmonica in una versione registrata su disco della Pacific del 1957, rintracciabile in rete). Non è un caso che Alfredo Giuliani avesse definito «poesia che abbaia e gracida» i componimenti che confluiranno negli Amours jaunes, usciti nel 1873, quando Laforgue aveva solo tredici anni, in un’edizione finanziata dallo stesso Corbière, attraente quanto un batrace e soprannominato dai concittadini an Ankou (in bretone lo spettro della morte).
Oltre alla succitata antologia mondadoriana esistono varie riduzioni nel nostro paese dell’opera poetica di Laforgue: dalle Poesie, curate da Luciana Frezza per Lerici nel 1965 (poi riprese in Un cervello a tre emisferi, Accademia 1972), alle Poesie curate da Enrico Guaraldo per la Bur nel 1986, fino agli Ultimi versi, tradotti da Francesca Del Moro per Marco Saya nel 2020, senza contare qualche rara versione delle Moralità leggendarie, compresa quella canonica allestita da Nelo Risi per Addenda nel 1972 (poi Guanda, ora Garzanti). Un insospettabile Ennio Flaiano si esercitò al riguardo traducendo Amleto, brano incipitario delle Moralités légendaires, per La Pietra di Paragone nel 1945. Le Poesie complete uscirono inoltre in lingua originale in due volumi per le Edizioni dell’Ateneo, con accurata introduzione di Sergio Solmi (1966).
Naturalmente il deus ex machina di simbolisti e decadenti non poteva che essere Baudelaire, già riconosciuto da Rimbaud nella celebre lettre du voyant, «il primo veggente, il Re dei poeti, un vero Dio». In una lettera all’amico Gustave Kahn del 28 gennaio 1885, Laforgue dichiara di voler «offrire un contributo al culto di Baudelaire (Charles il Grande)». Le sue riflessioni sull’autore delle Fleurs du mal, inedite in italiano, appaiono ora con il titolo Note su Baudelaire (Aragno, pp. XXIV-80, € 15,00), ben tradotte e curate da Luigi Azzariti-Fumaroli. In realtà si tratta di annotazioni scritte di getto, la cui immediatezza è percepibile anche a una lettura superficiale, anche se non mancano momenti dove la vena lirica di Laforgue si manifesta appieno: «La tempesta della sua giovinezza e i soli marini dei suoi ricordi hanno nelle brume dei lungosenna allentato le corde della viola bizantina incurabilmente lamentosa e afflitta».
Gli appunti di Laforgue, i cui testi originali non sono stati rintracciati, si cadenzano su foglietti volanti che vennero pubblicati nel 1891 da Félix Fénéon sul periodico «Entretiens politiques et littéraires», poi accolti nel terzo volume delle Œuvres complètes edito da L’âge d’homme di Losanna nel 2000. Sono considerazioni di taglio criptico, riportate attraverso uno stile telegrafico che, spesso, si limita a isolare e trascrivere alcuni versi delle Fleurs in funzione di uno studio più articolato che Laforgue non riuscì a realizzare, ma che si può congetturare affrontando la seconda parte, più risolta e lineare. Non mancano tuttavia osservazioni significative: «I fiori del male non sono né neri, né verdastri, né plumbei, ma lilla».
Il lilla era uno dei colori d’elezione di Laforgue, anche se tale supposta preferenza da parte di Baudelaire sembrerebbe derivare da un’errata interpretazione di un passo di Gautier, oltre a un’idiosincrasia cromatica di Des Esseintes descritta in À rebours di Huysmans. Roberto Calasso osserverà: «Le Note di Laforgue su Baudelaire sono allarmanti, come per una qualche interferenza parapsicologica. Non è più un critico, un lettore a parlare, ma una fisiologia che si associa ad un’altra». Laforgue si avvalse dell’edizione delle Fleurs pubblicata nel 1868 da Michel Lévy (la prima, di Poulet-Malassis e De Broise, risale al 1857), che aveva fatto rilegare con la fodera di un vecchio abito, quasi a rimarcare la profonda vicinanza con colui che concepiva il dandismo alla stregua di una vocazione monastica.
Se «la parola ammaliante di Baudelaire applicata alle cose equivoche» non poteva non conquistare Laforgue, intriso di una poetica che prefigura atmosfere crepuscolari (si vedano in particolare Les Complaintes, con annessi organetti di Barberia, domestiche defunte e domeniche invischiate in un’aura di indelebile melancolia), si deve altresì considerare il trasporto per la sprezzatura presente nell’autore delle Fleurs che tuttavia non rinuncerà mai a strutture metriche rigorose, operando piuttosto una corrosione interna tesa a minare le fondamenta di un impianto formale apparentemente perfetto mediante la scelta di temi e vocaboli in aperta contrapposizione con il genere adottato. La comune avversione per il sonetto, pur presente nelle Fleurs, andrebbe associata al «cant della poesia», laddove il termine cant, ripreso da uno dei saggi di Baudelaire su Poe, si rifà non a una forma anglicizzata del termine latino «cantus» ma al linguaggio cifrato di mendicanti e criminali.
In quest’ambito si dovrà considerare il ricorso al verso libero effettuato da Laforgue, già rilevato da esegeti d’eccezione come Eliot e Pound che definirà nei Saggi letterari il poeta delle Complaintes un «verbalista». D’altronde, nella sua articolata e dotta prefazione, il curatore avverte come la scrittura critica di Laforgue esuli dagli stigmi dell’ortodossia effondendosi «in parole vaghe, frasi in libertà, estrosità quasi glossolaliche». La mancanza di temi che caratterizza certe liriche di Baudelaire – «che fanno dire al borghese che ha appena finito di leggerle: “E allora?”» – è ripresa in una lettera che lo stesso Laforgue indirizza a M.me Mültzer in data 18 luglio 1882, specificando di preferire «una poesia che non dica niente, ma consista in frammenti sconnessi di fantasticherie».
Sarà proprio tale gratuità, ben simbolizzata dalla figura del Pierrot fumiste, alter ego del poeta travestito da saltimbanco, a rendere quanto mai moderna una poetica che non disdegna il ricorso a vocaboli tecnici. Si pensi a ciò che scrisse Starobinski: «Bevuta la delusione sino alla feccia Laforgue presta ai “bianchi chierichetti della luna” tutti i sarcasmi di una filosofia misogina». Risulterà proficuo riferirsi al confronto effettuato da Deleuze tra messinscene grottesche laforguiane e la phoné di Carmelo Bene, essendo in entrambi il testo riconducibile a una «variazione dell’intonazione vocalica, che si tenderebbe a mantenere alta per mezzo ora d’una caduta ora d’una risalita», come postilla il curatore. I richiami di Laforgue alla figura di Alessandro Magno o a opere composite come Séraphita ed Eureka costituiscono, pur nella loro frammentarietà, suggestioni atte a rivendicare l’autonomia sprezzante di Baudelaire: «Per il pubblico sono dannato – benissimo – il Pubblico qui non entrerà».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento