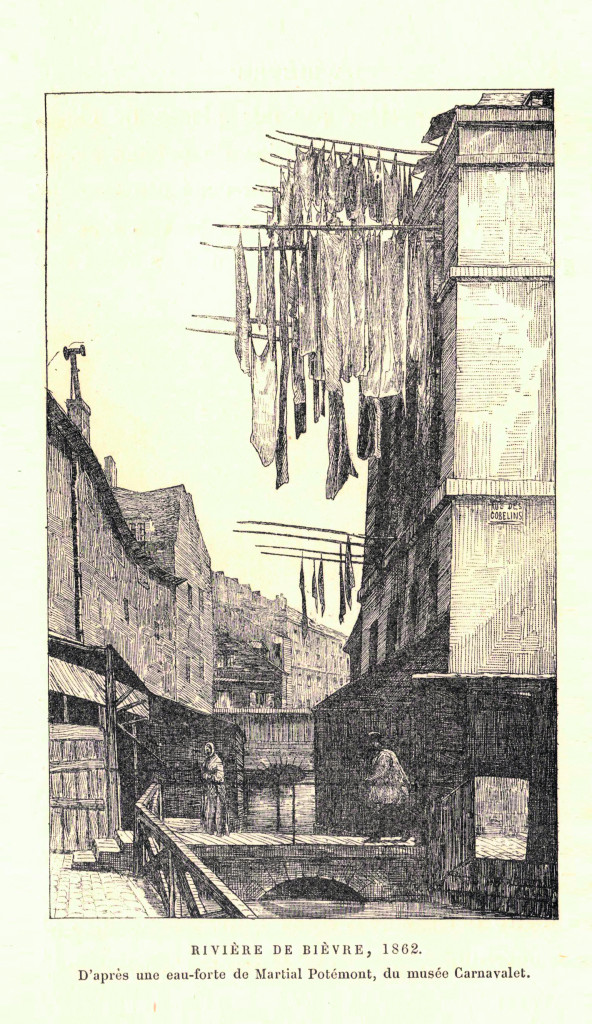La sfida di Blanchot alle pretese del senso
Scrittori francesi Più volte rielaborato, il primo libro del critico francese è un «récit» che induce esperienze di straniamento, persino dalla stoffa materica delle parole: «Thomas l’oscuro», dal Saggiatore
 Jean Dubuffet, «Ritratto del soldato Lucien Geominne», 1950
Jean Dubuffet, «Ritratto del soldato Lucien Geominne», 1950Scrittori francesi Più volte rielaborato, il primo libro del critico francese è un «récit» che induce esperienze di straniamento, persino dalla stoffa materica delle parole: «Thomas l’oscuro», dal Saggiatore
Su una delle copie fresche di stampa del suo primo libro, l’allora trentaquattrenne Maurice Blanchot scrive all’editore questa singolare dedica autografa: «per G. G., un libro destinato a escludere ogni lettore». Siamo nel settembre 1941, nella Francia occupata dall’esercito tedesco: l’editore è Gaston Gallimard, il volume in questione – un «romanzo», recita la copertina – è Thomas l’Obscur.
La dedica può dare un’idea dei motivi che hanno reso tardive le traduzioni del libro – in inglese nel 1973, in spagnolo nel 1982, in tedesco nel 2007, solo oggi in italiano – Thomas l’Oscuro (traduzione di F. Fogliotti, il Saggiatore, pp. 139, € 18,00) – malgrado nel corso del secondo Novecento una cerchia nutrita di lettori illustri – da Bataille a Levinas, da Char a Godard, da Michaux a Klossowski, fino a Foucault e Derrida – avessero manifestato il loro apprezzamento per l’anticipazione dei temi e del senso di tutta l’opera successiva di Blanchot, sia letteraria che filosofica. Sottolineavano, quei lettori, il carattere sperimentale di una scrittura che tentava, come si espresse Starobinski, di «far intravedere una nuova universalità», più originaria di quella del pensiero, posta alla sua radice.
Tra dubbi, rinunce, riprese, Blanchot aveva lavorato al libro per otto anni, sin dal 1932, producendone una mezza dozzina di diverse redazioni, e arrivando a una consapevolezza dell’esito finale di cui fa fede la dedica all’editore. Le primissime reazioni dei critici testimoniano il disorientamento suscitato da quella che si presentava come la figurazione del destino solitario di un corpo nel suo incontro con la morte. Thomas l’Oscuro racconta l’attraversamento, da parte del protagonista, di strane esperienze di depersonalizzazione e di metamorfosi (di volta in volta in un’ameba mostruosa, in un ragno, in un angelo nero, in un muro, in una voce illocalizzabile, e in altro ancora), che preludono alla riconfigurazione della consistenza identitaria del personaggio, il quale arriva a dire di non essere «reale se non sotto il nome della morte», anzi di «non avere che la morte come indice antropometrico».
Testo di elevatissima densità e pressoché privo di una voce narrante, Thomas l’Oscuro ha una forma così atipica da sottrarsi a ogni tentativo di esaurirlo in una analisi univoca. Del tutto spoglio di elementi psicologici, questo romanzo antirealista – che non può tuttavia essere qualificato come «fantastico» né come «metafisico» – rinuncia a stipulare qualsivoglia «patto di lettura», sottoponendo la lingua a una estrema tensione, e immergendo il lettore in un’atmosfera minacciosa, pesante, popolata di forze terribili e sconosciute. La critica del tempo si esercitò in formule – «un libro fatto di notte», «un canto in un mondo senz’aria», l’esposizione di una «macchia cieca» della mente umana, l’indizio delle «future contraddizioni del pensiero» – che denunciavano turbamento e sconcerto (e talvolta risentimento), in qualche caso accompagnandole a rinvii a Lautrémont e a Rilke.
Negli anni a seguire Blanchot pubblicò altri due romanzi – Aminadab e L’Altissimo – una raccolta di studi letterari, Passi falsi, e due racconti tra i suoi più intensi e vertiginosi – «La sentenza di morte» e «La follia del giorno» – e a quasi un decennio di distanza dal suo esordio, nel 1950, consegnò all’editore una nuova versione di Thomas l’Oscuro, quella definitiva, rifiutandosi poi a più riprese di ripubblicare la versione originaria (condivisibile, dunque, la scelta dell’editore italiano di tradurre questa edizione del 1950). Nella nuova versione, che non portava più in copertina la menzione «romanzo», Blanchot eliminò circa tre quarti del testo, lasciando pressoché intatto il resto, che rivelava, per sottrazione, l’essenziale della versione del 1941. Ancora più spoglio di elementi aneddotici e di riferimenti a precisi luoghi e tempi, il testo che oggi leggiamo è un récit che lancia un’autentica sfida al lettore, invitandolo a imboccare una via che porti fuori dall’immaginario letterario.
Contestando la logica della rappresentazione, e esplorando i limiti delle tecniche narrative, Thomas l’Oscuro cerca, come altre opere della letteratura di avanguardia del XX secolo, di trasmettere un’esperienza di estraneità; ma è forse il primo testo che invece di limitarsi a evocare questa estraneità come l’esperienza di un personaggio nel mondo della finzione, provi a inscriverla nel rapporto che il lettore stabilisce con la stoffa materica delle parole e con la loro successione. I consueti modi di organizzare il nostro pensiero, e le nostre stesse convenzioni linguistiche, l’identificazione delle cose attraverso un uso delle parole in grado di stabilire tra essi diversità, frontiere, limiti, distinzioni, risultano profondamente destabilizzati dalle sperimentazioni messe in atto dal testo. Ricorrendo a un sistema complesso di ossimori, iperboli, adynata, epanortosi, aporie logiche, astrazioni, e istituendo una porosità reciproca tra corpi, realtà, concetti, Thomas l’oscuro sospende le demarcazioni abituali e mette in contatto ciò che di solito teniamo distinto e separato.
Ogni azione appare reversibile, gli spazi sono defigurati fino all’indistinzione, le nominazioni delle grandi polarità fisiche e metafisiche – dentro e fuori, morto e vivo, organico e inorganico, immobilità e movimento, passivo e attivo, io e altri, finito e infinito, essere e nulla – sono ricondotte a una spiazzante simultaneità. Qualche esempio, tra i molti possibili: «era, nella morte stessa, privato della morte»; «faceva dell’assenza di visione il punto culminante del suo sguardo»; «era stretto dall’assenza stessa di limiti»; «La sola possibilità di ridurre la distanza che ci separa sarebbe quella di allontanarmi infinitamente». Blanchot arriva così a revocare l’adeguatezza dei concetti di cui ci serviamo nella nostra lettura del mondo, mettendo in mora le loro capacità di interpretazione, e esibendo un reale aspro e inafferrabile, già sempre presente e al contempo ancora e di nuovo sfuggente.
Mentre indica la realtà stessa delle cose, la scrittura nega a esse lo statuto di elaborazioni percettive stabili e acquisite. E prende nota, piuttosto, della capacità del reale – «ciò a cui non manca nulla», come lo definisce Lacan, un altro tra i grandi lettori di Thomas L’Oscuro – di eccedere significati, simboli, immagini.
Così come per il Blanchot delle opere successive, qui l’esperienza della scrittura, ciò che per essa è davvero «reale», irrompendo nella trama delle significazioni date, contesta la loro pretesa di veicolare un senso, di attestarne le origini, di certificare trascendenze e immanenze. Già per l’autore di Thomas L’Oscuro di questo può farsi carico solo un’arte del discorso che, abbandonando al loro magro destino storico le prassi letterarie conniventi con progetti e valori scaduti, si mostri capace di trasmettere quelle esperienze di estraneazione, impersonalità, sofferenza a cui, in modi al limite del dicibile, si trovano esposti gli uomini del nostro tempo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento