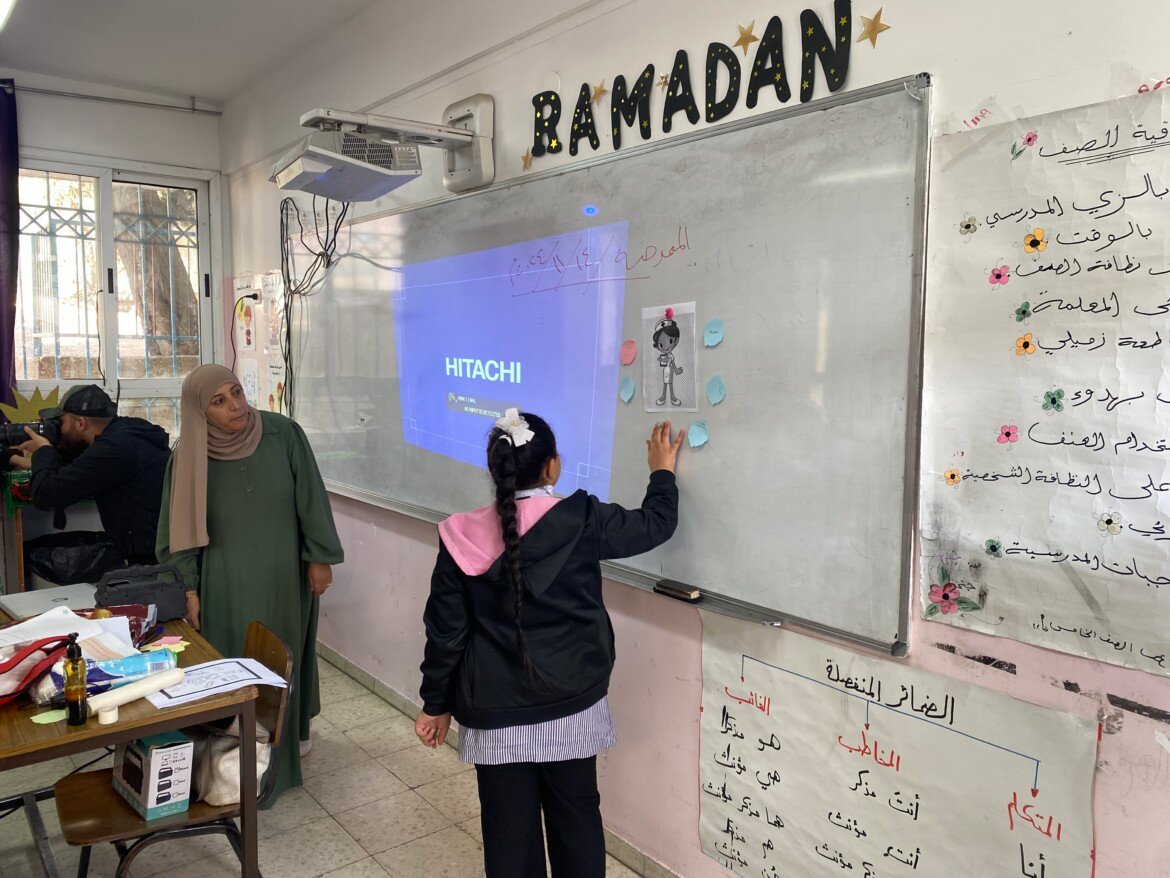La prigionia di Nasser Abu Srour
GEOGRAFIE «Il racconto di un muro», edito da Feltrinelli, è l’autobiografia di un detenuto condannato all’ergastolo. In un carcere israeliano dal 1993, l’autore palestinese narra la sua vita e quella di un popolo. Un libro universale e un flusso di coscienza che si appiglia ai tempi definiti della storia
 Una foto di Nasser Abu Srour viene mostrata durante una manifestazione del 2015 per la Giornata del prigioniero palestinese nella città di Bilin - foto di Abbas Momani/ Getty Images
Una foto di Nasser Abu Srour viene mostrata durante una manifestazione del 2015 per la Giornata del prigioniero palestinese nella città di Bilin - foto di Abbas Momani/ Getty ImagesGEOGRAFIE «Il racconto di un muro», edito da Feltrinelli, è l’autobiografia di un detenuto condannato all’ergastolo. In un carcere israeliano dal 1993, l’autore palestinese narra la sua vita e quella di un popolo. Un libro universale e un flusso di coscienza che si appiglia ai tempi definiti della storia
L’ergastolo è un cumulo di menzogne e speranze artificiali. È uno spazio minimo che tiene prigioniero il tempo, vuole addomesticarlo per renderlo innocuo e così rendere innocua l’anima costretta in una manciata di metri quadrati. È assenza di libero arbitrio del grande e del piccolo: delle occasioni perdute, del pasto serale. È la condanna a morte dello spirito, mentre il corpo espleta le sue funzioni quotidiane, «pesante fardello da portare, un limite imposto dalle leggi di natura che riduce la nostra capacità di ruotare, volare, nuotare in un oceano di nuvole… È un corpo sprofondato nell’analfabetismo e nell’ignoranza, senza una lingua, senza un discorso e senza un senso, che crede in un improvviso brivido notturno del quale, però, al mattino gli resterà soltanto un confuso ricordo».
Come la sorpresa, la gioia, il disgusto sono sentimenti universali, che prendono forma in modo identico sui volti di ogni essere umano del pianeta, così è l’ergastolo.
QUALSIASI SIA IL CARCERE, la vita prigioniera fino alla morte segna come uno stampo. Il libro di Nasser Abu Srour è universale, e allo stesso tempo unico perché narra di una vita specifica che è solo la sua e di una condanna unica che è quella palestinese.
Il racconto di un muro, edito da Feltrinelli (pp. 336, euro 19, traduzione di Elisabetta Bartuli), è un lungo memoir che è un gioiello.
Prosa di rara bellezza, come un flusso di coscienza si appiglia ai tempi definiti della storia e ripercorre tre decenni di galera puntellandoli con la vita fuori, i grandi sconvolgimenti attraversati dalla Palestina. La coda dolorosa della prima Intifada, i mendaci accordi di Oslo, la seconda Intifada e la ripresa fittizia del negoziato israelo-palestinese.
Una speranza dopo l’altra presto trasfigurate in bugie, una lunga serie che nella vita di Nasser Abu Srour è inaugurata da degli insospettabili, da chi pensava di poter valicare i confini di un campo profughi per farsi eroe: sono gli dei della menzogna, così li chiama Abu Srour, i giovani palestinesi dell’Intifada delle pietre. Dopo quattro decenni di esilio e occupazione israeliana, dopo anni trascorsi a ricostruire l’identità perduta, fatta in mille pezzi dalla Nakba, la Palestina si solleva e lo fa dai suoi luoghi più simbolici e allo stesso tempo più subordinati: i campi profughi, Jabaliya a Gaza, e poi Aida e Dheisheh a Betlemme, Jenin, Balata, il campo «luogo marginale gremito di individui marginali di cui parlava solo gente che nessuno ascoltava o che non aveva voce e io, come ogni bambino marginale, ho cominciato a esplorare i confini della mia marginalità».
GLI DEI DELLA MENZOGNA si scoprono eroi per risvegliarsi sconfitti. L’Intifada, prima che con la trappola di Oslo, per Nasser Abu Srour finisce nel 1993 in una camionetta dell’esercito che lo conduce nella prima delle sue tante prigioni. È accusato di aver ucciso un ufficiale dei servizi segreti israeliani. Dopo un mese di botte e torture, confessa per avere sollievo e invece firma il destino che del sollievo lo priverà per sempre.
Seguiranno prigioni diverse, l’isolamento, poi celle condivise, carceri a Nablus che gli permettono di scrutare una quotidianità familiare e quelle nel vuoto torrido del deserto del Naqab. In ognuna delle sue prigioni Nasser cerca, e trova, la via d’uscita alle menzogne: il muro.
Approdo solido e inscalfibile, ma permeabile allo scambio, il muro della cella diventa un sostegno, interlocutore silenzioso e voce di quel dio che fuori Nasser ha rifuggito. Un dio che appare e scompare, che non giudica né impone e che sarà sostituito solo quando l’utopia si fa possibilità: l’amore entra in carcere, si chiama Nanna ed è una folata d’aria fresca, quasi a ricompensare anni di privazione, anni a osservare la madre invecchiare e il padre ricacciare giù le lacrime perché si piange quando nessuno ti vede. Anni ad ascoltare la radio che sgrana come un rosario i nomi di chi può uscire e di chi invece deve tornare al suo muro.
Abu Srour ha fatto uscire dal carcere un libro bellissimo, incantatore, che svela a chi non vive in catene l’angoscia paralizzante della morte in vita, dell’ergastolo che come un virus contagia e uccide ogni cosa intorno, del potere totale e definitivo dell’essere umano sulla libertà di un altro suo simile.
ABU SROUR costruisce spazi infiniti dove di spazi non ce ne sono, dove l’evasione dello spirito è pratica peccaminosa.
La storia di una persona, di un ergastolano, di un campo profughi grande quanto un Paese intero, di un sogno sfumato ma non per questo meno credibile, di un innamoramento inaspettato che vive di troppa speranza e muore per troppa paura, è di fatto una dichiarazione d’amore per una casa che è allo stesso tempo memoria condivisa e idea di futuro.
Una casa che, nonostante la menzogna, non si smetterà mai di amare e agognare: la Palestina, che è centro e che è margine perché «un nuovo mito può nascere solo se quello vecchio muore o viene ucciso… perché un mito muoia o venga ucciso serve un altro mito che sia più potente e più bugiardo, sarebbe a dire che a noi serviva una bugia più grossa e più forte della Palestina come legame unificante, della Palestina della resurrezione, della Palestina di Dio e dei profeti, della Palestina delle pietre, della Palestina del mare e del cielo, della Palestina della memoria e dei nomi di un tempo, della Palestina che somiglia a tutto e niente le somiglia, della Palestina che ricompensa di tutto e che niente e nessuno ricompensa mai, della Palestina che toglieva il fiato a mio padre quando mi veniva a trovare».
*
SCHEDA/ 1. «CASE DI SALE», DI HALA ALYAN PER ASTARTE
È testardaggine mista a una ricerca continua, l’indagine prolungata e profonda del significato di «casa», che si ritrova come una costante nelle opere di autrici e autori palestinesi.
Nei romanzi, nelle canzoni, nelle pièce teatrali, narrare della precarietà della presenza e della temporaneità «permanente» della diaspora è un processo quasi terapeutico, individuale e collettivo, che lega il concetto di casa a quello di famiglia. La letteratura narra del dolore per la perdita della terra attraverso saghe familiari e percorsi accidentati di generazioni, dal 1948 a oggi, per tornare o per ricostruire altrove radici che sanno di pacificazione.
Lo fa anche Hala Alyan, scrittrice e poeta palestinese-americana, nel romanzo Case di sale, tradotto da Margaret Petrarca per Astarte (pp. 421, euro 16). Conosciamo la grande famiglia Yacoub quindici anni dopo la Nakba del ’48, quando Nablus è ormai divenuta la nuova casa obbligata dall’esodo forzato da Jaffa. Nella città cisgiordana focolaio politico, la cenere della ribellione brucia sotto quella di un trauma che si sta appena ricomponendo.
La cenere diverrà fuoco anni dopo, nei tentativi di rivolta, nelle carceri israeliane e poi nell’esodo del 1967 che le nuove case – Amman, Kuwait City, Beirut – non sopiranno mai.
Case di sale è poesia collettiva, narrata attraverso gli occhi di tutti i suoi protagonisti, ognuno autore di un capitolo, impegnato a ricomporre il racconto e se stesso: giustificare scelte, svelare misteri, mostrare la ricchezza culturale, religiosa, politica della società palestinese dispersa nel mondo. (Ch. Cru.)
*
SCHEDA/ 2. «POP PALESTINE» E «ARABPOP», DAI RICETTARI ALLE RIVISTE
Donpasta, al secolo Daniele de Michele, nella prefazione alla nuova edizione di Pop Palestine traccia in poche parole il senso più profondo di cucina: «il sedersi per un momento a rinfrancarsi» perché, proprio come la poesia, la cucina «rende le cose più belle».
Riposo, profumo di cose conosciute ma anche battaglia politica per ribadire un’origine: Pop Palestine di Fidaa Abuhamdiya e Silvia Chiarantini, edito da Meltemi (pp. 288, euro 28), è un ricettario che non si dà limiti, viaggio nella storia del cibo popolare palestinese e nei territori della Palestina storica, è un percorso disturbante dentro l’occupazione coloniale e allo stesso tempo la sedia di un tinello da cui osservare l’incontro degli ingredienti, immaginarsi odori e sapori, sentire su di sé il tepore rassicurante dei fornelli.
Ad attraversare la complessità della cultura palestinese è anche il nuovo numero di ArabPop, rivista di arti e letterature arabe contemporanee edita da Tamu.
Dedicato alla Palestina («paradigma e non metafora» come spiega nell’editoriale Christian Elia: «il paradigma è materiale, lascia segni vivi sulla pelle, mentre la metafora è evanescente e rischiosa»), ci sono racconti, saggi, musica e fumetti che gettano sulla Palestina, su Gaza, la luce che spesso manca nella cronaca quotidiana dell’orrore.
Il luogo che è, che era e che potrebbe ancora essere, e che – come scrive nel suo intervento Karim Kattan – disturba perché insiste a esistere quando dovrebbe limitarsi a sparire e portarsi via con sé «le espulsioni, i bombardamenti, le uccisioni, la fame di un popolo che ci costringete a scatenare su di voi». (Ch. Cru.)
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento