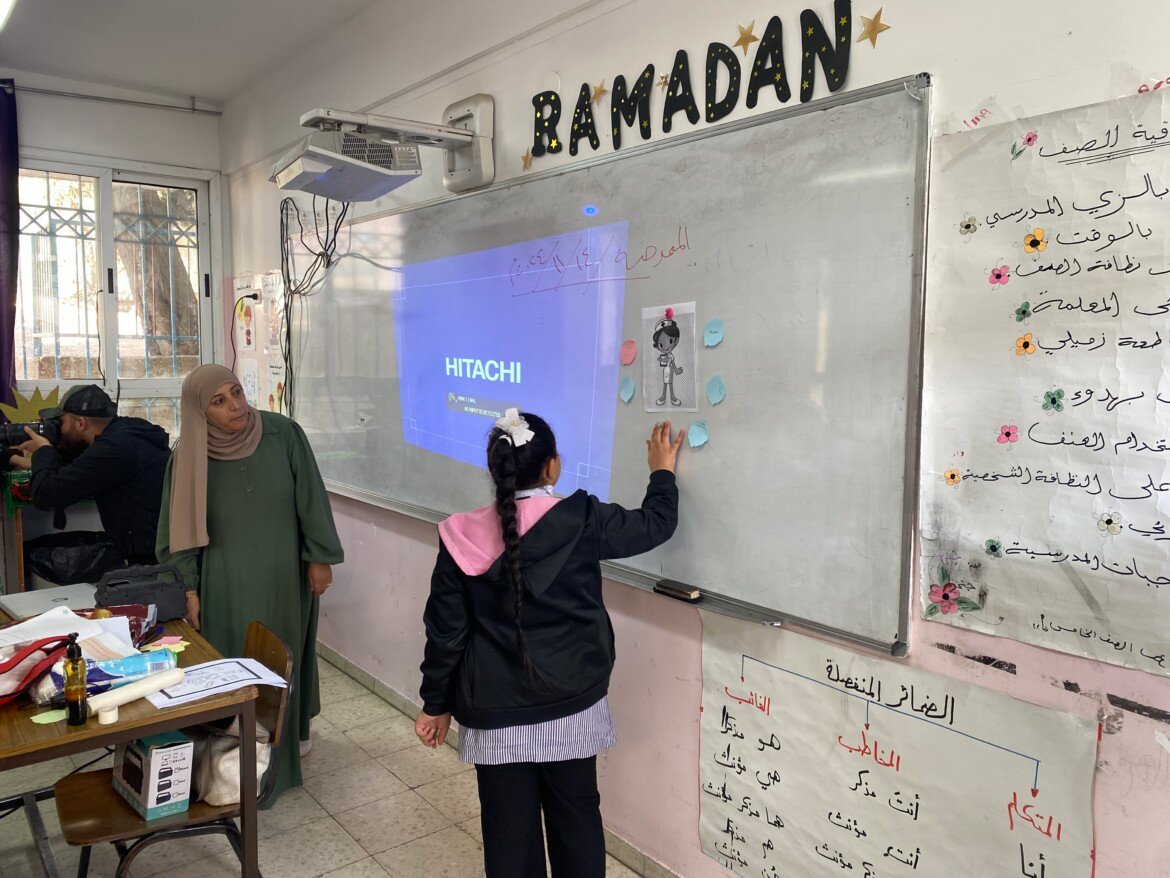Khaled e le piazze israeliane, un sistema legale che perpetua la diseguaglianza
Israele/Palestina Apparentemente vicende lontanissime tra loro: da una parte una mobilitazione eterogenea a difesa della Corte suprema, dall’altra la detenzione di un giovane italo-palestinese. Ma il legame c'è: quella in corso è una mobilitazione conservativa, tesa a mantenere lo status quo attuale, quello che distingue da 75 anni – su base etnica e religiosa – tra soggetti sottoposti alla stessa autorità. È possibile godere di un sistema giudiziario libero, indipendente e democratico all’interno di un contesto strutturale di occupazione militare e di discriminazione interna?
 Khaled el Qaisi
Khaled el QaisiIsraele/Palestina Apparentemente vicende lontanissime tra loro: da una parte una mobilitazione eterogenea a difesa della Corte suprema, dall’altra la detenzione di un giovane italo-palestinese. Ma il legame c'è: quella in corso è una mobilitazione conservativa, tesa a mantenere lo status quo attuale, quello che distingue da 75 anni – su base etnica e religiosa – tra soggetti sottoposti alla stessa autorità. È possibile godere di un sistema giudiziario libero, indipendente e democratico all’interno di un contesto strutturale di occupazione militare e di discriminazione interna?
Sono passati nove mesi da quando le prime manifestazioni hanno cominciato ad affollare le strade di Tel Aviv e Gerusalemme, protesta sempre più partecipata contro la riforma della giustizia immaginata dal governo del primo ministro israeliano Netanyahu e dalla coalizione di estrema destra. E ne è passato uno da quando il cittadino italo-palestinese Khaled el Qaisi è stato ammanettato e portato via al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania.
Apparentemente vicende lontanissime tra loro. Da una parte una mobilitazione eterogenea (giovani, impiegati delle start-up, magistrati, intellettuali, riservisti, un pezzo di destra liberale) contro una riforma che ha come obiettivo lo svuotamento dei poteri della Corte suprema. Dall’altra la detenzione di un giovane palestinese.
IL LEGAME esiste, seppur scompaia dalla narrazione che in Italia media e politica danno della vicenda di el Qaisi e delle proteste stesse. È una mobilitazione a difesa della democrazia, così la descrivono i manifestanti e chi in Europa li racconta, una democrazia compiuta di cui la Corte suprema è estremo baluardo.
Ma quella in corso è una mobilitazione conservativa, tesa a mantenere lo status quo attuale, quello che distingue da 75 anni – su base etnica e religiosa – tra soggetti sottoposti alla stessa autorità. È possibile godere di un sistema giudiziario libero, indipendente e democratico all’interno di un contesto strutturale di occupazione militare e di discriminazione interna?
Nel 1948 il neonato Stato di Israele aveva necessità di normare se stesso, di costruire un’impalcatura istituzionale e legislativa che gestisse «legalmente» la nuova realtà sul terreno, fatta di un’espulsione di massa (l’80% della popolazione palestinese dell’epoca, quasi un milione di persone) e dell’acquisizione dei beni mobili e immobili che quelle persone lasciavano dietro di sé. Sono state promulgate leggi, è stata istituzionalizzata la confisca di Stato ed è stato fondato un sistema giudiziario che da allora ha garantito che quelle norme discriminatorie si moltiplicassero e venissero rispettate.
Dal 1948 la magistratura israeliana è stata uno dei pilastri della salvaguardia del regime di segregazione etnico-religioso realizzata dentro lo Stato di Israele e dal 1967 lo è stata dell’occupazione militare. Seppur in violazione del diritto internazionale, la Corte suprema non ha mai messo in discussione lo stato di eccezione permanente, quello che lo storico israeliano Ilan Pappé – superando la teorizzazione di Giorgio Agamben – ha definito un mukhabarat state, uno stato d’intelligence e sorveglianza totale, che usa un mix di burocrazia, esercito, servizi segreti, violenza per mantenere il controllo della metà delle persone che vivono sul territorio della Palestina storica.
LE PROTESTE per la democrazia non lo scalfiscono. Chiedono che tutto resti com’è. E che resti com’è il doppio standard giudiziario applicato nei Territori occupati palestinesi, quello che oggi tiene in prigione Khaled el Qaisi senza accuse ufficiali e che vent’anni fa ha ricevuto l’assenso ufficiale della Corte suprema stessa (sentenziò che la tortura può essere applicata su detenuti palestinesi): da una parte corti civili riservate ai cittadini israeliani (i coloni illegalmente presenti in Cisgiordania), dall’altra corti militari per i palestinesi sotto occupazione. Due poli opposti: anche in presenza di identico reato, cambiano i diritti del detenuto e dell’imputato, cambiano i tempi di custodia e l’accesso alla difesa, cambiano le pene e l’età legale per distinguere adulti da minori.
È a questo sistema giudiziario militare che Khaled el Qaisi è sottoposto, come centinaia di migliaia di palestinesi prima di lui (se ne stimano oltre un milione dal 1967). È impossibile non tracciare una linea tra due vicende apparentemente distanti, per superare la narrazione mitica che vede nelle piazze israeliane la spinta vitale di una democrazia di per sé sana, ma messa in pericolo da un governo di estrema destra.
Fino a quando permarranno sistemi diversi sulla base dell’etnia e della religione non esisterà democrazia, ma quella che associazioni israeliane, palestinesi e internazionali non temono di chiamare apartheid.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento