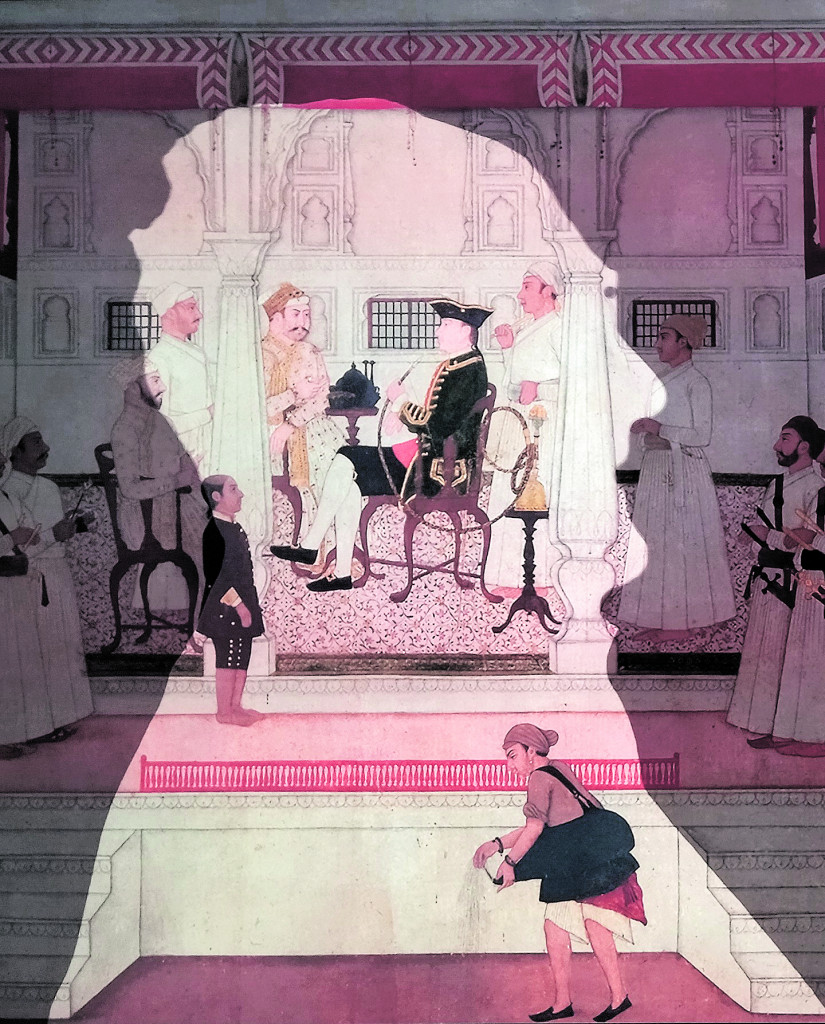Jakob Guanzon, lo sguardo d’America che incontra la fame
L'intervista Parla l’autore di «Abbondanza», pubblicato da Marsilio. Un romanzo d’esordio tenero e struggente per narrare la vita degli ultimi nel Paese più ricco del mondo. «Ho capito che volevo scrivere il libro vedendo una donna senza casa contare i centesimi per comprare il pane a New York»
 Eastgate Motel, Bellevue, Washington, 1992 – Getty Images
Eastgate Motel, Bellevue, Washington, 1992 – Getty ImagesL'intervista Parla l’autore di «Abbondanza», pubblicato da Marsilio. Un romanzo d’esordio tenero e struggente per narrare la vita degli ultimi nel Paese più ricco del mondo. «Ho capito che volevo scrivere il libro vedendo una donna senza casa contare i centesimi per comprare il pane a New York»
Poco più di un giorno nella vita di Henry e di suo figlio Junior, un pugno di ore per immaginare un’esistenza diversa, riepilogare cosa è andato storto fino a quel momento e fare un piccolo, umile salto verso un possibile avvenire migliore. No, non un sogno, quello forse è davvero difficile poterselo permettere quando si vive in un pick up, i morsi della fame ti stringono lo stomaco a tenaglia, i ricordi somigliano ad un impasto sofferente di sensi di colpa, rimpianti e occasioni perdute. Quella che Jakob Guanzon racconta nel suo romanzo d’esordio, Abbondanza (traduzione di Gaja Cenciarelli, Marsilio, pp. 364, euro 19), allo stesso tempo struggente e delicato, crudo quanto ad analisi e commovente quanto ad empatia, è una storia di povertà, di fame, di emarginazione.
Dotato di una lingua piana e sensibile, a metà strada tra il memoir e la narrazione da road movie, il libro ci porta nel cuore ferito e dimenticato della società americana, dove l’opulenza di facciata si specchia nell’invisibilità dei molti che non hanno nulla, spesso neppure le risorse per arrivare al giorno dopo. Intrecciando molti quesiti sui modelli maschili che si trasmettono non senza conflitti da una generazione all’altra – nel caso specifico quello del padre del protagonista, di origine filippina proprio come quello dell’autore, sulle dipendenze e la difficoltà a riemergere dai momenti di difficoltà in una realtà sociale che premia il successo e punisce gli sconfitti, Abbondanza racconta senza retorica, ma con una grande carica d’amore, la vita quotidiana degli ultimi nel Paese più ricco del mondo.
Un romanzo che narra una giornata nella terra dell’abbondanza, dove tutto appare a portata di mano anche quando è inaccessibile. Come è nato il libro?
La struttura mi è apparsa ben prima della storia stessa: in un istante, dentro un supermercato. Mi trovavo nell’Upper West Side di New York, un quartiere che è stato lo scenario borghese per la maggior parte dei film di Woody Allen ed è molto, ma molto diverso da dove vivo io, ad Harlem, per non parlare del mio Stato d’origine, il Minnesota. Ero stato invitato ad una festa ed ero in coda per pagare un cartone di birre. È in quel momento che ho visto una donna, almeno settantenne e visibilmente senza casa. Sul bancone c’era una manciata di monetine che lei stava contando diligentemente, tremante, centesimo dopo centesimo per pagare un pezzo di pane. Aveva bisogno di aiuto, solo di un briciolo di dignità, eppure tutto ciò che la gente poteva vedere era un’intollerabile interruzione del proprio comfort. La disumanità di tutto ciò ha rotto qualcosa dentro di me. Da quando mi ero trasferito a New York stavo imparando che non ha senso discutere delle disparità assolutamente rivoltanti di ricchezza di questa città attraverso le astrazioni della statistica quando accanto a noi c’è tutto ciò. Come scrittore ho capito che c’era una storia che aveva bisogno di essere raccontata in una nazione che misura non solo il successo ma anche il valore umano in potere d’acquisto, nel dollaro Onnipotente, fino al centesimo.
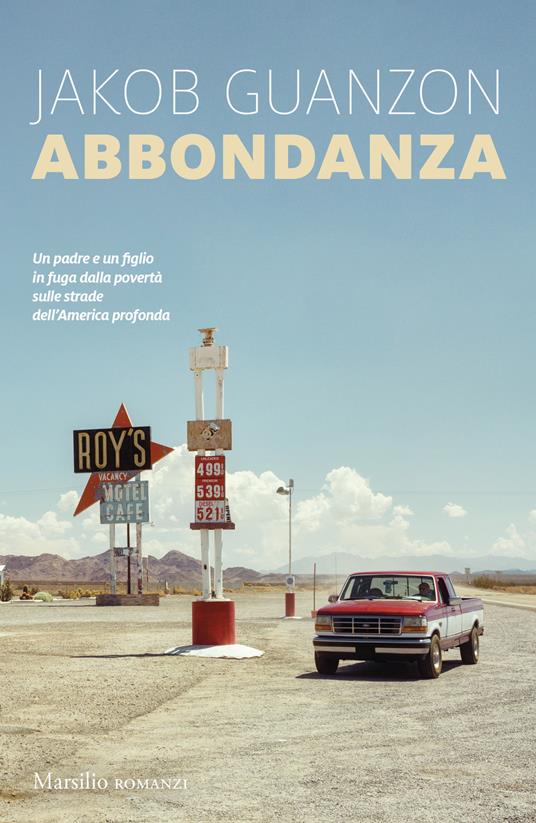
La bellezza della rabbia è che ha un obiettivo, decide cosa o chi incolpare. Ed è proprio per questo che ho dovuto offuscare il confine tra fame e rabbia finché non si è manifestato in un senso generale di disperazione che qualsiasi lettore, indipendentemente dal proprio background sociale, potrebbe sentire vicino. Personalmente ho conosciuto direttamente la fame da bambino, e attraverso la lettura, da adulto, ho appreso delle forze più grandi che avevano affamato la mia famiglia in nome del profitto. Ma mi sembrava cruciale che il romanzo fosse incentrato sull’esperienza viscerale della pressione di tali condizioni strutturali ed economiche sulla vita di un individuo e sulla sua reazione. Perché la spietata macina della povertà non ti esaurisce ma ti confonde, spingendoti a scagliarti contro chi è a portata di mano piuttosto che contro i veri colpevoli della tua sofferenza.
Il romanzo sembra dominato da un senso di perdita e di sconfitta, anche se mancano forse i presupposti perché i personaggi possano nutrire qualche speranza. Se non ci si può aspettare il lieto fine, cosa alimenta le traiettorie delle figure che compaiono nella storia?
La qualità più salvifica e agrodolce del popolo americano è la nostra aspirazione. Sì, può sembrare ingenuo, il sogno americano non è altro che una sfacciata bugia, ma è così: questa nozione culturale di speranza che ispira così tante persone a perseverare, nonostante le lezioni della Storia e la triste realtà di oggi. Tale ironia è resa ancora più tragica dalla sincerità del nostro ottimismo.
Il sottotitolo potrebbe essere «di padre in figlio», nel senso che malgrado Henry abbia sofferto nella relazione con il padre, ne ricalca in parte le orme nel suo rapporto con Junior. Non si può evitare di ripercorrere le vie del passato anche quando ci portano su un terreno incerto o doloroso?
Il dilemma dell’eredità – sia essa genetica, culturale, economica o morale – è parte integrante di questa storia, incarnata nelle tensioni generazionali tra padri e figli. Non so come sia in Italia, ma nella mia esperienza in America, il desiderio di un padre di costruire una vita migliore per i figli sembra universale, almeno quanto il desiderio del figlio di diventare una persona migliore, un padre più gentile e comprensivo di quello che ha avuto. Indipendentemente dal risultato, è perciò la lotta per migliorare ciò che abbiamo ereditato che definirà ciò che lasceremo a nostra volta dietro di noi, come avviene nel caso di Henry. Il suo il carattere è definito molto più dalla sua tenacia e dai suoi sforzi che dai suoi apparenti fallimenti, sia come giovane padre che come povero lavoratore nell’America moderna.
A proposito del proprio stile, Raymond Carver spiegava di voler raccontare un fatto e regalarlo al lettore nella sua immediatezza. Malgrado lei scriva di vite che sfiorano la sopravvivenza, adotta una forma tutt’altro che minimalista. Una scelta a un tempo poetica e politica?
In effetti con questo approccio penso di aver voluto rispondere a scrittori come Raymond Carver e Lucia Berlin, la cui austerità stilistica ha stabilito un punto di riferimento per la descrizione della povertà nella letteratura americana. Mentre ammiro profondamente questi autori, credo che l’esperienza della povertà sia connotata da un diluvio costante e travolgente di sensazione: dai morsi della fame alle inevitabili pubblicità ad alta definizione che ti prendono in giro con tutto il cibo, i vestiti e gli status symbol che non puoi permetterti. Insomma, una tale alluvione funge da promemoria per i poveri della loro inadeguatezza, della loro mancanza di valore: di ciò che ogni vero americano può superare con il duro lavoro, o almeno così dice il nostro mito nazionale.
La povertà in America è stata analizzata anche in inchieste e libri molto noti, da «Nomadland» di Jessica Bruder a «Una paga da fame» di Barbara Ehrenreich che evidenziano come il fenomeno riguardi anche chi ha un lavoro. Raccontare queste storie non produce alcun dibattito negli Usa?
In una certa misura sì, anche se i dibattiti non durano mai a lungo, e ancor meno stimolano un cambiamento. Uno dei motivi principali è che diamo la colpa ai poveri per la loro condizione. Qualcosa di così profondamente radicato in America, nel nostro culto del rude individualismo. Inoltre, è molto più semplice fare di chi vive in povertà un capro espiatorio, piuttosto che esaminarne la condizione nell’ambito del sistema e delle istituzioni che la generano. Lo status quo non avvantaggia poi solo l’élite. Anche la classe media è complice del perpetuarsi della povertà, a causa dell’utilizzo di servizi con salari da fame come Amazon e McDonald’s, o nel bloccare la costruzione di alloggi a basso reddito nei propri quartieri, per paura della diminuzione del valore delle proprietà.
Senza interrogarla direttamente, il suo libro chiama in causa la politica parlando delle condizioni di vita delle persone. Da questo punto di vista, per i protagonisti del romanzo cosa cambia se alla Casa Bianca dopo il 5 novembre andranno Harris o Trump?
Solo alla fine del libro, quando arriva lo sfratto al protagonista, svelo che la storia è ambientata nel 2015. Ciò aveva lo scopo sia di segnalare le condizioni che hanno portato all’elezione di Trump (nel 2016, nda), sia spegnere la nostalgia per l’era Obama. Sappiamo cosa significherà un’altra presidenza Trump per i miei personaggi: ulteriori tagli ai servizi pubblici, tariffe internazionali che gonfieranno i prezzi a livello nazionale, un’ulteriore deregolamentazione che paralizzerà i diritti dei lavoratori e arricchirà gli azionisti. E nonostante tutto questo e le bugie della sua campagna elettorale, i lavoratori poveri continuano a sostenere Trump con numeri imponenti e scoraggianti. Malgrado la dissonanza cognitiva che porta i lavoratori a sostenere degli sfacciati ciarlatani neoliberisti, il malcontento delle masse è stato cooptato dalla destra americana. Per quanto riguarda Harris, mi piace credere che la sua amministrazione risponderebbe ai bisogni dei poveri e della working class. Ha promesso di reintrodurre la child tax credit che ha fatto uscire dalla povertà milioni di bambini durante la pandemia. Mentre il candidato vicepresidente Tim Walz, governatore del mio Stato d’origine, è fortemente favorevole al sindacato e desidera implementare in tutto il Paese le mense scolastiche gratuite come aveva già fatto in Minnesota. Gocce nel mare, data la realtà davvero terribile degli Stati Uniti, ma meglio di niente. Francamente, però, penso sia ora che i miei concittadini, più che guardare ai politici perché ci salvino, cerchino di impegnarsi per rendere le nostre comunità più eque, prospere e accogliente. Questo è il tipo di America in cui mi piacerebbe vivere e di cui forse un giorno potrei anche dirmi orgoglioso.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento