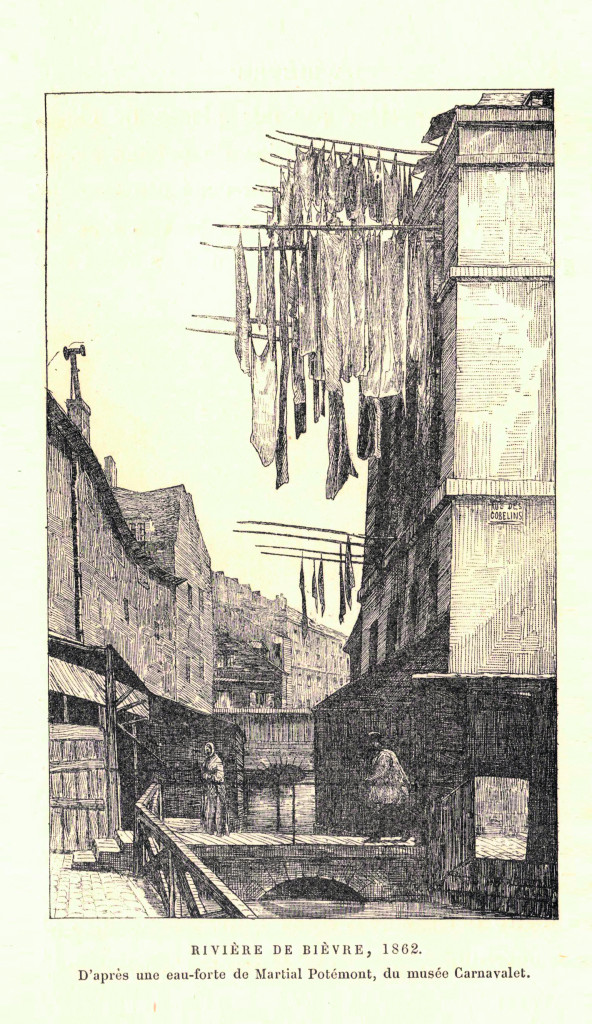Inès Cagnati, riverberi anaffettivi di una terra ingrata
Scrittrici francesi A cinquant’anni dalla pubblicazione, tradotto da Adelphi l’esordio di Inès Cagnati, «Giorno di vacanza»: protagonista, una ragazzina che si rivolge a se stessa, con frasi brevi, ripetute, ossessive
La storia editoriale di Inès Cagnati è ormai nota, ma resta sorprendente: venuta da una famiglia di veneti emigrati nelle campagne del sud-ovest della Francia, divenne insegnante nonostante all’inizio non capisse una sola parola di francese; sempre in disparte, defilata dalla società letteraria, ha pubblicato tre romanzi e una raccolta di novelle tra il 1973 e il 1980, vincendo qualche premio e venendo apprezzata da Michel Tournier, senza tuttavia conquistare mai davvero la critica. Presto dimenticata, fu riscoperta soprattutto nel mondo anglofono grazie a chi militava per una maggiore inclusione delle scrittrici nel canone letterario; ma è tuttora abbastanza in ombra in Francia, e lo era del tutto in Italia finché non venne tradotto, l’anno scorso da Ena Marchi per Adelphi, Génie la matta.
Cinquant’anni esatti dopo la sua prima uscita, riemerge ora dalla palude anche Giorno di vacanza, il primo romanzo di Inès Cagnati, appena uscito da Adelphi (pp. 151, euro 18,00) a cura di Lorenza Di Lella e Francesca Scala, la cui traduzione sa stare vicino alle cose, rimanendo sobria, dura e poetica al tempo stesso.
«Non ho molto fiato», dice la voce narrante, e forse per questo le sue frasi sono così brevi e nude. Non c’è spazio per il superfluo, d’altronde, nella vita di Galla, una ragazzina di quattordici anni nata in una famiglia dove manca tutto. Annie Ernaux l’avrebbe descritta come «una vita sottomessa alla necessità», e di fatto non solo l’abbigliamento è per lei un lusso, lo sono soprattutto i gesti dell’affetto. Nelle prime pagine pedala e spinge la bici lungo la strada – trentacinque chilometri – che separano la sua casa, isolata in mezzo alle paludi, in una terra ingrata senza sole e piena di sassi, dal liceo dove è stata ammessa come interna.
Per «riprendere fiato», almeno dal punto di vista narrativo, Galla si esprime in prima persona e divaga, si muove nei pensieri e nei ricordi, tenendoli accanto a sé durante la notte, che passa nella cuccia della cagna, dal momento che il padre l’ha chiusa fuori casa.
Il lettore non ha altra scelta se non farsi guidare dalla sua voce; ma non arriverà molto lontano: la ragazza non si è mai spostata dalla terra dove è nata, lei e le sue sorelle. Può però muoversi lungo l’asse temporale, di ricordo in ricordo, di associazione in associazione: ridotte a una sorta di grado zero della sintassi, le frasi si ripetono, alcune tornano in modo ossessivo, quasi identiche, e anche i pensieri si torcono intorno a un pugno di immagini forti, per poi sbrogliarsi un po’ alla volta fino al drammatico epilogo, solo accennato, come se alcuni nodi espressivi fossero impossibili da sciogliere.
Inesorabilmente sola, Galla racconta a se stessa delle storie, parla a sé «come se fosse due persone». Il lettore torna indietro nel tempo e impara a conoscere le pene della sua esistenza, insieme alle poche gioie concentrate intorno a tre figure amate: la madre, vittima come lei della miseria e delle violenze del padre; la sorella cieca, di tre anni, Antonella; e Fanny, la compagna di scuola, con le efelidi sul viso che la rendono bella: «come un luminoso sole di primavera. Io somiglio alle pozze delle paludi. È terribile essere come me».
Presa in giro anche a scuola, come «una specie di palla respinta con furia da una parete all’altra», Galla sogna di perdersi. Un suo professore le ha raccontato «una storia vecchissima», «la storia di una ragazza che si chiamava Ofelia»: come lei, Galla vorrebbe scomparire sotto l’acqua, e in passato l’ha fatto, almeno una volta, dopo avere (non si sa se volontariamente) ferito la madre. La sua palude non è e non sarà solo un paesaggio.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento