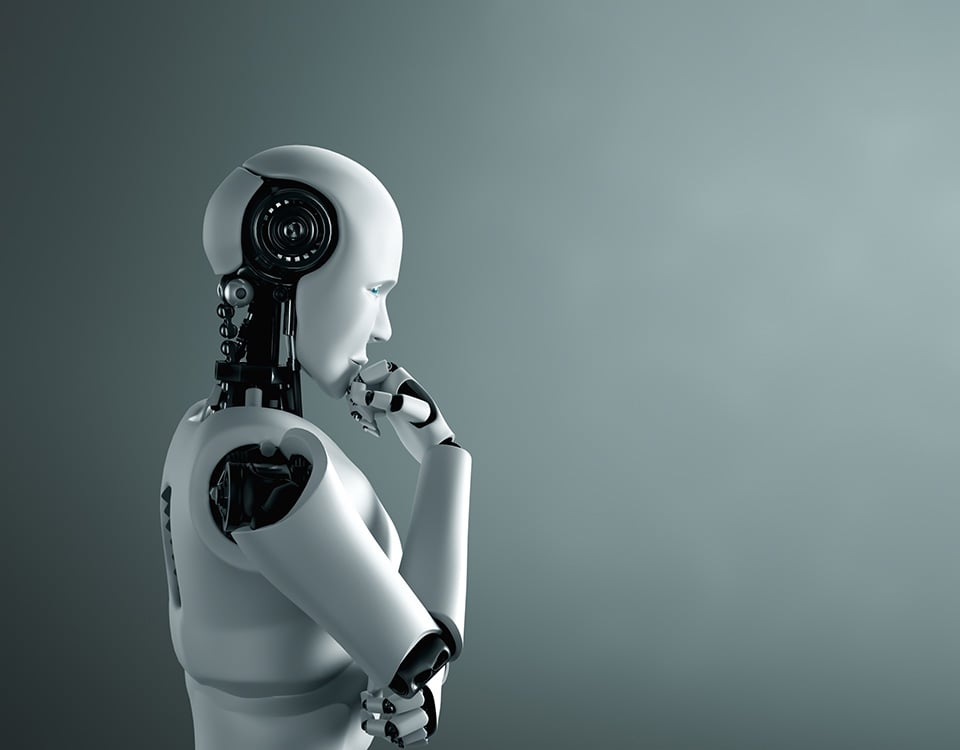Il telaio automatico che genera il mondo
Dentro la rete «Incomputabile» di Alexander Galloway, pubblicato da Meltemi. Cinema, tessitura, politica e biologia possono offrire chiavi di lettura della storia del digitale, di quel divenire macchina dei processi artistici, produttivi e scientifici
 – Ikon images / Ap
– Ikon images / ApDentro la rete «Incomputabile» di Alexander Galloway, pubblicato da Meltemi. Cinema, tessitura, politica e biologia possono offrire chiavi di lettura della storia del digitale, di quel divenire macchina dei processi artistici, produttivi e scientifici
In Cibernetica e fantasmi, conferenza del 1961, Calvino riconosceva già come da più direzioni e in più ambiti del sapere stesse affiorando una stessa tendenza, una discretizzazione del mondo e di ciò che prima era continuo. Il pensiero, che fino al secolo precedente era considerato come qualcosa di fluido, gassoso, associato all’anima e allo spirito, ora è sempre più descritto in termini di segnali, circuiti, impulsi elettrici.
Se Calvino prediligeva la letteratura come campo di indagine di questo fenomeno con le regole combinatorie della produzione narrativa e la scrittura automatica, la discretizzazione di ogni campo della conoscenza consente di tracciare nuove genealogie di questo fenomeno a radici più disparate. Ed è ad alcune di queste possibili genealogie che volge l’attenzione Alexander Galloway nel suo Incomputabile, dal sottotitolo Gioco e politica nella lunga era digitale (Meltemi, pp. 292, euro 20), tradotto di recente dal gruppo di ricerca indipendente Ippolita. E così cinema, tessitura, politica e biologia possono offrire chiavi di lettura della storia del digitale, di quel divenire macchina dei processi artistici, produttivi, scientifici.
LA STORIA della cronofotografia è usata da Galloway nel primo capitolo per raccontare un’evoluzione dal cinema al computer, dalla centralità dell’immagine a un modello informativo. Se Albert Londe, con la sua «macchina fotoelettrica» espande l’occhio della fotocamera dimensionalmente nello spazio anziché solo nel tempo, Braune e il suo studente Fischer portano la fotografia a un processo di modellizzazione tridimensionale dei corpi e dei loro movimenti. Utilizzando la fotografia come mezzo al fine di fornire dati e grafici dei movimenti di un soggetto, i due medici furono negli anni ’80 precursori di quella motion capture e di quella computer grafica che si sarebbe affermata decenni dopo.
L’autore procede poi con la tessitura, e il suo intreccio con la storia del calcolo a partire dal lavoro di Babbage, pioniere del calcolo automatico e ideatore della macchina analitica a partire dal telaio automatico di Jacquard. Lavoro poi descritto e ampliato da Ada Lovelace, intuendo che la macchina avrebbe trovato altre applicazioni (come quella musicale) a partire dalla possibile computabilità di altri processi. Ancora, se oggi si dibatte di limiti e possibilità dei modelli multiagente, un pioniere spesso dimenticato e ricordato da Galloway in questo ambito fu Nils Aall Barricelli, ricercatore dell’Università di Oslo che si dedicò alla genetica e allo studio dei virus attraverso modelli matematici per dimostrare la sua teoria della simbiogenesi.
L’EPIDEMIOLOGIA, come la guerra, è stata in più fasi vettore di computazione dei fenomeni biologici e sociali, come ricorda d’altronde David Quammen in Spillover citando la teoria matematica del premio Nobel Ronarld Ross nel suo studio della malaria. La guerra e l’analisi dei conflitti è un altro vettore di questo processo: dalla teoria dei giochi sviluppata durante la Guerra Fredda al Jeu de la Guerre di Debord, dove per il potere l’arcaico desiderio di prevedere le future mosse dell’avversario diventa cruciale, e da qui quindi anche il tentativo di formulare decisioni e scelte umane in modo scientifico e formale.
LEGGENDO GALLOWAY ci si accorge di quanto, seppur lontani nello spazio e nel tempo, questi eventi siano legati da fili rossi sottili, che al progredire dell’era digitale diventano sempre più evidenti, e sono accomunati dagli stessi timori e dagli stessi entusiasmi, che sono quelli che oggi pervadono il dibattito sulle macchine intelligenti: timore per l’automazione dei processi lavorativi, ottimismo per l’avvicinarsi di una fantomatica teoria leibniziana del tutto, paura per la fine di un’epoca umanista, messa in dubbio della razionalità degli agenti, umani e non.
A partire dalle conferenze Macy e la cibernetica di Wiener si inizia ad affermare il paradigma della scatola nera, ormai sempre citata quando si tratta di studiare l’intelligenza artificiale o i sistemi complessi su larga scala, iperoggetti talmente sofisticati che, anziché essere indagati come nell’approccio marxiano o freudiano tramite un’analisi profonda dei processi che li compongono, vengono invece studiati in termini di input e output, definendo così una nuova epistemologia del sapere.
UNA CONSEGUENZA di questi aspetti, che possiamo osservare se pensiamo alla fase post-pandemica, è la delega della comprensione dei fenomeni dagli esperti del settore (epidemiologi, psicologi, sociologi…) all’elite tecnodigitale, composta da accademici ma anche e soprattutto da chi detiene il monopolio dei dati. Epidemie, conflitti, gestione dello spazio urbano si traducono immediatamente in problemi di ottimizzazione e calcolo, diventato incarico della tecnica.
Ripercorrere le genealogie di questa discretizzazione, e prestare attenzione ai dubbi e i dibattiti che ne sono scaturiti nei vari contesti, è un compito allora sempre più cruciale per poter leggere e capire questi tempi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento