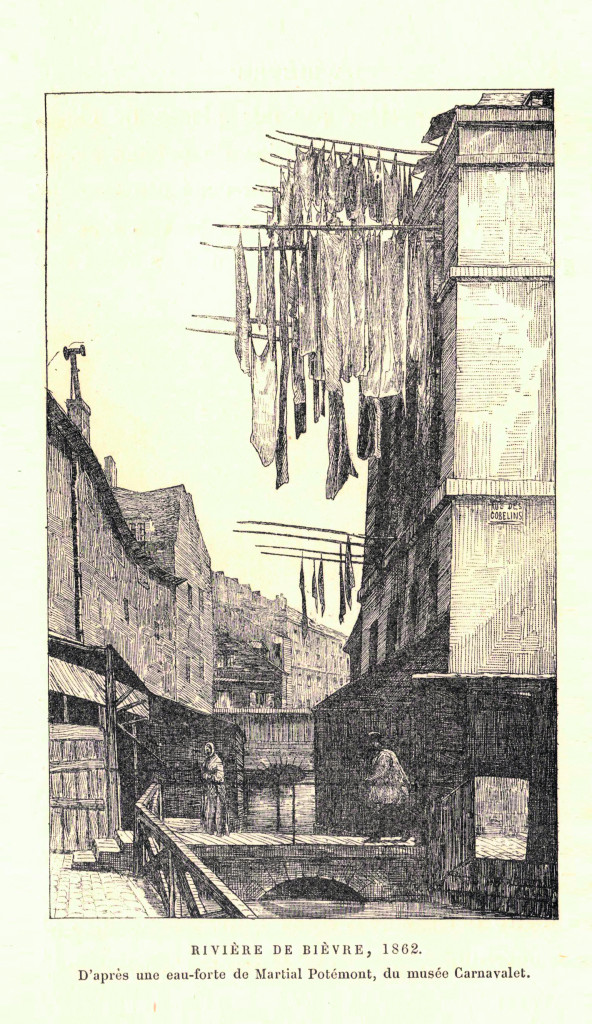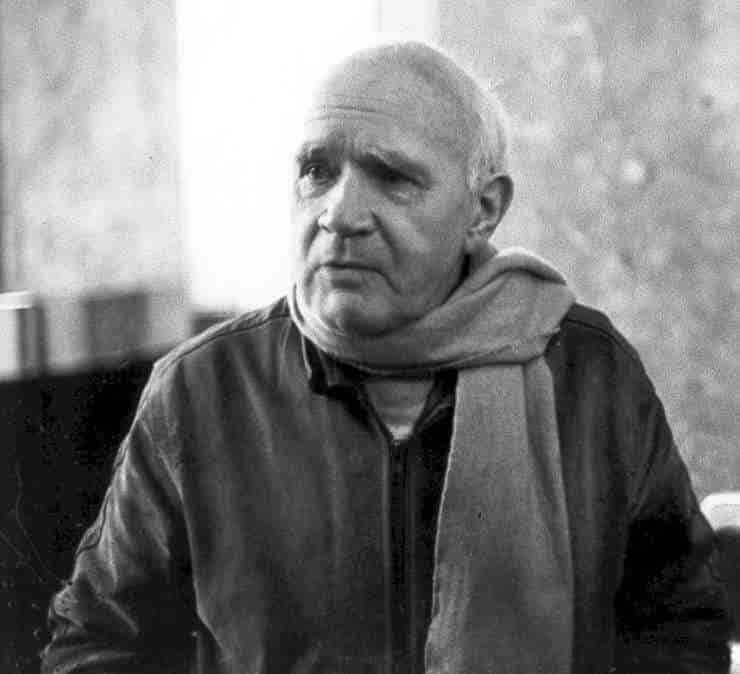Il popolo a venire (1/2): l’unione della destra contro il Fronte popolare
Elezioni politiche in Francia Di fronte all'ipotesi poco plausibile - ma non impossibile - di una condivisione consensuale del potere tra Macron e il Rassemblement National, dobbiamo riflettere sul significato di un Nuovo Fronte Popolare, senza teorizzarlo ma evidenziandone sia le difficoltà che le potenzialità
 Manifestazione di Marsiglia – Ap
Manifestazione di Marsiglia – ApElezioni politiche in Francia Di fronte all'ipotesi poco plausibile - ma non impossibile - di una condivisione consensuale del potere tra Macron e il Rassemblement National, dobbiamo riflettere sul significato di un Nuovo Fronte Popolare, senza teorizzarlo ma evidenziandone sia le difficoltà che le potenzialità
La catastrofe politica che si è abbattuta sulla Francia il 9 giugno ha colto molti di noi di sorpresa, eppure era stata ampiamente prevista. Innanzitutto dai sondaggi, anche se non sempre bisogna crederci. Ma soprattutto dall’ascesa pluridecennale del Front-Rassemblement National (RN) nelle elezioni e nell’opinione pubblica, che negli ultimi anni ha continuato ad accelerare e ad allargare la sua base.
Alla base di questa ascesa ci sono alcune cause convergenti, ognuna delle quali è ben nota. Errori commessi da politici “repubblicani” che hanno pensato di poter usare Le Pen, o sua figlia, a proprio vantaggio. Ci siamo forse dimenticati che lo stesso Mitterrand si è arreso a questo? C’è l’accettazione strisciante dell’idea che “l’immigrazione è un vero problema”, non solo dal punto di vista economico (anche se senza immigrati, compresi quelli privi di documenti, la Francia non funzionerebbe), ma per la diversità culturale e religiosa che apporta alla società francese e alle società di tutto il mondo. Questo è un compromesso con l’ideologia securitaria e autoritaria che l’RN propaganda instancabilmente. Ma c’è anche l’ignoranza o il disprezzo per l’angoscia e la sofferenza che la devastante globalizzazione sta causando nella società e che oggi favorisce ovunque l’ascesa dei nazionalismi. C’è lo sfinimento del dibattito politico che sostiene una governance basata sulla premessa dell’“ignoranza del popolo” e l’invasione dello spazio pubblico da parte dei social network commercializzati.
Il risultato è la denigrazione altezzosa o la repressione violenta di tutti i movimenti che, anno dopo anno, esprimono le richieste della società e ricreano la partecipazione civica. E a coronamento di tutto ciò, la demoralizzazione e il disorientamento prodotti nel “popolo della sinistra” dalle divisioni, la stagnazione intellettuale, la partigianeria, le inversioni di rotta opportunistiche e i ripetuti tradimenti dei loro impegni da parte di partiti la cui storia era destinata a incarnare un’alternativa al sistema economico dominante: un capitalismo finanziario sempre più feroce e arrogante.
Cosa avremmo dovuto aspettarci se non una brutale avanzata populista alla quale gli eredi del vecchio fascismo alla francese stavano lavorando da tempo? È quanto sta succedendo: come dicono i manuali di filosofia, “la quantità si è trasformata in qualità”. Nel giro di una giornata ci siamo trovati in un altro paesaggio, se non in un altro mondo. E soprattutto in un altro futuro. La rivelazione è avvenuta la sera delle elezioni europee considerate “senza posta in gioco nazionale”. Allora la cosiddetta estrema destra (RN, più “Reconquête”, più una parte da determinare dei “Repubblicani”) era diventata potenzialmente la maggioranza del paese. Tutto questo è stato vissuto come un trauma.
Si può immaginare cosa significherebbe l’arrivo al potere di Marine Le Pen, Jordan Bardella e della loro squadra: l’estinzione delle libertà civili a favore di una polizia libera da ogni controllo e obbligo, il monopolio degli imperi mediatici ultraconservatori e la loro morsa sulla cultura e sull’informazione, la regressione dei diritti sociali e lo smantellamento dei servizi pubblici, la xenofobia criminale incoraggiata e persino formalizzata, un ordine morale, sanitario e carcerario…
A questo primo choc ne è seguito immediatamente un secondo dagli effetti ancora più contraddittori: l’annuncio da monarca da parte del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, colpito in pieno dal successo dell’avversario da lui stesso designato, di sciogliere l’Assemblea Nazionale e annunciare le elezioni praticamente senza campagna elettorale. Perché questo colpo di teatro architettato con un manipolo di consiglieri irresponsabili, all’insaputa del governo e nel grande sgomento dei suoi stessi fedelissimi, ha messo alle strette tutti coloro che non possono rassegnarsi a piombare nella notte senza fare nulla, rivelando il pericolo imminente di un cambio di regime. Troppe esperienze storiche ci insegnano che ne usciremo solo alla lunga, pagando un prezzo terribile. Se ne usciremo.
Per tutti i cittadini che noi siamo era fuori questione limitarsi a dirsi: lasciamo passare questo brutto momento e aspettiamo che dimostrino la loro incapacità… Al contrario, è diventato evidente che bisognava agire, riunirsi, mobilitarsi. Nel giro di poche ore sono stati lanciati appelli in tal senso. Un piccolo gruppo di dirigenti di sinistra che, nel naufragio della Nupes (l’alleanza delle sinistre alle elezioni del 2022, ndt.), avevano mantenuto tra loro legami di fiducia e di immaginazione, ha preso l’iniziativa di riunire i partiti, emarginando allo stesso tempo coloro che, da tutte le parti, avevano trasformato la competizione elettorale in una frattura ideologica e personale. Rimasti uniti dal movimento contro la riforma delle pensioni, i sindacati hanno indetto a manifestare per unire le forze sociali e democratiche nella lotta.
Una mina vagante de La France Insoumise, il deputato François Ruffin, ha lanciato l’idea di un nuovo “Fronte Popolare”, subito accolta con favore, arricchita da un esplicito riferimento all’ecologia e iscritta dal nome stesso in una tradizione che associa l’unità delle forze di sinistra allo sbarramento repubblicano di fronte al pericolo fascista. È questa l’idea che oggi guida lo sviluppo della strategia e del programma elettorale dei quattro partiti che aspirano alla maggioranza nella prossima Assemblea e che costituisce l’orizzonte delle mobilitazioni e delle consultazioni che hanno preso forma. Sto semplificando, ovviamente. Lo choc non si è attenuato, il rapporto di forza nel paese non si è invertito, ma si è aperta una prospettiva di resistenza e di alternativa. Di conseguenza è tornata la speranza. Il peggio non è certo e la sconfitta collettiva annunciata potrebbe trasformarsi in una controffensiva, se si verificano molte condizioni favorevoli.
Appoggio pienamente questa prospettiva. Tra gli altri voglio cercare di dare un contributo come cittadino e come intellettuale. Non ho alcuna pretesa di influenzare decisioni e negoziati, né di elaborare linee guida. Piuttosto, a beneficio mio e di chiunque altro voglia opporre altre ipotesi, mi propongo qui di “problematizzare” questa idea di fronte popolare, affrontando le difficoltà e le potenzialità. Sono certo che non è nata dal nulla, ma vedo anche che si tratta di una “trovata”, e l’esperienza dirà se è stata felice o meno.
Sono colpito sia dal numero di proposte che stimola sia dalle imprecazioni che suscita, perché fin dall’inizio ha stabilito una polarizzazione che può evolvere e che dobbiamo sperare porti a chiarimenti piuttosto che a processi alle intenzioni. Non è certo mia intenzione fornire una “teoria”, ma indicare, attraverso alcune questioni di storia, di linguaggio o di strategia, la natura degli ostacoli che prevedo e le risorse che potrebbero essere opposte.
Il “rischio” di Macron e il gioco della destra: il terzo scenario
La prima questione che penso debba essere discussa riguarda la strategia seguita dal presidente Emmanuel Macron e delle opzioni che sta considerando. Anche se, data la struttura delle istituzioni e il metodo piuttosto peculiare dell’attuale potere, ogni risposta deve comportare un certo grado di congetture.
Fin dall’inizio, la stampa ha insistito sull’idea che Macron stia “rischiando grosso” o “giocando a poker”. Questo è evidente, purché si chiarisca che il rischio è per lui e per chi lo segue, ma soprattutto per gli altri, per il paese e quindi per tutti noi, materialmente ed esistenzialmente. C’è il rischio di bloccare la capacità di governo, o addirittura il caos e gli scontri violenti che potrebbero aprire la strada a iniziative autoritarie. La Costituzione della Quinta Repubblica, in parte redatta sotto l’influenza delle idee schmittiane sullo “stato d’eccezione”, faciliterebbe questa opzione. C’è il rischio di una crisi finanziaria dello Stato che metterebbe a rischio la continuità dei servizi pubblici e delle politiche economiche a causa dell’esplosione del debito. C’è il rischio di delegittimare il sistema politico rappresentativo. E così via.
Ma se torniamo agli obiettivi di Macron, vedo che gli analisti prospettano principalmente solo due scenari: quello di un improbabile “recupero” del macronismo che, contro ogni logica, sarebbe riuscito a proporsi ancora una volta come baluardo contro l’arrivo del lepenismo al potere, e quello di una vittoria dell’RN (ormai sostenuto da diversi alleati) che otterrebbe la maggioranza assoluta e imporrebbe la coabitazione. Quest’ultima si preannuncia conflittuale e quindi esposta a ogni sorta di sconvolgimenti interni ed esterni. In realtà, Macron allontanandosi dal modello gollista di cui ogni tanto imita gli atteggiamenti, ha escluso di dimettersi in caso di sconfitta del suo schieramento.
Queste ipotesi sono di buon senso, ma mi sembra che si faccia troppo in fretta a escluderne una terza, ancora più “rischiosa” delle precedenti, quella che nasce dalle forze esistenti, dall’evoluzione del loro discorso e dalle tendenze osservabili a livello internazionale: quella di un’alleanza “innaturale” tra gli avversari, e quindi di una condivisione consensuale del potere tra Macron e l’RN, incarnata da Bardella come primo ministro con Marine Le Pen più o meno in disparte. Consensuale non significa, ovviamente, priva di secondi fini e di intenzioni mortali: ci si può trovare d’accordo nel cercare di distruggersi a vicenda in modo più efficace.
Non c’è dubbio che questa ipotesi sia poco verosimile[1]. Vengono avanzate una serie di obiezioni. In primo luogo, la resistenza che susciterà in entrambi gli schieramenti. E quindi le defezioni che ne deriveranno. Soprattutto da parte macronista, poiché è prevedibile che l’ascesa al potere rappresenti per i politici di estrema destra che puntano alle elezioni presidenziali del 2027 un bonus che vale tutte le concessioni. Poi ci sono le questioni di vanità personale che sono indissolubilmente legate alla distribuzione di settori di competenza e di prerogative tra presidenza e governo, e quindi al modo in cui si negoziano compromessi e svolte. Infine, ma non meno importante, c’è la questione delle differenze dei programmi e delle parole d’ordine.
L’RN ha aumentato il suo elettorato esprimendo critiche violente al “macronismo” e, più in generale, al “sistema” (una vecchia tradizione dell’estrema destra), proclamandosi difensore del tenore di vita e della dignità della gente comune, nonché come avversario intransigente della tecnocrazia di cui Macron e il suo entourage figurano essere la pura incarnazione. Il suo “sovranismo nazionale” sembra essere l’antitesi dell’europeismo che Macron ha proclamato nel discorso della Sorbona e per il quale sostiene di essere il leader negli organismi dell’Unione Europea. Questo vale sia per la sua posizione nei confronti della Russia e della conduzione della guerra in cui l’Unione Europea è coinvolta in Ucraina, sia per la protezione delle imprese francesi dalla concorrenza internazionale. Eppure… La decisione immediata di Bardella di ritirare dal suo programma l’abrogazione della riforma delle pensioni dimostra che i principi sono flessibili. Interpretata come un modo per facilitare l’alleanza con la destra “tradizionale” (LR), questa decisione potrebbe altrettanto facilmente – insieme ad altre dello stesso tipo – facilitare l’accordo con i Macron, Darmanin e Lemaire, per i quali questa riforma imposta contro l’intero paese è diventata un totem.
In politica internazionale, il modello “occidentalista” di Giorgia Meloni potrebbe indicare la strada da seguire, allentando allo stesso tempo alcuni legami con Mosca che sono diventati pericolosi. Non bisogna certo esagerare, perché l’elettorato si sentirebbe tradito fin dal primo giorno (come gli elettori di sinistra di Hollande nel 2012). O, per essere più precisi, è necessaria una certa scienza del bispensiero come la definiva George Orwell. Ma a meno di rischiare una crisi istituzionale prima del tempo, l’RN ha bisogno di Macron e della tecnocrazia che lo circonda per poter utilizzare la macchina amministrativa dello Stato, la cui cultura e le cui reti di influenza gli sono in gran parte estranee, con la notevole eccezione della polizia.
Macron, da parte sua, deve evitare una guerriglia tra i poteri di cui le precedenti convivenze della Quinta Repubblica danno solo una pallida idea. Se vuole continuare a presentarsi come “capo” sulla scena internazionale, che è il suo punto di vanità per eccellenza, ed evitare il declassamento della Francia agli occhi delle istituzioni finanziarie europee e mondiali. E c’è da scommettere che i leader e i portavoce del capitalismo francese faranno sentire il loro peso, adducendo il realismo economico, l’interesse nazionale e i rischi “sistemici” di un conflitto politico aperto nel cuore dell’Europa.
Ma i primi terreni di incontro, dove le differenze possono essere appianate e tutti gli interessi riconciliati, possono già essere identificati. Me ne vengono in mente almeno due, grandi come case. Il primo è la xenofobia, e quindi la politica di repressione di migranti e rifugiati, che il voto sulla legge Darmanin, che istituisce per la prima volta in Francia la “preferenza nazionale”, ha riscosso il consenso dell’RN. A questo si aggiunge, naturalmente, la guerra al “comunitarismo” e al “separatismo” rivolta a milioni di residenti e cittadini di origine straniera, su basi di fatto razziali.
Il secondo è il programma di ripristino dell’“autorità” civile, educativa e familiare e di promozione del patriottismo nella tradizione conservatrice e militarista. Questo programma si sposa molto bene con la difesa dell’“universalismo” inteso come cancellazione dei diritti delle minoranze a cui, anche a costo di qualche battuta d’arresto, la presidenza Macron ha da tempo aderito, e converge pienamente con i valori proclamati dall’RN: l’immutabile petainismo francese. Non si tratta di un “programma comune”, ma è comunque un serio punto di partenza.
Si delinea così uno scenario irto di ostacoli ma che sarebbe sciocco escludere a priori: una guerra “totale” durante il periodo elettorale tra i portavoce dei due schieramenti (compreso lo stesso Macron), seguita immediatamente, in caso di risultato a lui sfavorevole (e se, punto cruciale, la sinistra non riuscirà a bloccare la spirale), da una nuova trovata e da una nuova “propensione al rischio”: nell’interesse del paese, per salvare la Repubblica e la posizione internazionale della Francia, per bloccare la strada verso l’anarchia (cioè il Fronte Popolare), occorre riunire il centro e l’estrema destra (incorporando nel processo la vecchia destra) e farli lavorare insieme. In questo modo, il ritorno a una bipolarizzazione della vita politica francese a scapito dei tentativi di governo “né a destra né a sinistra”, annunciato da alcuni politologi, diventerebbe un fatto compiuto.
Una realtà brutale, sinonimo non di un conflitto civile o di una riattivazione dell’“agonismo” politico di cui parlano altri teorici (e che altrove ho chiamato “democrazia conflittuale”), ma di criminalizzazione dell’opposizione e di normalizzazione dello stato di eccezione. È anche contro questo pericolo che dobbiamo trovare una risposta, o meglio è questa configurazione che una politica di fronte popolare deve trasformare nel suo contrario, dal punto di vista del rapporto di forze e dei progetti politici da far emergere.
Fronte Popolare e Unione della Sinistra: qual’è la differenza?
Ecco perché non credo sia una perdita di tempo tornare indietro nel tempo e confrontare le circostanze storiche. Il riferimento al “Fronte Popolare” è un tema ricorrente nell’immaginario politico francese e potrebbe essere visto come puramente simbolico, mentre in realtà solleva questioni fondamentali. Il più delle volte, però, viene invocato in difesa delle istituzioni nate dall’esperienza unica del 1936-38 (come le ferie pagate e la scuola unica), semplicemente per dimostrare cosa si può ottenere dall’unione dei partiti di sinistra in termini di diritti del lavoro, cultura, istruzione, sanità pubblica – in breve, un governo al servizio della stragrande maggioranza del popolo.
In questo senso, è apparso più volte nella nostra storia contemporanea (in particolare, un altro esempio decisivo, dopo l’insurrezione del maggio 68 nella formazione dell’ “Unione delle Sinistre” con il suo programma comune, che ha portato all’elezione di Mitterrand alla Presidenza). Ma la decisione presa dai partiti di sinistra aggiunge un elemento strategico che rende necessario approfondire l’esame delle analogie e delle differenze, per cercare di trarne insegnamenti pratici.
Le ragioni principali sono due. La prima, ovvia, è che il “fronte popolare” che ha appena preso forma è, come nel 36, una risposta diretta alla gravità del pericolo “fascista”. O, se preferiamo aspettare un po’ prima di esaminare la rilevanza di questa categoria, al pericolo di una presa di potere dell’estrema destra, che è una minaccia mortale per la democrazia. Come possiamo contrastare il fascismo o i suoi successori? Riunendo quali forze nella società e dando loro che tipo di organizzazione? Questa è la prima domanda, e l’esempio del “primo” Fronte Popolare dovrebbe essere esaminato.
L’altra faccia della medaglia è che nella storia del nostro paese c’è una differenza qualitativa tra diversi tipi di sindacato: o si tratta più di un’unione di partiti (che possiamo chiamare “cartello”), anche sostenuta da mobilitazioni che vanno al di là di essi, per proporre un’“offerta” comune agli elettori; oppure si tratta di un movimento di massa i cui protagonisti sono i cittadini stessi e i partiti uno dei quadri organizzativi e al tempo stesso lo strumento nel campo delle istituzioni politiche.
La prima formula è naturalmente richiesta da una scadenza elettorale (che, non c’è dubbio, è l’emergenza attuale). Ma è per definizione in balia delle vicissitudini elettorali e del loro seguito, il che significa che può andare in frantumi in caso di sconfitta o, più o meno rapidamente, nel corso di un esercizio del potere che vede riaffiorare la tentazione di ciascuna componente di far prevalere il proprio programma e di trovare il proprio sostegno nell’opinione pubblica per farlo.
La seconda suggerisce, al contrario, che si è avvertita un’urgenza storica che ha generato un affetto comune nel cuore dei cittadini, facendo passare in secondo piano la molteplicità dei loro interessi e delle loro ideologie, in grado di creare quotidianamente quella che il filosofo Jacques Rancière chiama “una comunità di lotta che è allo stesso tempo una comunità di vita”, messa al servizio non solo di un programma di governo, ma di un progetto di società che mira a trasformare le condizioni di esistenza. Si dirà che si tratta di “idealtipi” molto semplicistici e che la realtà dell’esperienza storica si colloca sempre a metà strada.
I cittadini, in quanto “soggetti”, che si iscrivono ai partiti o ne seguono le indicazioni, investono sempre nelle loro scelte una convinzione o una passione trasformatrice; e le “moltitudini” in movimento verso il futuro che credono di potersi forgiare sfidando l’ordine costituito sono comunque alle prese con problemi di rappresentanza, di disciplina, di tattica e di leadership, che rientrano tutti nella politica dei partiti. È stato chiaramente così nel ’36. Si pensi alla questione della “partecipazione dei comunisti al governo”. Ed è stato ancora così nella sequenza che va dal maggio ’68 alla presidenza Mitterrand. O meglio, se devo credere ai miei ricordi personali, fino alla crisi sindacale intorno all’“aggiornamento del programma comune” che ha portato al fallimento elettorale del 1978. I semi di un’unione di base (o, come si diceva allora, “nelle lotte”) erano stati gettati, superando la grande frattura tra il movimento operaio di protesta e i “nuovi movimenti sociali” antiautoritari, ma i calcoli e le rivalità tra i due partiti di sinistra, anche se coperti da un patto di governo, li avevano privati della capacità di influenzare le politiche perseguite congiuntamente. Lo abbiamo pagato caro dopo il 1981.
La mia sensazione, per dirla in parole povere, è che il nostro “nuovo Fronte Popolare” sia attualmente sospeso tra le due formule. Esiste un’alleanza elettorale, sostenuta dalla necessità di resistere all’ondata di estrema destra evitando scontri fratricidi, e dalla convinzione che la forza dell’RN sia in gran parte il contraccolpo del “vuoto” politico creato dall’assenza di una sinistra stabile. Una forza sufficientemente organizzata, sufficientemente armata ideologicamente, dotata almeno virtualmente di un programma che fa parte di un progetto per il futuro. In pochi giorni, appena conclusa, questa alleanza ha dimostrato una capacità di iniziativa piuttosto sorprendente che, di fatto, ha destabilizzato i suoi avversari, soprattutto da parte del potere, che si aspettava che il posto della sinistra restasse strategicamente vacante.
Le sue debolezze sono però apparse subito e il governo le ha subito sfruttate. Un François Hollande che, senza vergogna, è tornato a candidarsi per – qualcuno pensa – frenare la voglia di “rottura” con il passato che lui incarna, anziché sostenerla. Oppure Jean-Luc Mélenchon che ha riaffermato subito la sua presa sul partito da lui fondato “personalmente” a scapito dei deputati uscenti che sono figure rappresentative della tendenza unitaria al suo interno e ha lasciato intendere che in tal modo egli vorrebbe dominare dall’esterno il gruppo parlamentare. Ma soprattutto, non esiste, o non esiste ancora, accanto all’alleanza elettorale un movimento di cittadini “di base”, capace di sostenerla, incoraggiarla e controllarla, nonostante ci siano appelli, manifestazioni, incontri o scambi sui social network.
È ovvio che un movimento o una mobilitazione che possa essere definita “di massa” non emergerà in pochi giorni, semplicemente perché è necessario o perché qualcuno lo chiede. Ma credo anche che sarà difficile, e quindi richiederà un grande sforzo di volontà e fantasia, e che valga la pena chiedersi perché. È qui che, ancora una volta, uno sguardo all’esperienza del 1936 può fornire indicazioni preziose.
Come trovare il popolo?
Non mi si fraintenda. Il riferimento al Fronte “storico” e il prestito del suo nome per lanciare la mobilitazione contro l’annunciata vittoria del Rassemblement National, a cui il presidente Macron ha dato un formidabile impulso, è una grande invenzione perché il momento in cui ci troviamo è caratterizzato, come nel 36, da un’alternativa radicale: o lo Stato si mette al servizio di un progetto totalitario, i cui proclami di “normalizzazione” non devono trarre in inganno, oppure si forma nell’urgenza un “popolo” di resistenti, consapevole degli interessi fondamentali che lo uniscono e degli obiettivi da raggiungere, ribaltando quello che sembra essere una fatalità.
Questa è la grande analogia tra la situazione del 1936, quando il fascismo salì al potere in un paese europeo dopo l’altro, dopo il tentativo di colpo di stato antiparlamentare del febbraio ’34, e la nostra nel 2024, quando la Francia è a sua volta conquistata dall’“ondata populista”, “illiberale” e nazionalista che si sta diffondendo in tutto il mondo e in particolare in Europa. Ma del resto, se scendiamo al livello delle condizioni economiche, delle forze sociali, delle ideologie, perfino degli affetti, nulla o quasi di ciò che aveva consentito la formazione e il successo (anche transitorio) del Fronte Popolare sembra più esistere. Quindi prevalgono le differenze, ma cosa significa esattamente?
Il “1936”, per dirla breve, corrisponde al punto più alto di intensità e di purezza raggiunto nel nostro paese dalla lotta di classe come matrice della lotta politica e della personalità dei suoi attori. Lo scontro tra democrazia e fascismo non ha fatto altro che intensificare e sovradeterminare questa configurazione, tanto che le due logiche si sono strettamente fuse, al punto da diventare praticamente indistinguibili nella coscienza degli attori. “Pane, pace, libertà”: cittadini e lavoratori, militanti e dirigenti del Fronte popolare hanno difeso con un solo movimento la democrazia (nell’unico modo possibile, espandendola), e imposto (con lo sciopero e l’occupazione delle fabbriche) le più grandi “conquiste operaie” nella storia del capitalismo.
Ciò è senza dubbio dovuto al momento in cui questa lotta ha avuto luogo, all’indomani di una guerra, di una rivoluzione e di una crisi economica globale. Uno dei rarissimi momenti storici in cui le classi sono diventate “visibili” per se stesse e le une per le altre. Di qui l’esistenza di un potente movimento operaio, pur diviso in più organizzazioni, composto sia da sindacati che da partiti, di una solidarietà di classe che faceva parte delle condizioni stesse dell’esistenza quotidiana, come nell’aiuto ai disoccupati, e di un’“orizzonte dell’attesa” o di un’utopia che ha immediatamente dato all’antagonismo politico il significato di una messa in discussione del capitalismo. Costringendolo in ultima analisi a inventare nuovi modelli di regolamentazione del lavoro e di “compromesso sociale”. A questo si aggiungeva il concretizzarsi di una questione costituzionale, nel senso di “costituzione materiale”, ormai più che secolare, che si era posta fin dalla Rivoluzione francese, relativa alla scelta tra una repubblica oligarchica, retta da “élite” borghesi nell’interesse dei ricchi, e una democrazia repubblicana, in cui le classi popolari esercitano un potere reale, anche se non è assoluto e passa attraverso i rappresentanti.
Possiamo allora affermare che queste classi, nonostante le difficoltà materiali in cui si dibattevano e la violenza dell’aggressione che mirava a terrorizzarle, sono state storicamente all’offensiva e ne hanno preso coscienza, proprio sotto forma di un “fronte” il cui linguaggio della trasformazione sociale fu immediatamente comprensibile ai suoi partecipanti e sostenitori. Niente di simile oggi, ripeto, o niente che possa costituirne immediatamente l’equivalente.
La politica della sinistra, pur pretendendo di fare riferimento a principi democratici, socialisti, comunisti, ecologisti carichi di significato, appare sempre fondamentalmente difensiva: difensiva di fronte alle politiche “neoliberali” di distruzione dei diritti e delle relative tutele del lavoro, difensiva di fronte alla privatizzazione diretta o indiretta dei servizi pubblici o al loro smantellamento, difensiva di fronte alla commercializzazione della cultura, difensiva di fronte alle forme “atipiche” di crisi economica inerenti al capitalismo finanziario, difensiva di fronte alla globalizzazione quanto di fronte alle reazioni populiste e nazionaliste che essa suscita. Difensiva soprattutto di fronte alle “catastrofi” che offuscano l’orizzonte del cambiamento: dalla catastrofe ambientale alla rivoluzione informatica, passando per il ritorno della guerra. Perché ciascuno di essi la rinchiude in dilemmi di cui non ha trovato la chiave, come la decrescita e la riduzione delle disuguaglianze, generando al suo interno conflitti di interessi e di principi che ostacolano il progetto e privano dell’unità di azione una base storica che la politica cercherà poi di tradurre e consolidare. Di per sé un nome non cambierà nulla, a meno che non evochi potenzialità della situazione ancora inosservate, che devono essere portate alla luce.
Spingendo così all’estremo lo scetticismo, cerco di designare il compito che deve ora affrontare un’unione delle forze di sinistra per dare vita al “fronte popolare” di cui si sente portatrice e la cui necessità è apparsa come un imperativo di salute pubblica. Ora questo compito ha due aspetti distinti, ma che riguardano un’unica pratica o azione politica collettiva: dobbiamo ribaltare la posizione ideologica difensiva in una posizione offensiva, fatta non solo di riflessi repubblicani o di risposte al pericolo, ma di veri e propri progetti credibili che liberano una “potenza di agire” che sia la potenza stessa del comune, riorganizzando da cima a fondo il regime delle paure e delle speranze della moltitudine. E, dall’altro lato, dobbiamo trovare il “popolo” ancora virtuale che si approprierà di questi progetti, inventerà il linguaggio con cui possa discutere dei suoi interessi comuni e soprattutto dei suoi disaccordi, uscendo “dall’alto” dagli antagonismi ereditati dalla sua storia o dai litigi suscitati dall’attualità. Perché è solo attraverso l’elaborazione dei “disaccordi” che lo separano da sé, approfondendo le ragioni del loro peggioramento, che il popolo “che manca”, costituito da masse eterogenee e estranee tra loro, ritroverà la sua unità e la sua identità politica. Il popolo del fronte “popolare” non è dato, in un certo senso possiamo dire che non esiste, che esso è “a venire”.
[1]Penso in particolare al fuoco di sbarramento del tipo “Blum si starà rivoltando nella tomba” di Manuel Valls, Bernard Cazeneuve e altri, a cui il pronipote di Léon Blum, Antoine Malamoud, ha risposto con rigore e dignità su Mediapart: https://blogs.mediapart.fr/amd92/blog/110624/bernard-cazeneuve-accapare-leon-blum
(Traduzione di Roberto Ciccarelli)
*Ringraziamo Etienne Balibar e il sito Aoc Media per la gentile concessione editoriale per la traduzione
L’articolo è stato originariamente pubblicato in francese, in due parti, qui e qui.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento