Il mondo sognato da James Bond
Geografie letterarie L’indagine di Kathryn Harkup, scrittrice e ricercatrice, per Codice edizioni. Una scienziata con la passione per 007 analizza i contorni del personaggio più noto della spy story. Più che le «diavolerie» tecnologiche emerge l’uomo oltre la maschera dell’agente segreto. Come già nelle opere di le Carré, Graham Greene e William Somerset Maugham
 Formazione degli addetti dell’artiglieria navale della Royal Navy vicino a Portsmouth, Hampshire, 1942 – Getty Images
Formazione degli addetti dell’artiglieria navale della Royal Navy vicino a Portsmouth, Hampshire, 1942 – Getty ImagesGeografie letterarie L’indagine di Kathryn Harkup, scrittrice e ricercatrice, per Codice edizioni. Una scienziata con la passione per 007 analizza i contorni del personaggio più noto della spy story. Più che le «diavolerie» tecnologiche emerge l’uomo oltre la maschera dell’agente segreto. Come già nelle opere di le Carré, Graham Greene e William Somerset Maugham
Forse non è un caso che per l’ultimo romanzo pubblicato in vita, un altro sarebbe uscito solo postumo, John le Carré avesse scelto di tornare in qualche modo ad indagare nell’ambiente stesso dell’intelligence britannica: il contesto cui si era ispirato per il debutto della sua lunga carriera letteraria e che aveva fatto da sfondo alle azioni dei suoi celebri personaggi, su tutti George Smiley, l’ufficiale dell’MI6 e vice-capo del «Circus», come lo scrittore ribattezzò lo spionaggio locale, collocandone la sede nel Cambridge Circus di Londra.
IN «LA SPIA CORRE sul campo» (Mondadori, 2019), uscito l’anno precedente la scomparsa dell’autore ottantanovenne – in seguito vedrà la luce anche L’ultimo segreto (Mondadori, 2022), in cui le Carré, tenacemente ostile alla Brexit, tornava a riflettere su quale debito si possa pensare di aver contratto nei confronti di un Paese nel quale non ci si riconosce più – non compare la figura di Smiley, al centro di un fortunato ciclo di romanzi editi soprattutto intorno alla metà degli anni Settanta, ma Nat, un funzionario di mezza età, già agente reclutatore nell’Europa orientale, che vede avvicinarsi l’agognata pensione.
Non sarà così, e il personaggio finirà suo malgrado ad occuparsi di un vecchio rifugio londinese nel quale venivano accolti quanti disertavano dallo spionaggio della Cortina di ferro. Nat non la prenderà bene e inizierà a riflettere sul modo in cui il suo lavoro è stato scarsamente considerato dai superiori, in un ambiente spesso dominato dalle lotte e dagli intrighi di potere. Tema cui si aggiungerà, in virtù delle vicende famigliari del protagonista – rivelare o meno alla figlia quale sia stato fino a quel momento il suo «vero» incarico -, un interrogativo destinato a diventare centrale nella storia e che può essere sintetizzato in quale sia la vera identità di chi, per missione, ne deve avere più d’una. O forse nessuna percepita fino in fondo come propria.
CERTO, IL CONTESTO internazionale nel quale opera l’agente segreto è ancora più torbido e incerto di quello della Guerra fredda. Basti pensare che a misurarsi sulla scena globale sono per molti versi due facce della stessa medaglia come Trump e Putin, mentre Londra ha scelto in modo sconsiderato di allontanarsi dall’Europa. Ma i quesiti che catturano la mente di Nat hanno più a che fare con la propria traiettoria personale, nel difficile tentativo di tracciare un confine sensibile, o almeno probabile, tra l’uomo e la spia. Un’incertezza che tradisce al tempo stesso dei sani dubbi per chi è abituato a rispondere senza fiatare agli ordini ricevuti e un senso di feconda inadeguatezza quanto alle proprie qualità di essere umano, che traspare in molte opere di le Carré.

Lo stesso scrittore, che quando nel 1961 aveva scritto il suo primo romanzo, Chiamata per il morto, era ancora in forza al Secret intelligence service, si dibatteva del resto nell’incertezza intorno ad un altro possibile dualismo: «Provavo rabbia perché mi era chiaro che, dal giorno della pubblicazione de La spia che venne dal freddo (il romanzo che nel 1963 lo consacrò definitivamente nell’ambito letterario, nda) sarei stato marchiato per sempre come la spia diventata scrittore e non come lo scrittore che, non diversamente da tanti altri, aveva lavorato per un certo periodo nei Servizi segreti e si era messo a scrivere sull’argomento».
L’enigma che divide l’uomo dalla spia o se si vuole, come in questo caso, lo scrittore dall’agente segreto – le Carré vantava dei validi antecedenti in Graham Greene e William Somerset Maugham, passati per l’intelligence di Sua Maestà Britannica prima di dedicarsi alle lettere, come fece anche Ian Fleming, il creatore di James Bond che fu ingaggiato dai servizi della Royal Navy durante la Seconda guerra mondiale -, resta perciò un tema in qualche modo ineludibile della spy story.
Al punto che anche una delle più recenti serie tv, Una spia tra noi (in Italia è disponibile su Sky) ricostruisce in questa chiave la vicenda, reale, di Kim Philby, che per circa trent’anni, dal ’36 al ’63, lavorò per lo spionaggio dell’Urss all’interno degli apparati di sicurezza britannici prima di rifugiarsi a Mosca. Tratta dal romanzo di Ben Macintyre A Spy among Friends (Bloomsbury, 2014), la serie indaga proprio i contorni della personalità di Philby e quanto di lui conoscevano davvero le persone che aveva intorno, i suoi famigliari come il suo migliore amico nell’intelligence britannica che dovrà indagare sul suo caso. Alla vicenda di Philby si sono già ispirati, tra gli altri, Graham Greene (Il fattore umano, 1978), Frederick Forsyth (Il quarto protocollo, 1984), oltre allo stesso le Carré (La talpa, 1975).
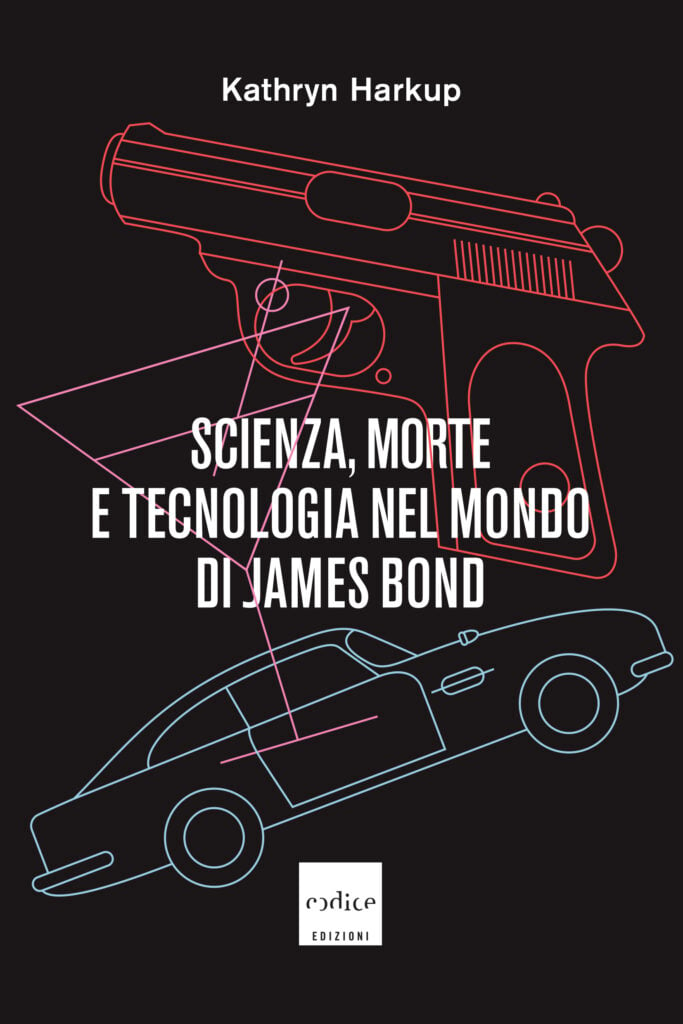
Il presupposto della godibile ricerca è infatti che malgrado il mondo di Bond sia «una fantasia piena di megalomani esagerati, buchi nella trama così grossi che ci passerebbe la superpetroliera di Stromberg e automobili talmente accessoriate che dovrebbero essere inguidabili», tuttavia, «senza riferimenti alla vita reale, senza dettagli autentici, si ridurrebbe a un’assurda parodia di se stesso». Se si stima che il personaggio creato da Ian Fleming nel 1953, protagonista di dodici romanzi e di due raccolte di racconti, ma portato diverse decine di volte sullo schermo e impersonato da una mezza dozzina di attori, anche se con esiti talmente diversi ad essere difficilmente comparabili, sia stato seguito al cinema da circa un quarto della popolazione mondiale, mentre i lettori si attesterebbero intorno ai cento milioni, il libro di Harkup ha il merito di sfilare la maschera alla spia più nota di sempre.

La tesi della studiosa è che alla base della popolarità di James Bond vi sia una sorta di estensione folle, e per certi versi «visionaria» dei ritrovati tecnologici e scientifici di cui l’umanità, in quello stesso periodo, vale a dire a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, cominciava ad avere qualche nozione. Si tratti di armi, laser, automobili o mezzi subacquei, ritrovati della medicina o della meccanica, Ian Fleming, e poi quanti ne adatteranno le storie al grande schermo, proiettavano la propria fantasia verso il futuro senza dimenticare il proprio punto di partenza.
Ma, alla fine del libro, consapevoli che le intuizioni della celebre spia erano solo in parte frutto di un’invidiabile creatività, resta ancora una volta l’uomo. Tra «esplosioni spettacolari, inseguimenti mozzafiato, auto veloci, belle donne e grandi criminali che minacciano il mondo intero», malgrado la patina a prima vista indistruttibile, l’«eroe» che si staglia all’orizzonte o si appoggia con esibita nonchalance su di una Aston Martin DB5, come quella che appare in Missione Goldfinger e che fu rubata al termine delle riprese nel 1964 per essere ritrovata vent’anni più tardi, è solo. E niente ci è dato sapere della sua vera identità. Ancora una volta, sarà l’uomo o la spia a guardarci negli occhi dalla macchina da presa?
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento




