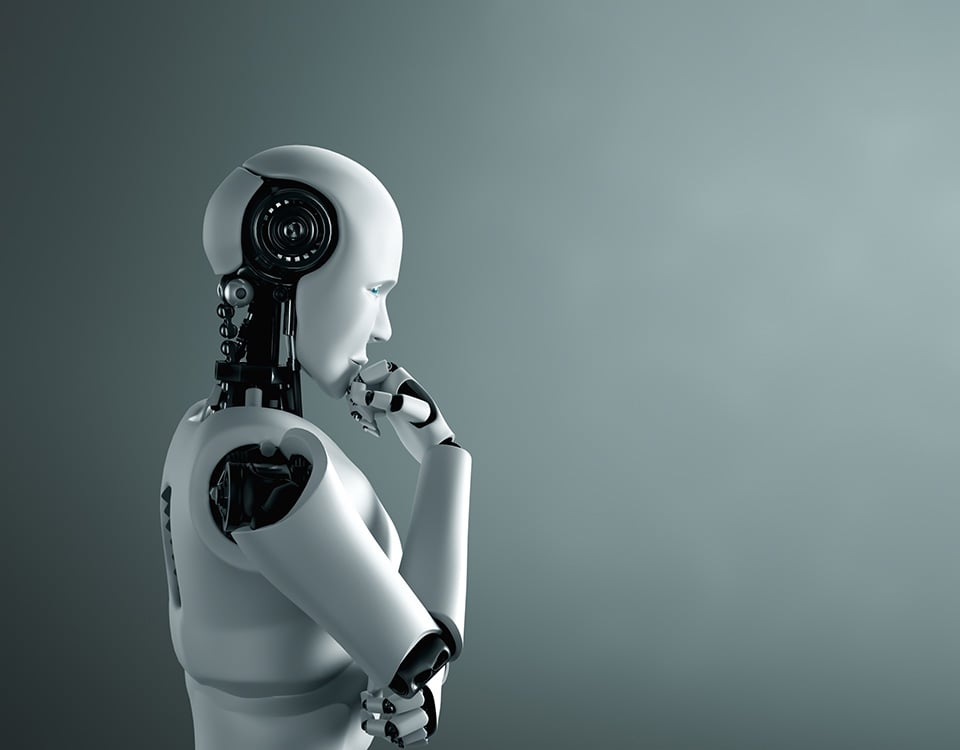Il lavoro umano cambia, il pensiero della sinistra arranca
Welfare digitale «Gli individui spensierati di domani sono necessari per creare la ragion d’essere di quelli seri e ponderati di oggi», così Keynes spiega che si risparmia per investire

Welfare digitale «Gli individui spensierati di domani sono necessari per creare la ragion d’essere di quelli seri e ponderati di oggi», così Keynes spiega che si risparmia per investire
Quella che propongo non è una sinistra spensierata, ma una sinistra finalmente pensosa, capace di darsi pensiero delle difficoltà che l’umanità attraversa oggi e, ragionando, analizzando, di trovare le soluzioni, che devono essere diverse perché diverso è il mondo.
Ammiro Roberta De Monticelli, e proprio per questo vedere trattata la mia proposta di un welfare digitale come una freddura mi è un po’ spiaciuto. Non scherzavo affatto. Roberta incarna l’ala nobile della sinistra, attenta ai princìpi e ai diritti, necessaria e indispensabile, ma purtroppo facile da ghigliottinare con un tweet contro i migranti.
All’altro polo c’è un’ala complottista che parla di sfruttamento e di alienazione come frutto di manovre del Kapitale, con una protesta che è stata capitalizzata dalla destra. In mezzo, c’è un terzo stato volenteroso, quello che abbiamo letto negli articoli sul primo maggio, in cui si denunciava la scomparsa del lavoro, solo che si pensava al lavoro novecentesco.
Ai complottisti del Kapitale dico semplicemente che una cosa del genere non esiste, e che il capitale siamo tutti noi, in quanto parte di un mondo sociale più complesso e interrelato di quanto non lo si pensasse ai tempi di Marx. Agli aristocratici dei diritti umani dico che occuparsi del reale è il solo modo per tutelare i diritti.
Al terzo stato preoccupato del lavoro dico che il problema è proprio quello del lavoro, solo che il lavoro non è scomparso, ma è cambiato in un modo radicale, ed è proprio questa radicalità che ora manca nella comprensione del presente.
Visto che si sta parlando del welfare del futuro, conviene partire dal welfare del passato. La semplice intuizione di Keynes, che sta alla base del welfare del Novecento e che ha permesso alle sinistre di socializzare il plusvalore del capitale industriale è stato il considerare il risparmio e l’investimento come i due volti di una stessa realtà.
Se guardi al capitale come a una totalità, bisogna superare la credenza moralistica per cui chi mette i soldi in banca è premiato perché risparmia. Non è così: è premiato perché rende disponibile dei soldi che saranno investiti, sostenendo nel lungo termine dei consumi che costituiscono il fine ultimo di ogni produzione di beni. E l’investimento costituisce la via regia per ottenere ciò che – in epoca di automazione ancora imperfetta – costituiva l’obiettivo fondamentale del welfare, il raggiungimento del pieno impiego. E perché ciò avvenga scrive Keynes, “gli individui spensierati di domani sono assolutamente necessari per creare la ragion d’essere di quelli seri e ponderati di oggi”. Quanto dire che si risparmia oggi solo per spendere domani, e un risparmio senza spesa non ha senso.
Che cosa è necessario per il welfare digitale? Certo non le demonizzazioni per cui Silicon Valley sarebbe un covo di pirati, ma qualcosa che la Cina sta capendo molto bene, anche se lo sta attuando a modo suo, cioè con poca attenzione ai diritti civili e alle libertà individuali.
L’idea è molto semplice. L’automazione crescente e ben più perfetta rispetto ai tempi del welfare industriale ha prodotto una disgiunzione concettuale su cui non si è ancora riflettuto: il lavoro umano non è più sinonimo di produzione, perché questa è assicurata in modo crescente dalle macchine – e nella produzione l’intelligenza artificiale, chiamata a eseguire ordini, funziona meglio di qualunque agente umano, proprio come un braccio meccanico fa canestro con molto più successo di qualunque campione.
Nessun umano, però, sarebbe disposto a guardare una partita di basket tra bracci meccanici. E costruire dei robot spettatori non ha alcun senso. Proprio qui, dunque, diviene indispensabile l’apporto umano, che, come ricordavo nel pezzo del 19 aprile, è chiamato a dar significato condiviso a una attività in sé insensata, e può farlo perché costituisce il fine ultimo di tutto il processo.
Proprio qui si nasconde l’intuizione di fondo del welfare digitale. Nel momento in cui il lavoro non coincide più con la produzione, è necessario stabilire a livello macroeconomico che il consumo è il vero lavoro, proprio come negli anni trenta del secolo scorso il new deal si è basato sul fatto che l’investimento è il vero risparmio. I consumatori sono assolutamente necessari per creare la ragion d’essere di quegli individui seri, ponderati e noiosi che sono le macchine, e l’obiettivo del welfare, la piena occupazione, si ottiene molto meglio con il consumo, che riguarda tutti, che non con la produzione, che riguarda una minoranza sempre più esigua.
Ciò non era possibile un tempo, quando il consumo non lasciava tracce e non generava conoscenza. Oggi invece l’enorme potenza di archivio e di calcolo delle reti informatiche che rende in linea di principio possibile l’automazione perfetta è anche ciò che permette di raccogliere le informazioni di uso e di comportamento che derivano dalla nostra mobilitazione.
Ai giganti del web non importano i nostri segreti, ma sapere che cosa compriamo, che cosa guardiamo, che cosa crediamo. E importa che ci sia una umanità capace di consumare, costituendo il motore immobile di tutto il processo. Dunque, questa enorme produzione di valore è il vero capitale umano su cui si fonda il welfare digitale, e che va pagato dai giganti digitali.
Per far sì che lo paghino, però, è necessario pensiero, altro che spensieratezza. Il pensiero che consiste nel riconoscere il consumo come lavoro. Roberta sosteneva che questo mondo di consumatori le ricorda un Brave New World, ma vorrei ricordare che anche Auschwitz è una fabbrica, con probi lavoratori e una morale produttiva impeccabile e novecentesca, purtroppo devoluta allo sterminio.
Campi e officine non sono di per sé nobili, lo sono solo se producono la fioritura umana, e, inversamente, il consumo non è l’equivalente di una felicità forzata e idiota, ma costituisce il vero obiettivo di una umanità che si riconosca come portatrice di bisogni, di desideri, e dunque di fini, ossia di ciò che nessun automa potrà mai avere.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento