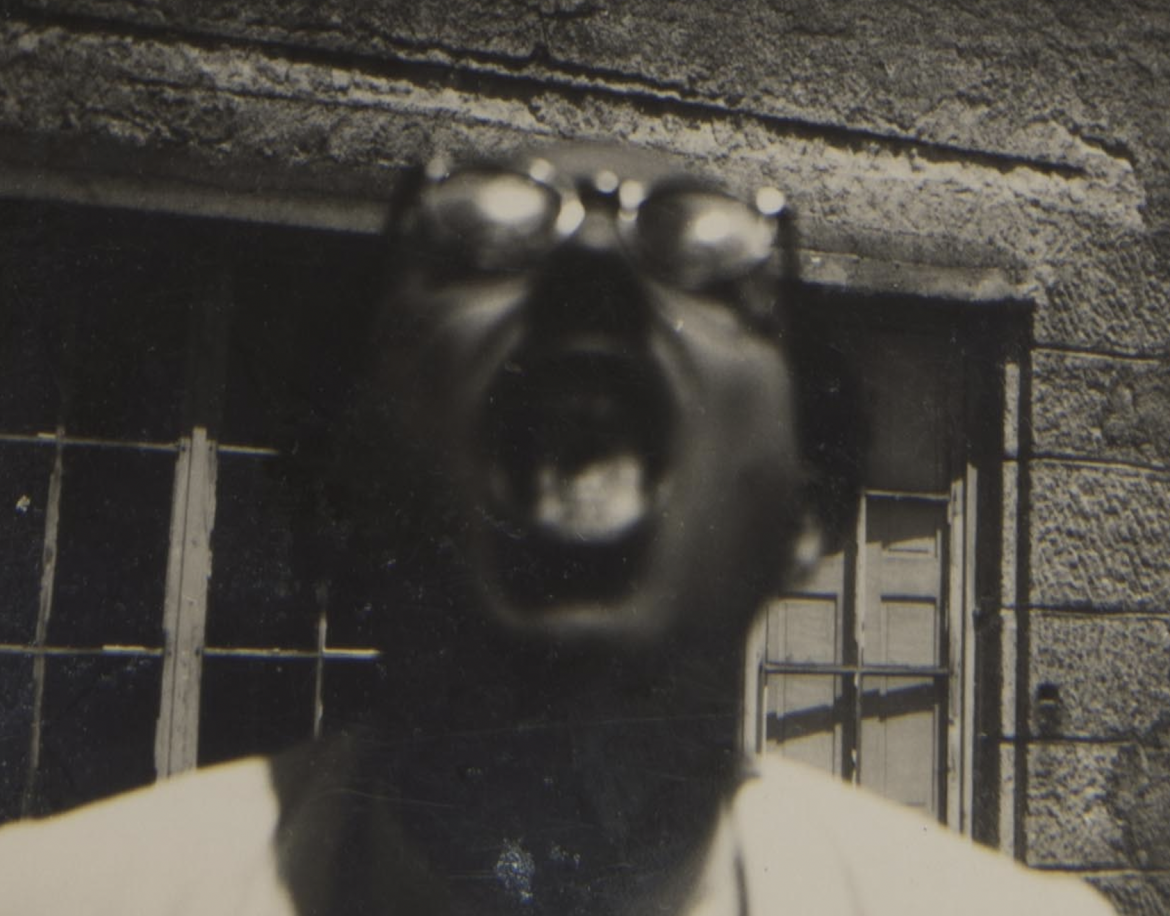
Francesc Tosquelles, la psichiatria fra il dire e le dita
Il motivo per cui la mostra Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo debba ritenersi l’evento immancabile del calendario madrileno di quest’inverno agli sgoccioli va ricercato innanzitutto nella proficua meditazione che ha portato alla sua genesi, un cantiere in grado di coinvolgere attori diversi e istituzioni disparate.
Concepito a partire da una proposta curiosa (il video-saggio di Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato, Déconnage, proiettato nel 2012 al Museu d’Art Contemporani di Barcellona), il progetto ha subito infatti una lunga decantazione, nell’analisi condotta da un gruppo universitario costituito ad hoc (sotto alla guida di Joana Masó) e grazie alle idee di Carles Guerra, figura eminente nel panorama curatoriale catalano: attraverso un iter tanto ricco, la retrospettiva ha potuto contare, oltre che sui contributi dell’agile catalogo coedito dal Centre de Cultura Contemporània e dal Reina Sofía, sull’uscita tempestiva di un volume apparso in autunno, biografia ‘canonica’ che dello psichiatra al centro del percorso, Francesc Tosquelles (1912-’94), della sua parabola fra Spagna e Francia, fra Guerra Civile, Vichy e tardofranchismo, offre un résumé densissimo, sostenuto da una scelta acuta di testi e interviste offerti ‘in silloge’ al lettore.
Tale profondità d’esame si legge, non certo in filigrana, nel percorso allestito al Reina Sofía fino al 27 marzo, al terzo piano dell’edificio Sabatini, con materiali eterogenei, video, sequenze di film, opere innumerevoli, fra dipinti, disegni e sculture: non mancano nemmeno creazioni odierne a punteggiare con ritmo efficace, sottolineando l’attualità di quanto esposto nelle molte sale, necessariamente dedicate all’evento.
La figura di Tosquelles, invero, vi svetta per le capacità di profetico aggiornamento, ma pure per la brillante autonomia di pensiero, per l’abitudine di rivestire le proprie conclusioni in una rete di jeux de mots, nutrite entrambe nel contatto con certe istanze avanguardiste: pertanto, se nel circolo virtuoso di un’arte che torna all’arte l’accoglienza concessa dal Reina Sofía appare affatto consona all’incubazione della mostra, non meno coerente risulta l’ospitalità nel white cube nosocomiale dell’istituzione madrilena per i convincimenti anti-accademici, per le simpatie anti-estetiche espresse con continuità dal medico spagnolo, lungo un’esistenza prolifica e produttiva.
È indiscutibile infatti – i curatori lo evidenziano con sagacia – quanto lo stesso ragionamento di Tosquelles abbia incontrato un humus fertile nell’innesto rivoluzionario di comunismo e freudianesimo eseguito dai Surrealisti sin dagli anni venti: la sua formazione trascorse, non a caso, fra le esperienze politiche di estrema sinistra ambientatesi nel clima della Seconda Repubblica (in particolare nell’adesione al Bloc Obrer i Camperol o al Partit Obrer d’Unificació Marxista), e gli incontri con Dalí presso l’Ateneu Barcelonès.
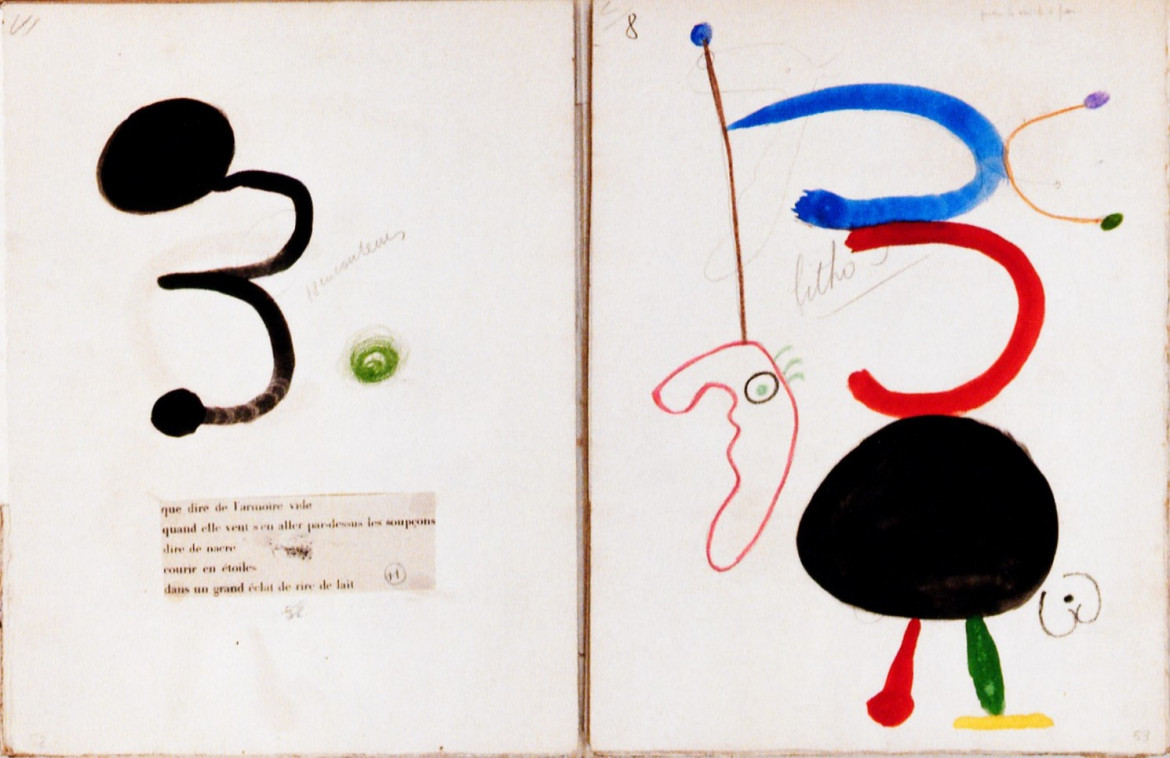
Il racconto di questa conoscenza, assieme al dichiarato apprezzamento per il pittore, raccontano bene la peculiare prospettiva sulla vita e sulla professione che Tosquelles era andato immaginandosi nel clima della capitale catalana, specchio delle riforme promosse dall’Esquerra Republicana e dal Frente Popolar, divenuta una «piccola Vienna» del metodo analitico per l’immigrazione di tutta un’intelligencija germanofona in fuga dal nazismo. Il medico ha, a più riprese, elogiato la declinazione peculiare del credo bretoniano offerta da Dalí col sistema paranoico-critico – «tomaba en cuenta lo real… la vida no es soñar» – ma ha anche descritto come, sin dal primo sguardo, il suo universo e quello dell’artista avessero cozzato, provocando le scintille che generano di solito gli impatti improvvisi fra personalità distinte, ben salde: «Non avevo terminato ancora i miei studi di medicina… Dalí mi guardò con il suo peculiare disprezzo: Saresti psichiatra? E con che si mangia, con il cucchiaio o con la forchetta? Gli risposi che si mangia con le dita… perché ‘dits’, in catalano sono le dita, ma anche il ‘dire’. Risposi insomma che la psichiatria si mangia con le dita e con il ‘dire’, con ciò che è stato detto. Se non abbiamo niente nelle mani, non abbiamo niente nella testa. Si tratta di avere una mano nella testa».
Questa replica, solo all’apparenza paradossale, è il programma sintetico di quanto Tosquelles, pagando l’adesione al fronte repubblicano negli anni cruenti del colpo di stato, avrebbe sperimentato in Francia, lungo una vita d’esilio inevitabile, dapprima col lavoro emergenziale nei campi per profughi di guerra e poi nella clinica di Saint-Alban, villaggio occitano distante dal confine, nella cui équipe sarebbe stato accolto per invito del direttore, Paul Balvet, all’inizio degli anni quaranta. In questa struttura, avrebbe messo a frutto esperienze vissute negli ospedali catalani più aggiornati, dall’Institut Pere Mata al Centre La Sageta; avrebbe però avuto anche modo di coniugare la pratica cooperativa legata alla militanza politica (appena quindicenne, aveva scritto una lettera a Stalin, lamentando le derive del centralismo sovietico!) con la rivoluzione epistemologica di Jacques Lacan, del cui pensiero fu apostolo fervente e sollecito.
Nacque dunque a Saint-Alban, sotto l’impulso di un intellettuale avvezzo a un ricco plurilinguismo, quella che negli anni cinquanta sarebbe stata definita «psicoterapia istituzionale»: al di là delle etichette accademiche, l’insegnamento di Tosquelles si fondò su un’azione «aperta», intesa per far vivere alla comunità dei pazienti e dei sanitari un’ergonomia rivolta al mondo e alle esperienze circostanti, attraverso l’adattabilità dell’istituzione alle esigenze dei suoi membri «vivi». I risultati ottenuti vennero prontamente consegnati a video e documentari, prodotti dentro e fuori il cineclub avviato nella clinica: tuttavia non è nemmeno questa relazione moderna con le immagini a giustificare appieno l’esposizione del Reina Sofía, a determinarne l’urgenza critica.
Oltre i molti contatti con l’intellettualità francese accostati grazie alle entrature di uno dei medici impiegati a Saint-Alban, e cioè Lucien Bonnafé (vi passarono Eluard e Tzara, Georges Sadoul e Georges Canguilhem, senza dimenticare le presenze eccentriche di Guattari e Frantz Fanon), è soprattutto il rapporto con le esperienze di Dubuffet che traccia una linea d’investigazione ben chiara nell’appuntamento di Madrid, utile a delineare le convinzioni di Tosquelles e il suo legame con una concezione precisa del fare artistico.
Se da un lato infatti alcuni residenti nella struttura furono protagonisti delle iniziative curatoriali e collezionistiche promosse nel secondo dopoguerra dal padre dell’art brut, dall’altro lo stesso Tosquelles si dimostrò resistente a organizzare una raccolta dell’ospedale o a fornire dettagli clinici circa i profili dei singoli artisti in via d’affermazione, come ad esempio Auguste Forestier. Ben contento che le opere realizzate a Saint-Alban divenissero fonti di guadagno, ridistribuiva nondimeno gli introiti fra ciascun autore e la comunità dell’ospedale, facendo fronte alle esigenze di tutti i pazienti: convinto insomma che quelle testimonianze, prima che manifesti estetici, fossero una parte importante di precisi percorsi individuali, ne rivendicava il valore terapeutico sul metro dell’esistenza invece che su quello del successo.
«È importante che quest’arte si converta in ‘merce’… però si deve andar ben oltre il semplice esibizionismo per incontrare l’altro», sosteneva il dottore, ironizzando quasi su un’etichetta cara a quegli anni per descrivere il solipsistico rovello dell’Informale…
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento



