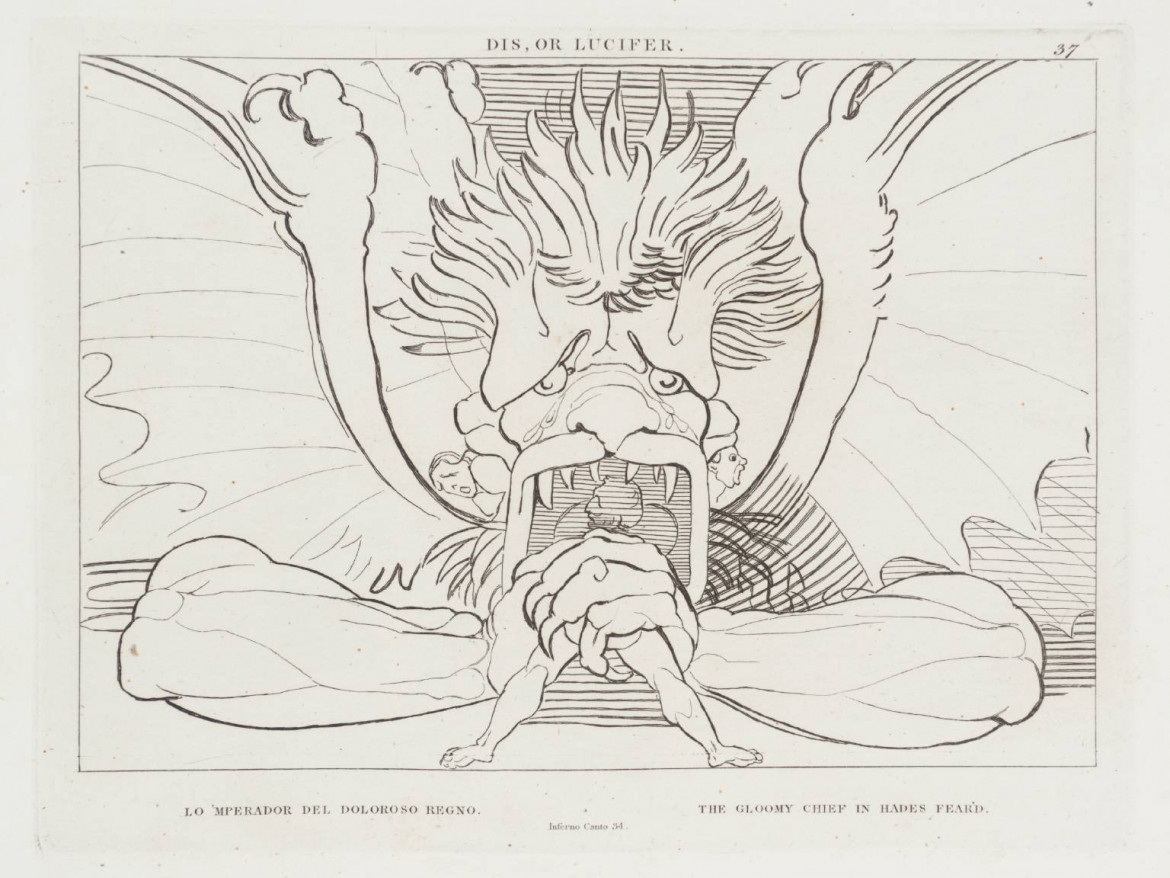Filologia quotidiana di due dantisti
Carteggio 1895-1922 Corse in tipografia, correzioni di bozze, acquisti e scambi di libri... Pesi massimi a Firenze tra studî e insegnamento: Ernesto G. Parodi e Michele Barbi
 Biblioteca Laurenziana a Firenze, Tribuna D’Elci, cupola a lacunari, XIX secolo
Biblioteca Laurenziana a Firenze, Tribuna D’Elci, cupola a lacunari, XIX secoloCarteggio 1895-1922 Corse in tipografia, correzioni di bozze, acquisti e scambi di libri... Pesi massimi a Firenze tra studî e insegnamento: Ernesto G. Parodi e Michele Barbi
A leggerlo così, tutto d’un fiato, torna un po’ alla mente il Dialogo tra Primo Levi e Tullio Regge. E in fin dei conti, stando all’aforisma di Giuseppe Billanovich – che la filologia, cioè, è la scienza umanistica più prossima alla fisica – l’accostamento non sembrerà troppo ardito: in questo imponente carteggio tra Parodi e Barbi (Il carteggio Michele Barbi-Ernesto Giacomo Parodi (1895-1922) Personalità, studi e problemi verso la «Nuova Filologia», a cura di Paola Siano, Biblion, pp. 920, € 40,00), i due pesi massimi della filologia che dal tardo Ottocento scollinava, sicura e ridente, verso il nuovo secolo, inducono a richiamare quel Dialogo la piena consapevolezza di una superiorità intellettuale e la sottintesa appartenenza a una élite cui pochi, pochissimi in Italia e in Europa potevano iscriversi. Tra questi (non senza distinguo) alcuni maestri della generazione precedente: Gaston Paris, l’Ascoli, Adolfo Mussafia e Pio Rajna, quasi un piccolo pantheon.
Si configura, questo carteggio, come un dialogo inter pares nel quale prevalgono, è bene dirlo per non alimentare curiosità da rotocalco accademico, argomenti di ordinaria amministrazione bibliografica. Barbi, di qualche anno più giovane di Parodi, diresse il glorioso Bullettino della Società Dantesca Italiana dal 1893 al 1905; nel 1906 subentrò Parodi che ne tenne le redini fino alla sua morte (1923), giusto in tempo per veder sorgere la nuova e vincente rivista degli Studi Danteschi, manco a dirlo, diretta da Barbi. La corrispondenza ruota dunque attorno a corse in tipografia e correzioni di bozze, scambi o acquisti di volumi e saggi («mandami, ti prego» – così Barbi a Parodi nell’estate del 1905 – «anche il Fanfulla della Domenica del 30 luglio e del 6 agosto … intendo dire che tu li compri per mio conto, dal tabaccaio di Via Martelli, prima che s’esauriscano»), solleciti agli amici perché onorassero le consegne, fossero articoli o recensioni; il tutto sempre o quasi per il tramite delle immancabili cartoline postali (che a quei tempi cavalcavano la penisola da nord a sud in un paio di giorni). Barbi era uscito dalla scuola del D’Ancona e, poi, del Rajna ma non aveva tardato a tracciare un suo proprio percorso di crescita, impiantato su filologia ed erudizione alimentate dalla quotidiana frequentazione di archivi e biblioteche fiorentine, cioè di documenti e manoscritti (e dunque di storia e di lingua). Non era apoditticamente lachmanniano però, Barbi; reso omaggio ai maestri tedeschi, amava sempre dire che ogni problema filologico richiede una soluzione sua propria, ogni autore un approccio specifico, secondo quel procedere che condurrà, nel 1938 alla mirabile raccolta della Nuova filologia. Il suo modello era il priore fiorentino Vincenzio Borghini, che nel Cinquecento aveva avviato lo studio dei testi e della lingua antica secondo una metodologia che sorprende ancora oggi.
Questa sorta di formazione permanente fu resa possibile grazie a prolungati periodi di studio, lontano da pastoie e impegni accademici: «Oggi – confessava un giorno a voce a Luigi Russo, tardo discepolo putativo a Firenze e autore della commemorazione funebre – compio i miei venticinque anni, non so dire di insegnamento o di non insegnamento». E in effetti Barbi aveva potuto studiare indisturbato per lunghi periodi, prima come bibliotecario a Firenze (1893-1900), poi comandato alla Crusca (1913-’23), mentre fu sempre insofferente nei riguardi della docenza universitaria: dal 1900 al 1912 nell’esilio di Messina (di fatto, a causa del disastroso terremoto, fino al 1908), oggetto di frequenti sfoghi epistolari tanto da indurlo a cedere il timone del Bullettino («poi ch’io ho da star quaggiù, abbiano altri le delizie che m’invidiano» e «sento che non è più cosa per me; né è cosa che si possa far di quaggiù», così in lettere a Parodi del 1905); dal 1923 a Firenze, a Magistero, e nemmeno in questo caso nascose la propria avversione («Che, che, che!!! Con tutte quelle donnette! Non c’è sugo», annota ancora il Russo). Più netto e lineare il percorso di Parodi, che lasciò Genova dopo la laurea e corse a perfezionarsi a Firenze, dove seguì i corsi di Vitelli, Comparetti, Bartoli e Rajna. A trent’anni era già incaricato, a Firenze, dell’insegnamento di Storia comparata di lingue classiche e neolatine, e già a quella altezza la sua preparazione linguistica e filologica temeva pochi confronti.
I rispettivi percorsi di formazione segnano, anche nel carteggio, ruoli abbastanza definiti, con Parodi chiamato a fornire non di rado consulenze di carattere glottologico o linguistico (esemplare la richiesta ossessivamente ripetuta e mai esaudita di una perizia sulla lingua del Fiore – questione apertissima dopo l’attribuzione a Dante di Guido Mazzoni e l’adesione presto intiepiditasi del Barbi stesso). Dal canto suo, Barbi si mostrava più forte sul versante della documentazione archivistica e sulla conoscenza delle tradizioni testuali, ma non rinunciava a dire la sua anche sul fiorentino antico, forte della conoscenza diretta di testi e documenti, condensata in centinaia e centinaia di schede. Ecco, il carteggio corre lungo questi binari e configura una sorta di filtro a maglie fittissime per valutare, accogliere, criticare o stroncare i mille contributi di ogni genere e provenienza che alimentavano la vita quotidiana del Bullettino. L’occhiuta censura linguistico-filologica dei due dioscuri non riusciva gradita a tutti. A farne le spese fu anche il Pascoli i cui lavori (Minerva oscura, Sotto il velame) caddero sotto la scure impietosa di Parodi. Il poeta professore – che sedeva sulla cattedra già del Carducci – non tardò a prendersi la rivincita allorché, dopo i primi positivi abboccamenti per un approdo bolognese di Barbi (era stato suo collega a Messina), riesumò gli sgarbi pregressi («la stupida e velenosa infamia di quel menomo Parodi», si sfogava con Luigi Pietrobono), mostrandosi di giorno in giorno più ostile a quella soluzione fino a minacciare le proprie dimissioni (ricostruisce tutto con puntualità Paola Siano).
È uno dei pochi guizzi del carteggio, perché Barbi – più di Parodi – era studioso laconico, di una freddezza in cui non pochi intravvedevano tratti di non sempre limpidissima superbia. Ma proprio la consapevolezza di tale superiorità, questo rinchiudersi nella torre d’avorio di una filologia tagliente come una lama – così ebbe a definirla Carlo Dionisotti – gli impedì forse di riconoscere gli altrui meriti. È quanto emerge dal paternalistico giudizio nei confronti di Rajna, reo di avere affrontato «problemi poco complicati, anzi relativamente semplici» (ma i contributi di Rajna sulla tradizione testuale della Vita nuova forniscono una patente smentita: sorprende vederne del tutto ignorati i meriti nei prolegomena all’edizione Barbi del prosimetro del 1907). Ed è quanto emerge dal silenzio riservato nei suoi mirabili Studi sul canzoniere di Dante (1915) ai Nuovi studi sulla Giuntina di rime antiche di Santorre Debendetti (1912). Una «canagliata meschina e di basso fetore» come la bollò ancora Dionisotti nella sua corrispondenza privata. Curiosamente proprio Debenedetti, uno dei pochissimi (benché dieci anni più giovane) a poter guardare dritto negli occhi Barbi grazie alla propria institutio filologica, è sostanzialmente assente nella corrispondenza con Parodi. A Dionisotti faceva forse velo la censura politica, l’essersi fatto seppellire, Barbi, in camicia nera (altro aneddoto oracolare di Billanovich). Ma forse questa reticenza sdegnosa è solo un’ulteriore sfumatura di quell’impegno filologico integrale ed esclusivo che non si poneva interrogativi eteronomi, non ammetteva distrazioni e non tollerava concorrenti.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento