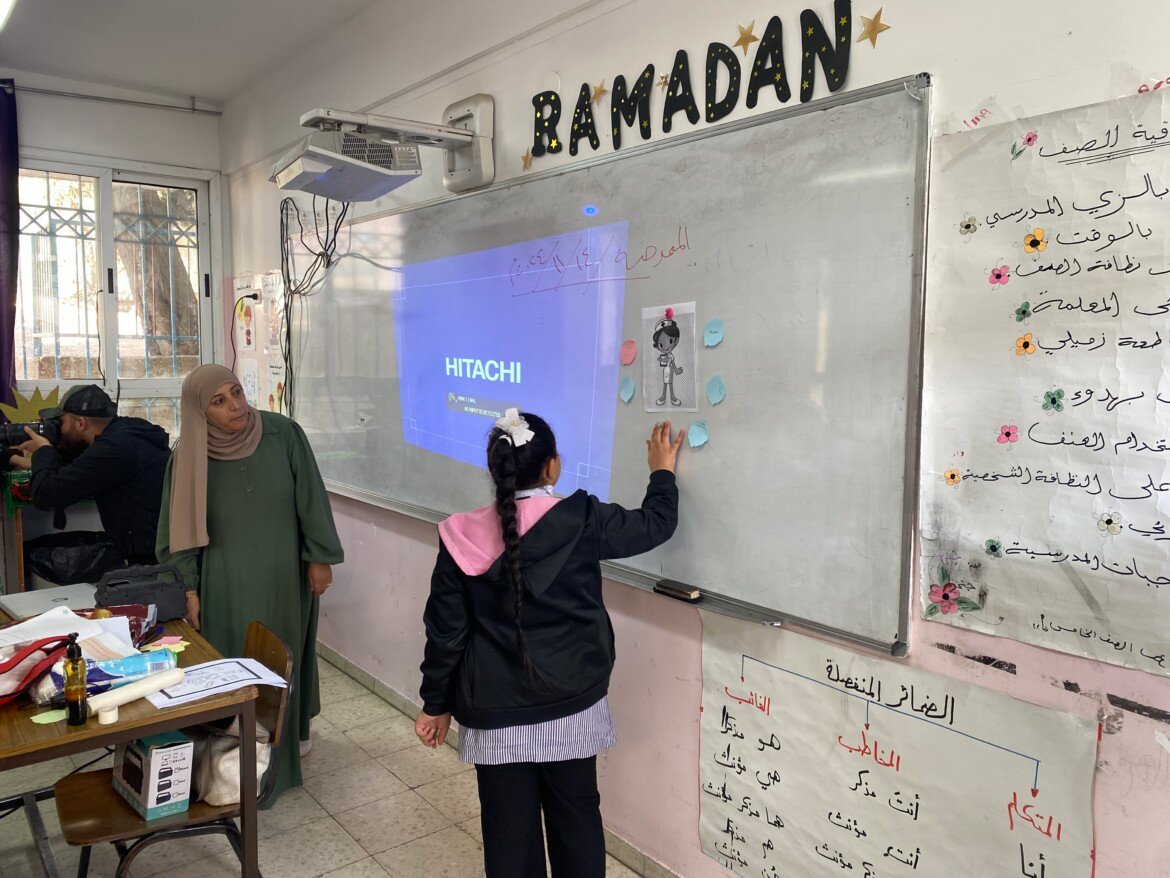Edward Said, preludi alla trappola di Gaza
Saggi Datati più di vent’anni e drammaticamente attuali, gli scritti del critico letterario hanno sullo sfondo la crisi degli accordi di Oslo, cui fu, dall’inizio, contrario: «La pace possibile», Il Saggiatore
 Dal cortometraggio «In the Future They Ate From the Finest Porcelain» di Søren Lind e Larissa Sansour, 2015
Dal cortometraggio «In the Future They Ate From the Finest Porcelain» di Søren Lind e Larissa Sansour, 2015Saggi Datati più di vent’anni e drammaticamente attuali, gli scritti del critico letterario hanno sullo sfondo la crisi degli accordi di Oslo, cui fu, dall’inizio, contrario: «La pace possibile», Il Saggiatore
«Gaza è circondata su tre lati da un recinto di filo metallico percorso dalla corrente elettrica; imprigionati come animali, gli abitanti si trovano nell’impossibilità di muoversi, di lavorare, di vendere la verdura e la frutta che coltivano, di andare a scuola. Sono esposti agli attacchi dal cielo degli aerei e degli elicotteri israeliani, e a terra vengono abbattuti come tacchini dai carri armati e dalle mitragliatrici. Affamata e misera, Gaza umanamente è un incubo, fatto […] di migliaia di soldati impegnati nell’umiliazione, nella punizione e nell’intollerabile indebolimento di ogni palestinese, a prescindere dall’età, dal sesso e dallo stato di salute. Le forniture mediche vengono trattenute al confine, sulle ambulanze si spara oppure si fa in modo che perdano tempo. Vengono demolite centinaia di case e terreni agricoli e centinaia di migliaia di alberi vengono distrutti in nome della punizione collettiva sistematica con cui si intendono colpire i civili, in gran parte profughi in seguito alla distruzione della loro società nel 1948».
Queste parole sembrano scritte ieri, ma portano la data dell’agosto 2002. Il loro autore, il teorico della letteratura e critico culturale Edward Said, è morto vent’anni fa. Sono moltissimi, in questi mesi in cui si sta consumando la tragedia di Gaza, a sentire la mancanza della sua voce autorevole, indomita e sempre scomoda alle orecchie del potere. Uscito da poco dal Saggiatore, La Pace possibile Riflessioni critiche e prospettive sui rapporti israelo-palestinesi (traduzione di Antonietta Torchiana, prefazione di Tony Judt, pp. 348, € 24,00) raccoglie un insieme di testi scritti poco prima della sua scomparsa, ma non ha perduto nulla della sua attualità. A distanza di vent’anni, le sue parole premonitrici risuonano anzi con. più forza. Destinati ai quotidiani arabi «Al-Ahram» e «Al-Hayat», pubblicati al Cairo e Londra, questi articoli analizzano il contesto della seconda Intifada in Palestina, dell’11 settembre e delle guerre che ne sono seguite in Afganistan e in Iraq. Lo sfondo è la crisi degli accordi di Oslo, che avrebbero dovuto portare alla pace ma hanno soltanto preparato il terreno per la distruzione della Palestina oggi sotto i nostri occhi. Said è stato uno dei primi (e dei pochi) a denunciarli come una trappola per i palestinesi e a indicare le conseguenze catastrofiche che ne sarebbero discese.
La diagnosi contenuta in questi testi è lucidissima. Said sottolinea innanzi tutto l’assenza, per non dire l’impossibilità di un dialogo: nel 1948 i palestinesi sono stati «depredati e sradicati», mentre Israele proclama di aver conquistato la sua indipendenza; i palestinesi sono stati privati della loro terra, mentre Israele afferma di essersi riappropriato di una terra che appartiene agli ebrei per decreto biblico; i palestinesi hanno subito decenni di occupazione, privazione di diritti, umiliazione e violenza sistematica, ma Israele ritiene di agire in nome di un popolo di vittime. Tutti i grandi media occidentali hanno aderito senza riserve alla narrazione sionista che sfrontatamente strumentalizza la storia degli uni e ignora o nega quella degli altri. In Europa e negli Stati Uniti, osserva Said, Israele non è mai trattato come uno stato ma piuttosto come «un’idea, una sorta di talismano» interiorizzato al fine di legittimare i peggiori soprusi in nome di alti princìpi morali. Decenni di occupazione militare, vessazioni e violenza appaiono così come l’autodifesa di uno stato minacciato e la resistenza palestinese una manifestazione di odio antisemita.
Reinterpretata in chiave orientalista, la storia ebraica si snoda come un lungo martirio in attesa di un meritato riscatto e i palestinesi diventano un popolo senza storia. Perfettamente integrato nel mondo occidentale, del quale gli ebrei sono stati per secoli i paria e le vittime, Israele ne adotta il linguaggio e i pregiudizi razziali, trasferendoli ora sui palestinesi. Nei mesi scorsi, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato che a Gaza Israele sta combattendo contro degli «animali umani». Questa retorica non è nuova; i suoi predecessori avevano già definito i palestinesi degli «scarafaggi» (Rafael Eytan) o «un cancro nel corpo ebraico» (Yitzhak Rabin). Chi ha un minimo di familiarità con la storia dell’antisemitismo non avrà difficoltà a rintracciare la matrice di questa retorica.
Said ha sempre denunciato il terrorismo palestinese come una forma di lotta illegittima sul piano morale, dannosa e controproducente sul piano politico. Israele ne fa il pretesto per giustificare la sua violenza incomparabilmente più mortifera, l’Occidente per rinchiudersi nella sua ipocrisia. I grandi media occidentali ripetono come pappagalli la versione della guerra fornita dalla propaganda israeliana. Nel 2002, Said descriveva i giornalisti americani come «mentitori consumati (che) creano falsità con tanta naturalezza da sembrare capaci di tutto». Spesso la sua prosa è costellata di pungente ironia. I media non possono evocare il nome di Hamas senza ricordarne la «barbarie» e sottolinearne il fanatismo religioso, incompatibile con i valori dell’Occidente, ma il «New York Times» ci informa con la consueta prosa compassata che, in base a un sondaggio, l’86% degli americani si considerano «un popolo amato da dio», un dio che per molti fondamentalisti cristiani si esprimeva attraverso la bocca di George W. Bush (e oggi di Donald Trump).
Lo sfondo dei testi raccolti in questo volume è il fallimento degli accordi di Oslo, ai quali Said si oppose fin dall’inizio dimettendosi dal Consiglio nazionale palestinese. Lungi dal gettare le basi per una pace durevole fondata sulla coesistenza di due stati sovrani, essi furono immediatamente sabotati da Israele, diventando la premessa per colonizzare la Cisgiordania, annettere Gerusalemme est e isolare un’autorità palestinese corrotta e discreditata. Il fallimento degli accordi di Oslo segna il tramonto del progetto di due stati. Questa prospettiva – vagheggiata ancora oggi da europei e americani – significa in sostanza uno o due Banstustan palestinesi sotto controllo militare israeliano. L’ipotesi di due stati è diventata impossibile, benché nelle circostanze della seconda Intifada – come oggi della guerra genocida a Gaza – uno stato binazionale sia difficilmente immaginabile. Said pensava che uno stato laico binazionale – una repubblica democratica capace di garantire ai suoi cittadini ebrei e palestinesi una completa uguaglianza di diritti – fosse l’unica via possibile per la pace. Questo è il significato dello slogan oggi scandito da milioni di manifestanti nel mondo (tra i quali moltissimi giovani ebrei): «From the river to the sea, Palestine will be free».
I media occidentali, tuttavia, si ostinano ipocritamente a considerarlo uno slogan antisemita. Questa accusa, osserva Said, è abbastanza paradossale. Molti politici americani, soprattutto democratici, ai quali l’idea di fare degli Stati Uniti uno stato bianco e cristiano apparirebbe insensata e razzista, sono i più tenaci difensori di Israele, uno stato costruito su basi etnico-religiose.
In base alla «legge del ritorno», Israele è pronto ad accogliere gli ebrei della diaspora ma proibisce il ritorno ai palestinesi espulsi nel 1948, espropriati delle loro terre e delle loro case; è uno stato democratico per i suoi cittadini ma una dittatura militare per i palestinesi dei territori occupati, dove vivono privati di ogni diritto. L’obiettivo ultimo, scrive Said, è sempre più stato quello di schiacciarli e renderli invisibili. In fondo, questo obiettivo era tacitamente condiviso da tutti, dagli Stati Uniti, dall’Unione europea e perfino dai paesi arabi, che si apprestavano a firmare accordi di pace ignorando i palestinesi. Il 7 ottobre ci ha ricordato tuttavia che non sono scomparsi ed è forse per questo che la guerra israeliana mira alla distruzione totale di Gaza, ossia a una nuova pulizia etnica, a una nuova Nakba.
Vent’anni fa, al tempo della seconda Intifada, Said si chiedeva con preoccupazione: «dove sono gli equivalenti israeliani di Nadine Gordimer, Andre Brink, Athol Fugard, degli scrittori bianchi che in Sudafrica si espressero in maniera inequivocabile e senza ambiguità contro i mali dell’apartheid»?
Questo silenzio è oggi altrettanto assordante, rotto da poche voci isolate. Ma la situazione è profondamente cambiata. Israele si è rivelato vulnerabile e soprattutto, attraverso la sua furia distruttrice, privo di ogni legittimità morale. La causa palestinese è diventata una bandiera del Sud globale e di gran parte dell’opinione pubblica, soprattutto dei giovani, sia in Europa che negli Stati Uniti. Per questo la voce di Edward Said risuona con tanta forza a vent’anni di distanza.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento