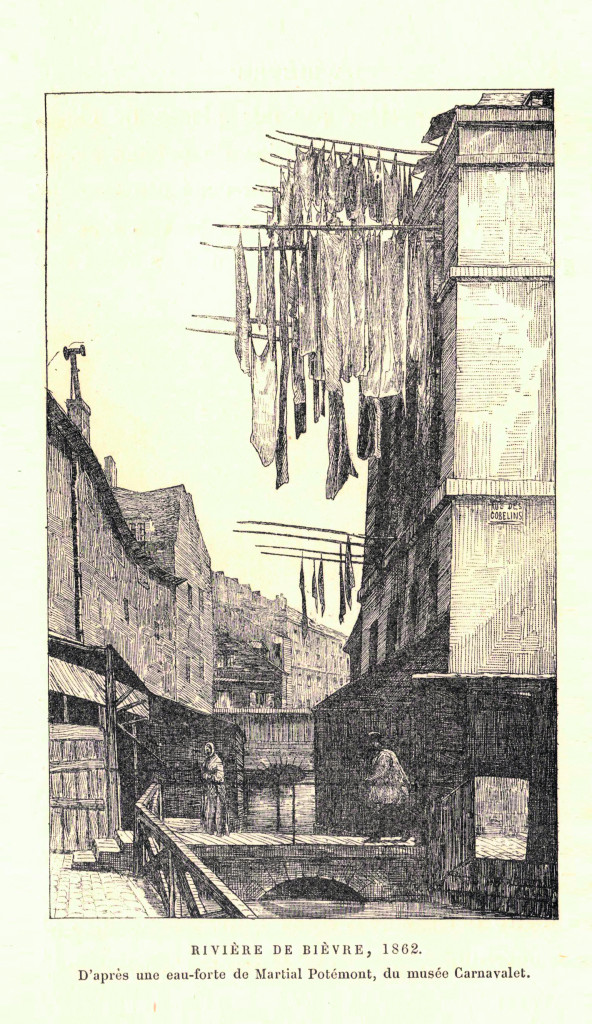Édouard Louis: «Il corpo di mio padre riflette una società classista»
Intervista Lo scrittore racconta il suo percorso, alla Milanesiana porterà in scena il suo romanzo autobiografico con la regia di Ostermaier
 Édouard Louis in «Qui a tué mon père» al Théâtre de la Ville di Parigi – foto di Jean-Louis Fernandez
Édouard Louis in «Qui a tué mon père» al Théâtre de la Ville di Parigi – foto di Jean-Louis FernandezIntervista Lo scrittore racconta il suo percorso, alla Milanesiana porterà in scena il suo romanzo autobiografico con la regia di Ostermaier
«Per me l’autobiografia è un’arma politica». Un’arma che Édouard Louis a 29 anni ha già affilato in quattro libri che attingono alla sua vita di giovane omosessuale cresciuto nell’intolleranza di una famiglia operaia poverissima della Piccardia più profonda, e che porta in scena col suo stesso corpo nello spettacolo teatrale Chi ha ucciso mio padre. Tratto dal suo romanzo del 2018 e diretto da Thomas Ostermeier, il monologo stasera è al teatro Franco Parenti di Milano per la Milanesiana. Lo scrittore francese sarà ospite anche domani del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che con La nave di Teseo ha appena pubblicato una conversazione tra lui e Ken Loach, Dialogo sull’arte e la politica.
Ero un ragazzino gay isolato, a dodici anni ho provato il teatro. Tutti mi hanno guardato, applaudito, per la prima volta nella mia vita mi sono sentito amato Édouard Louis
Tutto il suo lavoro verte sull’autobiografia.
L’autobiografia è disturbante, produce un confronto. È molto più difficile sfuggire a un testo che si sa che è autobiografico, perché mentre lo leggi sul divano sai che quella vita è accaduta realmente, non puoi aggrapparti a un salvagente dicendo «ma sì, è solo un personaggio». L’autobiografia è politica perché urta le persone, le mette a disagio. È una forma avanguardista, ultracontemporanea. Può davvero trasformare l’arte.

Oggi si parla tanto di autofinzione. Cosa ne pensa?
È una vigliaccheria, è fare dell’autobiografia senza andare fino in fondo. C’è sempre un po’ di finzione così la gente si può sentire rassicurata. Quando presento i miei libri a volte ho l’impressione che mi supplichino perché dica che c’è della finzione, per potersi sentire un po’ meno a disagio. L’autobiografia produce panico.
Sul palco se ne fa carico anche come attore.
Ostermeier per me è uno dei più grandi registi al mondo. Quando mi ha proposto di adattare Chi ha ucciso mio padre e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto fossi io a recitarlo, l’ho visto come un modo magnifico di continuare a sperimentare, di aggiungere una dimensione in più alla lotta che porto avanti. La letteratura e il teatro in passato avevano la missione di far conoscere delle realtà che non si conoscevano, penso a Zola, Simone de Beauvoir, Sartre, a Pasolini con Ragazzi di vita. Oggi con la circolazione delle informazioni, internet e i social abbiamo accesso al mondo, lo possiamo vedere. Sappiamo che ogni giorno gli uomini uccidono le donne, che il mondo è classista, razzista, che esiste la povertà, l’omofobia. Il mondo è più visibile, e il ruolo della letteratura è cambiato.
La redazione consiglia:
Storia di padri e figli, felicità e dolore nel ritrovarsiIn che modo?
Non deve insegnarci qualcosa, ma forzarci a vedere qualcosa che conosciamo già, ma non vogliamo vedere. Non è più l’impegno, l’artista engagé, ma l’artista che si confronta con delle realtà disturbanti.
Avete discusso di questo con Ken Loach?
L’avevo incontrato qualche anno fa a Londra, ci avevano invitato per una conversazione che ho adorato. Ci siamo detti di farne un piccolo libro, un manifesto sull’arte e la politica. Crediamo che se si vuole che l’arte trasformi le cose dobbiamo reinventare il modo in cui si pensa e si approccia l’arte. Ci vuole una responsabilità degli artisti non solo nel creare, ma nel manifestare nelle piazze, nell’esprimersi sui media, nell’andare nelle scuole. Bisogna essere coscienti che non tutti hanno accesso all’arte, e chiedersi: che cosa posso fare di più? Ken ad esempio fa delle proiezioni nei pub. Altrimenti non ti batti per la classe operaia, sei un bugiardo. Entrambi vogliamo rappresentare le classi popolari, con onestà. Il suo film Io, Daniel Blake mi ha influenzato molto nello scrivere la storia di mio padre.
Racconti.
Quand’ero piccolo non capivo la differenza tra destra e sinistra, ma mi ricordo che Sarkozy ha fatto una riforma dei sostegni sociali. Il sussidio era basso, ma da quel momento per averlo bisognava provare di stare cercando lavoro. La stessa situazione del film di Loach, dove un uomo malato è costretto a cercare lavoro finché ne muore. Mio padre aveva avuto un incidente in fabbrica, la sua schiena si era spezzata e aveva dovuto smettere di lavorare. A un tratto l’amministrazione mandava a casa dei controlli, lo chiamava al telefono e lo minacciava di togliergli il sussidio. Così mio padre, nonostante stesse male, ha dovuto accettare un lavoro da spazzino. Io già allora pensavo: o lo uccidono costringendolo a lavorare, o lo uccidono tagliandogli il sussidio. Le decisioni politiche di governi, presidenti e ministri poco a poco hanno distrutto il corpo di mio padre. Il suo corpo è il riflesso del suo posto nella società, di una vita in fabbrica, di povertà.
L’arte può cambiare le cose?
Sì e no. A volte è sconfortante, vedi gente che si commuove per un film di Loach e poi vota per la destra radicale o neoliberista che produce quelle situazioni. Ma succede anche che delle opere d’arte trasformino degli individui: quante donne hanno letto Simone de Beauvoir e hanno trasformato il loro rapporto col mondo? Nella mia storia personale, il teatro ha un posto particolare. A scuola ero un ragazzino gay, visto come effeminato dagli altri che non volevano farsi vedere insieme a un «frocio». Così io partecipavo a tutti i club, calligrafia, fumetto, scacchi, anche se li detestavo, per essere accettato. A dodici anni, ho provato con il teatro. Mi hanno chiesto di fare un’improvvisazione. Tutti mi hanno ascoltato, guardato, applaudito, per la prima volta nella mia vita mi sono sentito amato. Poi ho passato l’audizione per il liceo teatrale e la traiettoria della mia vita è cambiata radicalmente. Sono stato il primo della mia famiglia a continuare gli studi, a leggere dei libri. Non perché amassi il teatro, solo perché volevo essere amato.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento