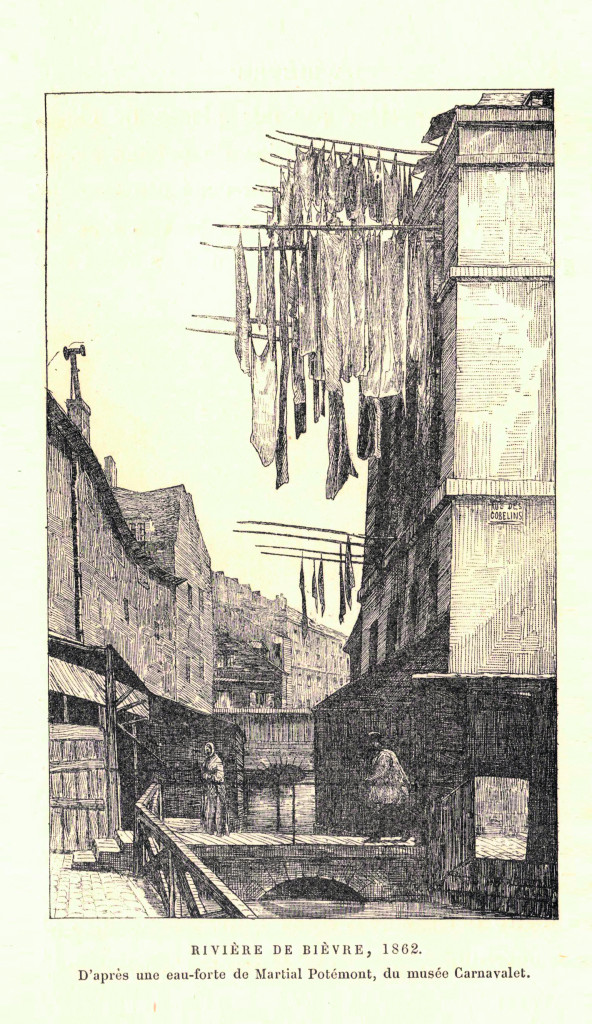Boileau-Narcejac, il re delle lampadine è cieco, alle sue spalle losche trame
Novecento francese Una interessante variazione sui canoni del ‘giallo’ e del noir prevede che siano i sensi ‘minori’, svalutati dalla tradizione fondata sulla equazione fra vista e ragione, a mettere il protagonista sulla strada della verità: «I volti dell’ombra», da Adelphi
 Pierre Boileau e Thomas Narcejac sulla spiaggia, foto di Jean-Claude Deutsch per «Paris Match» (via Getty Images)
Pierre Boileau e Thomas Narcejac sulla spiaggia, foto di Jean-Claude Deutsch per «Paris Match» (via Getty Images)Novecento francese Una interessante variazione sui canoni del ‘giallo’ e del noir prevede che siano i sensi ‘minori’, svalutati dalla tradizione fondata sulla equazione fra vista e ragione, a mettere il protagonista sulla strada della verità: «I volti dell’ombra», da Adelphi
Una precisa descrizione delle costanti formali che accomunano tutti (o quasi) i romanzi del nuovo millennio entrati nella cinquina del più noto premio letterario nazionale è leggibile in uno dei più significativi saggi della recente critica letteraria italiana, Caccia allo Strega di Gianluigi Simonetti (Nottetempo): in estrema sintesi, propiziano il successo (senza perciò garantirlo) un abile dosaggio di intrattenimento e impegno, il compromesso fra leggibilità e letterarietà e la predisposizione genetica all’intermedialità (un libro di cassetta deve poter diventare film, serie, podcast, ecc.). Anche se non necessariamente individua un fenomeno nuovo, la diagnosi è esatta. Da quando la letteratura è entrata nell’era dei media – cioè all’incirca dagli anni Trenta dell’Ottocento, con la nascita del romanzo d’appendice –, sono queste, grosso modo, le caratteristiche dei libri middlebrow, in precario equilibrio fra l’elitario ascetismo dei prodotti d’avanguardia e i facili stereotipi di quelli di consumo.
Negli anni Cinquanta del Novecento, mentre il dibattito culturale francese ‘alto’ ruotava intorno all’estremismo sperimentale del nouveau roman (le cui opere sono oggi in larga misura scomparse, sciaguratamente, dai cataloghi dei grandi editori italiani), la prolifica coppia Boileau-Narcejac incarnava una letteratura che certamente era di genere (Pierre Boileau e Thomas Narcejac si erano anche singolarmente illustrati nel ‘giallo’ e nel noir) ma era anche ambiziosa, capace di aspirare ai crismi della letterarietà, senza riservare al lettore sorprese troppo inquietanti o ostacoli troppo ardui. Non è un caso se, col senno dei posteri, possiamo dire che il massimo contributo dei due abili scrittori francesi alla cultura occidentale consiste nell’avere offerto a Alfred Hitchcock il canovaccio di uno dei suoi assoluti capolavori: Vertigo, in italiano La donna che visse due volte (1958), che sposta da Parigi a San Francisco la vicenda di D’entre les morts (1954). Ancora meno casuale è il fatto che, oggi, un editore raffinato come Adelphi, dopo avere pubblicato nel 2016 il libro più importante (appunto con il titolo cinematografico: La donna che visse due volte), e prima ancora Celle qui n’était plus (di nuovo con il titolo del film, realizzato da Henri-Georges Clouzot nel 1955: I diabolici), e Les Magiciennes (Le incantatrici, a sua volta portato sul grande schermo nel 1960 dal meno blasonato Serge Friedman), ora mandi in libreria, di Boileau e Narcejac, I volti dell’ombra, del 1953 (nella scorrevole traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio (pp. 192, € 18,00).
Se questo romanzo, letterariamente uno dei più riusciti dei due autori, non ha avuto una seconda vita sul grande schermo, è per ragioni squisitamente tecniche, e più precisamente narratologiche: l’intera vicenda è raccontata (sia pure in terza persona) dalla prospettiva di un cieco, dunque la dimensione visiva è di necessità obliterata.
Il protagonista, Hermantier, imprenditore di successo nel ramo delle lampadine elettriche, con velleità da inventore e inclinazioni alla speculazione e alla pubblicità megalomane, è rimasto ferito dall’esplosione accidentale di un ordigno bellico nel giardino della sua villa in Vandea. All’inizio del libro, è convalescente a Lione e assiste impotente allo sgretolarsi della sua autorità, un tempo indiscussa e temuta. La bella moglie, Christiane, lo accudisce con finta premura; il fratello Maxime, viveur dalla salute compromessa, gli spilla denaro con impudenza; il socio in affari, Hubert Merville, finge di assecondare i suoi azzardi, mentre agisce con gretta prudenza per salvaguardare i propri capitali. Il cieco firma documenti e assegni, sulla fiducia; ma sempre più spesso è assalito dai sospetti. Fin dalle prime pagine, infatti, si accumulano gli indizi – in particolare, il licenziamento di una fedele cameriera – di un complotto ai suoi danni; ma il grosso del romanzo riferisce di una villeggiatura estiva: al malato, che vorrebbe rimanere a Lione per dirigere i suoi affari, i familiari impongono un lungo soggiorno nella villa in Vandea, che diventa così lo scenario claustrofobico in cui si muovono pochi personaggi sommariamente tratteggiati.
Christiane è algida e impenetrabile, «una creatura avida e paurosa, per nulla sensuale»: nei confronti del marito, di origini popolari, prova in realtà un malcelato disprezzo di classe; Maxime è scapestrato e amorale, in modi a tratti gioiosi, a tratti sinistri; Hubert è un meschino calcolatore, che s’ingozza di caramelline alla liquirizia – il cui odore, stomachevole per il protagonista, avrà un ruolo importante nella trama indiziaria. Il ricorso agli stereotipi, ai topoi e ai suggerimenti della memoria letteraria è sobrio ma frequente: per dirne una, il rapporto fra i coniugi Hermantier ricorda per molti versi quello fra Hennebeau, il direttore della miniera, e la moglie fredda e infedele, in Germinal di Zola.
Non ci sono, in tutto il romanzo, pagine davvero memorabili. Eppure la descrizione del doloroso adattamento del volitivo e prepotente Hermantier a una condizione minorata è senz’altro efficace; il racconto del suo frustrante apprendistato sensoriale, nel buio della cecità e nella rabbia impotente della solitudine, ha una sua tragica (a tratti tragicomica) grandezza; soprattutto, non si smentisce la capacità degli autori di costruire progressivamente, quasi insensibilmente, ma con ineluttabile puntualità, un’atmosfera tesa e perturbante, in cui l’orrore del tradimento e il timore del crimine si fanno strada a poco a poco nella mente del protagonista (l’unica cui il lettore abbia accesso), per poi manifestarsi in piena evidenza in una scena cimiteriale tanto più impressionante per un lettore italiano, in quanto offre (consapevolmente?) una variazione con rincaro di quella celebre del Fu Mattia Pascal di Pirandello. Sulla tomba di Maxime, la confusione fra vivo e morto suggella definitivamente, per Hermantier, il crollo di ogni umana fiducia.
Sono il caldo soffocante (sull’Atlantico?), l’odore di pino che raggiunge la villa a intense folate (in Vandea?), l’incongruità di troppi dettagli materiali, nella casa, nel giardino, perfino negli abiti di Hermantier, a suscitare pagina dopo pagina quel senso spaventoso di perduta familiarità che Freud ha descritto nel saggio sull’Unheimliche. L’udito, il tatto e soprattutto l’olfatto del cieco si acutizzano, restituendo alla sua intelligenza, tanto vivace quanto rozza, una intermittente perspicacia da detective. Grazie a una variazione di sicuro interesse, rispetto ai canoni del ‘giallo’ e del noir tradizionali, sono i sensi ‘minori’ – quelli svalutati dalla tradizione occidentale, fondata sull’equazione fra ragione e vista –, a mettere Hermantier sulla strada di una verità peraltro assai prevedibile. Non sarà pertanto da imputare al recensore, credo, il peccato (capitale) di spoiler: chiunque avrà capito che Christiane è l’amante del pur poco attraente (ma solido, e senza scrupoli) Hubert.
In fondo al libro, non c’è lieto fine; ma nemmeno narrazione del crimine. Il lettore si ritrova (casualmente?) proprio dalle parti di Miragno, e può chiudere con soddisfazione un rispettabile e ingegnoso prodotto artigianale, capace di garantire, direbbe Simonetti, qualche ora di «nobile intrattenimento».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento