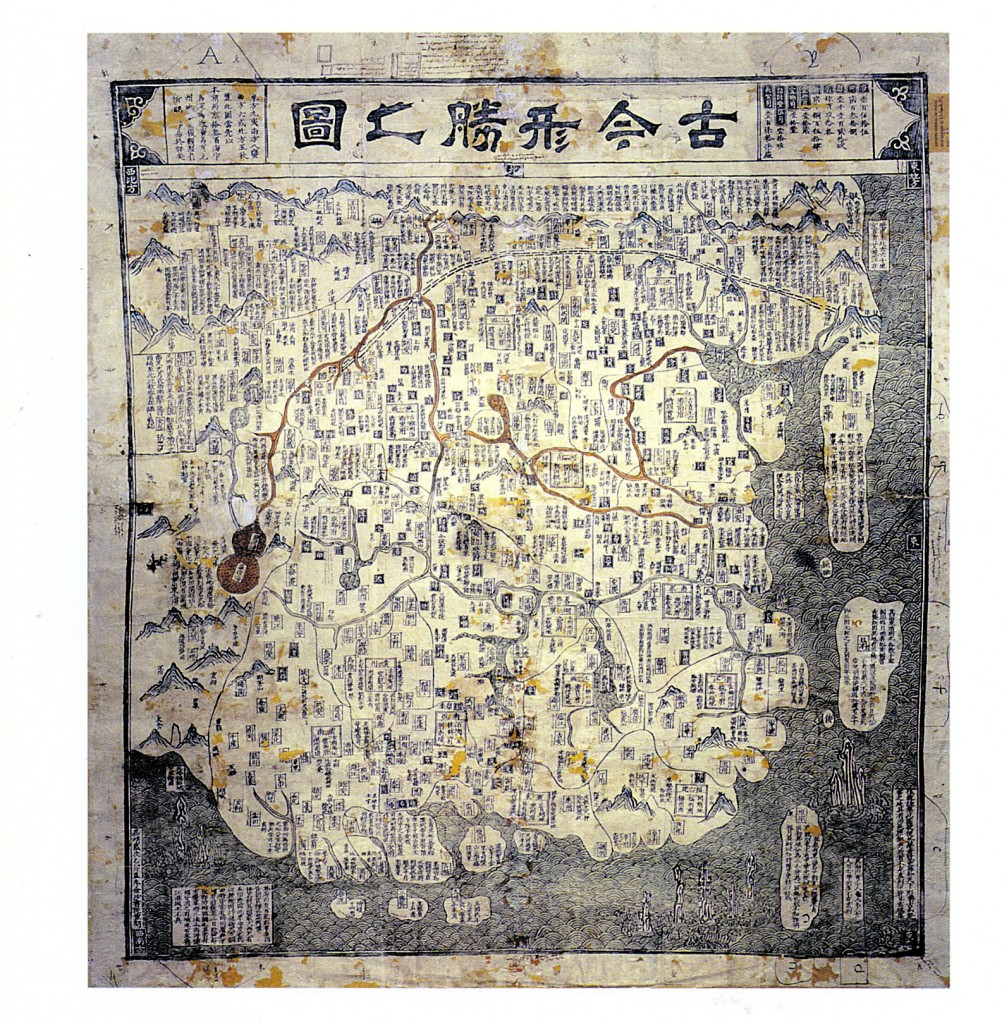Basta con i polpettoni è ora di «Sogno cinese»
Cina Il trionfo di «In the name of people», serie concentrata sulla lotta di Xi Jinping alla corruzione, segna un cambiamento epocale nell’industria tv di Pechino

Cina Il trionfo di «In the name of people», serie concentrata sulla lotta di Xi Jinping alla corruzione, segna un cambiamento epocale nell’industria tv di Pechino
Trecentocinquanta milioni di spettatori soltanto durante l’episodio pilota, 313mila menzioni sul Twitter cinese Sina Weibo e 120 milioni di yuan sborsati in fase di produzione. Sono i numeri sfavillanti di Renmin de mingyi («In the Name of the People»), la serie televisiva cinese più acclamata del 2017, trasmessa a marzo dalla televisione dello Hunan e rilanciata sulle piattaforme online Youku, iQiyi e Mango TV.
L’unica fiction ad aver ottenuto uno share sopra al 10%. Il segreto del suo successo? Avere come filo conduttore la lotta contro la corruzione inaugurata dal presidente Xi Jinping appena assunto l’incarico di Segretario generale del Partito cinque anni fa.
Ribattezzata per ovvie ragioni l’«House of Cards» cinese, la serie sposta volutamente i riflettori dal malaffare che appesta la nomeklatura comunista agli sforzi fruttuosi messi in campo dalle autorità di vigilanza per imbrigliare «le mosche e le tigri»; ovvero i corrotti alla base e al vertice della gerarchia comunista. Il tutto condito da sketch tanto parossistici quanto verosimili: montagne di rossastre banconote da 100 yuan spuntano dagli armadi, dal frigorifero, dalla trapunta di un letto.
Sono tante da far inceppare i contatori automatici della polizia. La mente corre a uno dei casi di cronaca più eclatanti degli ultimi anni, quando – data la mole del bottino – di contatori ne servirono ben sedici. Il confine che separa la fiction dalla realtà è impercettibile, e tutta la serie sembra spingersi al limite del lecito in un gioco di rimandi da mandare nel pallone i censori. Il nome di Xi Jinping si nasconde nelle sillabe finale dei nomi dei tre protagonisti senza macchia in un accostamento più nobile rispetto al rebus oltraggioso che nella commedia in costume L’Impero Qin 3 ha visto rubricare gli alti papaveri tra i traditori della patria in un furbesco gioco di parole cassato senza pietà dai revisori. Nata dalla cooperazione tra il TV and Film Production Center e il
Procuratorato supremo del popolo, Renmin de mingyi non è il primo prodotto televisivo a rimestare nel torbido mondo della politica cinese. La serie arriva a circa un anno dalla proiezione sul piccolo schermo del documentario in otto puntate Yongyuan Zai Lu Shang («Always on the Road») e a soli pochi mesi da uno show televisivo realizzato dalla statale CCTV in tandem con la Commissione centrale per l’Ispezione della Disciplina, l’organo responsabile della Mani pulite in salsa cinese. Secondo la stampa ufficiale, nel 2016, la Commissione si è trovata a visionare ben 11 programmi TV sulla corruzione.
Si tratta del revival di un genere che, nonostante il diffuso disinteresse dei cinesi per la politica, sopravvive a fasi alterne da circa vent’anni. Ovvero, da quando nel 1995 Cangtian Zaishang («Heaven Above») ottenne il semaforo verde del Dipartimento centrale di propaganda proprio mentre l’allora amministrazione Jiang Zemin era similmente impegnata a ripulire il Partito dalle mele marce. Segno che «il confine tra le tematiche politiche e quelle popolari è diventato fluido e negoziabile», commenta Bai Ruoyun in Staging Corruption: Chinese Television and Politics. È stato davvero così fino al 2004 quando, additando la scarsa qualità, le autorità hanno bandito il settore. Con il risultato che le fiction sull’anti-corruzione sono improvvisamente scomparse dalla fascia oraria di prima serata, cedendo il posto a tematiche meno sensibili: commedie famigliari, polpettoni storici e storie di guerra intrise di nazionalismo.
Soltanto dopo l’avvento di Xi i moderni intrighi di palazzo tornano a riempire i palinsesti. Con una funzione prettamente pedagogica, s’intende: quella di «incarnare i valori socialisti in modo vivido e brillante», come sottolineato nel 2014 dal presidente in occasione di un simposio sulle arti e l’industria dell’entertainment. «In termini di stile, temi e trama, In The Name of the People non è molto diversa dalle fiction sulla corruzione realizzate dal regista Zhou Meisen prima del divieto del 2004», spiega al manifesto Bai Ruoyun, «ciò che la distingue è piuttosto il rifiuto di quel vecchio tono cupo e pessimistico con cui si soleva descrive il fenomeno». E poi naturalmente la qualità. Avvalendosi di un budget cinque volte superiore alla media di quanto speso normalmente per i film tv, Renmin de mingyi ha un cast stellare per gli standard cinesi.
Ne è passato di tempo da quando circa trent’anni fa a dominare il piccolo schermo erano prevalentemente produzioni patriottiche raffazzonate e prive di appeal. Era quella che potremmo definire la fase esplorativa dell’industria delle serie televisive (’78-’88), succeduta da un periodo di crescita (’88-’98) e maturità (dal ’98 a oggi), in cui una progressiva apertura al settore privato (2008) ha coinciso con una diversificazione delle tematiche e dei soggetti trattati. Col tempo, il focus si è spostato dalla descrizione asettica di un passato glorioso a una narrazione introspettiva dei sentimenti e delle relazioni umane. Per questo che i funzionari depravati di Renmin de mingyi sono innanzitutto vittime della loro corruttibile fragilità.
Con i suoi drammi quotidiani, la vita di tutti i giorni ha gradualmente conquistato il piccolo schermo. Complice l’arrivo di capitali da Hong Kong, Macao e Taiwan e una maggiore competizione tra i player statali e quelli privati, che oggi compongono ben l’80% del settore. «È una specie di tiro alla fune tra soggetti non governativi ed emittenti provinciali da una parte, e la CCTV (controllata dal governo centrale) dall’altra», spiega al manifesto Stanley Rosen, docente di scienze politiche presso l’Annenberg School for Communication & Journalism, nonché autore di Art, Politics and Commerce in Chinese Cinema, «le prime, godendo di una maggiore libertà, tendono ad ampliare i limiti attuali. Talvolta aggirano il controllo della censura facendosi scudo di una narrazione propagandistica corretta per arricchire le loro programmazioni di elementi sensazionalistici e talvolta violenti, soprattutto quando si parla di Seconda Guerra Mondiale e invasori giapponesi».
In barba alla propaganda, con circa 15mila episodi l’anno, oggi il mercato di film tv cinese è il più vivace al mondo.
Secondo un rapporto di MPAA per il 2016, l’industria televisiva ha contribuito all’economia nazionale per un valore pari a 35 miliardi di dollari, con i servizi free to air a fare la parte del leone (12,3 miliardi). La diffusione delle piattaforme di streaming, iQiyi, Youku, LeTV e QQ Video – determinate a raggiungere i 140 milioni di iscritti paganti entro il 2020 – non ha fatto altro che incrementare la competizione con la promozione di produzioni individuali e contenuti esclusivi attraverso l’acquisto e la vendita di diritti televisivi.
Come per i servizi internet la fioritura del mercato interno è direttamente proporzionale all’emarginazione dei competitor stranieri in un mix di motivazioni ideologiche e finalità protezionistiche. Rispolverando una circolare di quattro anni prima, nel 2016, la SAPPRF ha imposto ai canali televisivi un limite massimo di due show d’importazione estera nella fascia tra le 19:30 e le 22:30 con lo scopo conclamato di lasciar spazio «solo a programmi innovativi con geni, caratteristiche e stili culturali cinesi».
A settembre, le restrizioni sono state estese alle proiezioni online. Al contempo, la diatriba sul dispiegamento del sistema antimissile americano Thaad a Sud di Seul ha finito per squalificare le amate soap opera sudcoreane per oltre un anno. E sebbene, dopo lunghe trattative, il leader mondiale dello streaming Netflix si sia visto aprire le porte al paese – proprio attraverso una partnership obbligata con iQiyi – il servizio stenta a decollare a causa delle molte limitazioni. In compenso, secondo statistiche della SAPPRF, l’anno scorso le esportazioni oltreconfine di serie TV hanno fruttato 77,2 milioni di dollari. Oltre 1.600 film e produzioni televisive cinesi sono stati tradotti in 36 lingue diverse trasmessi in più di 100 paesi.
«Il fatto è che ormai le produzioni televisive non sono più finanziate da fondi governativi ma da compagnie di produzione private che si muovono secondo logiche di profitto», chiarisce Bai, «nonostante si trovino spesso a dover aderire alla linea ufficiale per schivare la censura non sono più esclusivamente una forma di propaganda».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento